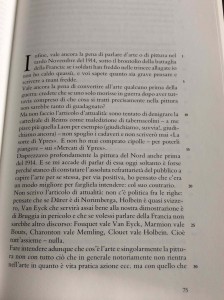«Qui la grafia prodigiosa del Bellotto, quasi un alfabeto Morse di linee, punti, tratteggi d’ogni specie e colore, svela il segreto sintattico di un trapasso all’“ottico” al “narrativo” che è quasi da leggere come certi brani del famoso Ottocento russo… La stessa precisione stregata».
Uso questa illuminante frase di Roberto Longhi (da un articolo scritto per l’Europeo nel 1965) per cercare di approcciare la grandezza di Bernardo Bellotto. L’occasione è stata la mostra alle Gallerie d’Italia chiusa domenica (con record di visitatori e coda infinita per gli ultimi giorni). Una mostra scoperta all’ultimo momento che è stata una rivelazione. Bellotto ha qualcosa che non ti aspetti, che va oltre non solo l’idea che ti eri fatto ma soprattutto oltre il posto in cui per comodità lo si colloca. Bellotto innanzitutto rompe la misura del vedutismo, perché la marcia che innesca con la serie di paesaggi di Dresda e Varsavia lo porta fuori misura. Il paesaggio, pur nella sua pacata naturalezza, prende una dimensione di vastità. S’allarga, sino ad assumere una dimensione che viene da definire monumentale. Ma dentro quel dilatarsi resta infallibile nella precisione del dettaglio: è l’ottico che si distende nel narrativo. Cioè in una grandiosità di respiro. Colpisce la predilezione per i fiumi, che assicurano prospettive in cui il paesaggio si apre e si allarga.
C’è poi il segreto tecnico della pittura di Bellotto: il paesaggio non è mai preso da un punto di vista, ma da una sequenza di punti di vista. Quindi non va mai a stringersi verso un punto focale. Per questo ci passa davanti allo sguardo in una sequenza di visioni che sono una parallela all’altra. È un paesaggio che scorre e che ci trova in ogni punto in una posizione di frontalità. Il nostro occhio è sempre in asse. Viene da fare il parallelo con le grandi di foto di Andreas Gurky che sembrano scattate con un obbiettivo il cui fuoco è identico in ogni parte dell’immagine: immagini senza un centro, perché tutto è centro.
All’interno di queste visioni, salite di scala in modo imprevisto, Bellotto si muove con una padronanza e una libertà impeccabili. C’è infatti un’esattezza nella sua pittura, che è esattezza non fredda o mentale, ma sempre vissuta e impastata di atmosfericità. Soprattutto è un’esattezza che non perde mai di vista l’insieme. Ogni dettaglio a suo modo è al centro, ma non si richiude mai su di sé. È un microcosmo sempre in collegamento con il macrocosmo che lo circonda.
Archive for the ‘Roberto Longhi’ tag
Bellotto rompe la misura. Il paesaggio come vastità
Il terremoto e la storia dell’arte
Questo articolo di Alessandro Delpriori, sindaco di Matelica e sotrico dell’arte, è uscito su Il Manifesto il 31 ottobre. Lo pubblico qui perché è la dimostra quale profonda forza civile abbia in dote la storia dell’arte.
di Alessandro Delpriori
Nel 1977 uscì il primo Manuale del Territorio della Regione Umbria, un progetto ambizioso che doveva descrivere in maniera capillare il patrimonio materiale e immateriale dell’intera Regione. Era dedicato alla Valnerina. Esattamente la porzione di Italia che in questi giorni, nuovamente, è tornato alla ribalta per il violento sciame sismico che l’ha distrutta.
Quel volume descriveva una enorme quantità di materiale allora semisconosciuto ma che solo sfogliando le pagine si intuiva essere di qualità spesso sorprendente.
Negli stessi anni Giovanni Previtali andava studiando la sua «Umbria alla sinistra del Tevere» in cui, partendo dalle aperture sulle aree minori di Roberto Longhi, sintetizzava figure critiche sconosciute come il Maestro della Santa Caterina Gualino o il Maestro della Croce di Visso. Enrico Castelnuovo e Carlo Ginzburg nella storia dell’arte Einaudi, studiando il rapporto tra centro e periferia prendevano ad esempio proprio la Valnerina come regione cerniera e laboratorio per un linguaggio artistico specifico e singolare.
C’era allora un entusiasmo particolare nello studiare le valli alle pendici del Monte Vettore, ricche di un patrimonio straordinario per quantità e, a volte, per qualità. Oggi tutto questo rischia di non esserci più. Il crollo della Basilica di San Benedetto a Norcia è il segno più eloquente di un disastro che potrebbe avere dimensioni inimmaginabili. C’è da chiedersi se saranno recuperabili le pale d’altare di quella chiesa, il Filippo Napoletano o anche il piccolo Michelangelo Carducci, pittore manierista figlio dell’esperienza romana ultimo erede di una dinastia nursina di artisti, gli Sparapane, che lavorò almeno dalla metà del Quattrocento.
Il Cristo di Giovanni Teutonico, da poco celebrato in una splendida monografia di Sara Cavatorti, conservato nella chiesa di Santa Maria Argentea, i marmi di Duquesnoy, la pala del Pomarancio, saranno mai recuperabili?
La lista potrebbe essere davvero infinita. Tutta quella zona d’Italia che da Spoleto risale lo scorrere del Nera fino alle Marche e, scavalcando il Vettore, va verso il mare seguendo la Salaria e la Flaminia è una zona sostanzialmente omogenea culturalmente, dove a partire dal XII secolo si sintetizza un linguaggio peculiare e identitario. A partire da Alberto Sotio il linearismo tutto superficiale delle pitture romaniche che sembrano discendere dalla scultura borgognona, si pone come uno dei vertici più alti dell’arte in Italia e crea una sacca di resistenza alle novità toscane, come Giunta Pisano ad Assisi, che resiste fino all’arrivo di Cimabue e Giotto nella stessa Basilica di San Francesco. Il Trecento si apre con artisti che declinano quelle novità in caratteri tutti personali e che concepiscono la spazialità e la narrazione ma che ricercano l’emozione e il dialogo espressivo con lo spettatore, tanto che si trovano enormi calvari affrescati con tonanti rappresentazioni della morte di Cristo. È anche il caso della chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia, chiesa di una poesia infinita, una doppia navata foderata di affreschi e che presentava ancora conservati tramezzi e pontile, a descrivere l’allestimento della chiesa medievale. Mercoledì sera si è sventrata totalmente.
Quando Roberto Longhi pensava al Rinascimento umbratile si riferiva in particolar modo al Quattrocento di queste valli, dove Bartolomeo di Tommaso, folignate, ma anconetano di adozione, costruiva uno stile a metà tra la bellezza di Gentile da Fabriano e le prime attrazioni della «pittura di luce». Sintomatico di tutto il XV secolo è il famoso documento del 1442, pubblicato da un ricercatore instancabile e raffinato, Romano Cordella, che descrive lo stesso pittore di Foligno a capo di una brigata, che comprendeva Nicola di Ulisse da Siena, Andrea de Litio, Lorenzo di Luca Alemanno e Giambono di Corrado, impegnata a decorare la chiesa di Sant’Agostino e che troviamo attiva anche a Santa Scolastica. È l’inizio di una storia nuova che già negli anni venti Van Marle aveva chiamato Norcia Style e che oggi rischia di essere cancellata quasi nella sua totalità. Parallelamente, nelle Marche più profonde si compiva la parabola di un pittore delicatissimo e spesso commovente, Paolo da Visso, allievo forse dello stesso Bartolomeo di Tommaso che ha decorato la collegiata del suo paese, oggi al centro di un paese in ginocchio, completamente a rischio crollo.
Negli stessi anni, dall’altra parte dell’Appennino, a Camerino, fiorisce l’esperienza straordinaria dei pittori della corte dei Da Varano, Giovanni Boccati e Giovanni Angelo d’Antonio portano dentro il cuore della Marca la cultura prospettica che avevano potuto vedere a Firenze e a Padova. Affreschi, tavole e polittici sono oggi in pericolo. Sono l’alternativa alla grandiosa civiltà del polittico di Carlo Crivelli. Allo stesso modo Luca di Paolo da Matelica e Lorenzo d’Alessandro da San Severino, nei musei e nelle chiese di quelle città testimoniano la propaggine più bella e più tarda della grandissima onda gotica che informa in un Rinascimento alternativo tutto l’Appennino.
Sarebbe da verificare lo stato della piccola e meravigliosa Madonna di Carpineto in cui un allievo camerinese di Donatello, Battista di Barnaba, ha lasciato un rilievo di terracotta che solo da poco era stato scoperto, studiato e restaurato.
Un viaggio tra le Marche e l’Umbria alla ricerca di opere d’arte può stupire anche per le presenze esterne. È una fortuna che i due Valentin de Boulogne di Santa Maria in Via a Camerino siano migrati temporaneamente al Metropolitan Museum per la stupenda mostra monografica su questo caravaggista francese, ma saranno da capire le condizioni della pala di Giacinto Gimignani nella stessa chiesa. Lo stesso vale per i due Crocifissi lignei di Benedetto da Maiano ad Ancarano di Norcia e a Todiano di Preci, due minuscoli castelli della Val Castoriana, una remotissima sottovalle del Nera che ospita in maniera inaspettata una lunga serie di opere fiorentine. Le due sculture sono in compagnia di Francesco Furini, di Giovanni del Biondo, di Francesco di Simone Ferrucci e di molte altro ancora.
Nel 1979 la terra tremò, nel 1997 lo fece di nuovo e tutto questo patrimonio fu in qualche modo riscoperto e salvato, oggi è la risorsa più grande di tutta la grande area geografica e metterlo in salvo significa non solo tutelare il passato, ma anche e soprattutto garantire un futuro.
*storico dell’arte e sindaco di Matelica, colpita dal sisma
L’opera d’arte come liberazione. Quattro situazioni da vedere (o leggere)
A maggio con Vita abbiamo fatto (grazie al lavoro di Anna Spena, in particolare, e di Marta Cereda e Daniele Capra) una copertina che lanciava la domanda “L’arte può salvare il mondo?”. In scia allo spunto di quel numero, ho intercettato molte suggestioni che meritano, secondo me, di finire in un ideale taccuino, in vista di una continuazione di quel lavoro avviato. Ecco alcune di quelle suggestioni, molto libere e assolutamente trasversali.
*************************************************************************************************
Uomini come cibo.
È geniale il tema che Luca Santiago Mora ha dato ai ragazzi del suo Atelier dell’Errore per il lavoro di quest’anno, ribaltando il tema dell’Expo, così come loro con le loro opere ribaltano qualsiasi gerarchia nella scala della produzione artistica. Come sempre negli Atelier che sono diventati tre (quello storico di Reggio, quello di Bergamo, e quello iniziato da quest’anno per gli allievi che hanno superato i 18 anni e che è stato ospitato alla Fondazione Maramotti di Reggio Emilia), soggetto unico sono gli animali. Animali fantastici, a cui i ragazzi assegnano nomi che meriterebbero un’antologia. Ma quest’anno il tema del mangiare gli uomini ha fatto scattare nella fantasia dei ragazzi una potenza inedita. A tratti davvero travolgente. La mostra apre il 18 giugno, sostenuta da Maramotti che ha sposato pienamente il progetto, in un palazzo centralissimo di Milano, in via Monte di Pietà, 23. Si tiene su cinque piani. Ho avuto la fortuna di vederla in anteprima. È assolutamente imperdibile. È la vita che torna ad occupare fisicamente la città. (nell’immagine: VendicatoreDiNotteCheDivorisceDeiCompagniDiClasseIoMiAvvicinoELoroSiAllontananoEDiconoChePuzzo)
***************************************************************************************************

I tre Crocifissi di Donatello a Padova.
A proposito della relazione tra l’arte e la vita, nessuno probabilmente nel passato aveva capito il nesso meglio di Donatello. A Padova ho potuto vedere la mostra dei tre Crocifissi: quello celebre del Santo, affiancato da quello giovanile di Santa Croce e da quello ritrovato pochi anni fa, a Santa Maria dei Servi, sempre a Padova. Ci sono immagini da questa piccola mostra che non ci si toglie più dagli occhi. La prima: il perizoma di Cristo nel Crocifisso del Santo. Un piccolo straccio di bronzo disperatamente strappato da un vento che scuote la storia. La seconda: il ventre di Cristo, contratto nello spasmo della morte. Dal punto di vista plastico un pezzo di intensità drammatica con pochi paragoni. Bronzo sottoposto a contrazioni esplosive. Un punto di scontro di forze, tra la muscolatura dell’addome e la corona delle costole che sporgono in fuori con uno strappo doloroso.
La terza immagine: è relativa all’altro Crocifisso padovano, che è in legno, e che è stato recuperato eccezionalmente nella policromia originale. La linea del muscolo della coscia e il rossore del ginocchio sono di una verosimiglianza carnale che quasi domanda una carezza. La quarta immagine: il clamoroso retro di questo stesso Crocifisso che l’allestimento lascia giustamente libero. Il corpo di Cristo è completamente nudo, e schiena e natiche sono intagliate con una delicatezza che toglie il respiro. Ma come sempre quello che spiazza è la libertà di Donatello, che affronta l’iconografia senza retorica e senza moralismi (ovvero quando il cattolicesimo non aveva il complesso culturale del corpo e della carne…)
************************
Longhi e il senso dell’opera d’arte.
Letto il libricino con le Proposte per un critica d’arte di Roberto Longhi (ed. Portatori d’acqua, con prefazione – bella – di Giorgio Agamben). A proposito della relazione tra Arte e vita, cito questo passaggio di Longhi: «È dunque il senso dell’apertura di rapporto che dà necessità alla risposta critica. Risposta che non involge soltanto il nesso tra opera e opere, ma tra opera e mondo, socialità, economia, religione, politica e quant’altro occorra. Qui è il fondo di un nuovo antiromanticismo illuminato, semantico, terebrante, analitico, empirico o quel che volete, purché non voglia svagare. L’opera d’arte è una liberazione, ma perché è una lacerazione di tessuti propri e alieni. Strappandosi non sale in cielo, resta nel mondo. Tutto perciò si può cercare in essa, purché sia l’opera ad avvertirci che bisogna andare a trovarlo, perché qualcosa ancora manca al suo pieno intendimento».
************************
Matisse e il suo maestro.
Sto leggendo L’intervista perduta di Matisse con Pierre Courthion. È un libro a cui Matisse lavorò tanto e che alla fine non volle pubblicare. Oggi esce per l’editore che lo allora lo aveva (invano) commissionato, Skira. Matisse vi racconta ad esempio il suo rapporto con Gustave Moreau, suo maestro. «Per lavorare con Moreau bisognava avere talento e temperamento per tenergli testa. Mi ha strapazzato spesso. Mi diceva: “Lei semplifica troppo la pittura”. Ma duceva anche: “Non mi presti ascolto. Quel che dico non ha importanza. Un professore non è niente. Faccia quello che vuole, questa è la cosa principale. Tutto quello che fa mi piace più di quello che fanno altri e che non sgrido”». Così fa un vero maestro…
************************
Post scriptum: Visita di Alessandro Mendini a Casa Testori per la mostra su Bonvesin. Con lui anche Fabio Novembre. Bello il riconoscimento di un grande maestro come lui alla vitalità dei giovani illustratori. «Sono più avanti di noi designer», ha detto. Bel segno di libertà intellettuale.
Maria su nuda terra. Le “natività povere” di Caravaggio
La cosiddetta “natività povera”, ovvero la rappresentazione del Natale secondo un’adesione alla lettera al racconto del Vangelo: Caravaggio dipinse due volte questo soggetto, in un arco di tempo molto ravvicinato, cioè durante il soggiorno siciliano a cavallo tra 1608 e 1609. Una delle tele rappresenta un’Adorazione dei pastori, ed è custodita al Museo Regionale di Messina. La seconda, una Natività con San Francesco e San Lorenzo, è stata purtroppo oggetto, nel 1969, di uno dei più clamorosi furti della storia. Era custodita a Palermo, all’Oratorio di San Lorenzo. Ciò che unisce le due opere è una comune committenza francescana: era una chiesa dei Cappuccini la destinazione originaria dell’opera di Messina; ed era invece tenuta da una Confraternita di San Francesco l’oratorio palermitano. Questo è un fattore chiave che spiega in buona parte l’origine dell’innovazione di Caravaggio: il santo di Assisi non solo aveva una devozione speciale per il Natale, tanto da inventare nel 1223 il primo presepe della storia (quello vivente di Greccio). Ma sperimentava una indicibile commozione davanti al racconto di quella radicale povertà in cui Gesù si trovò a nascere.
Caravaggio da lì partì per concepire queste due grandi tele, incoraggiato nelle sue scelte anche dal fatto che vescovo di Messina in quel momento era un francescano di grande prestigio e fascino, il frate minore Bernardino Secusio. E concepì così queste stupende “natività povere”. La povertà , prima ancora che dalla rappresentazione, è data dal tono così sobrio e antiretorico delle tele: la materia è scarna, e la costruzione dell’immagine, soprattutto nella tela di Messina, lascia tanto spazio “vuoto” destinato a rendere la sensazione di un ambiente nudo e privo di tutto. Anche la luce è fioca, e, a differenza degli effetti potenti a cui Caravaggio ci aveva abituato, qui non riesce a stanare dal buio tanti particolari delle figure presenti. È luce che si intrufola nella stalla, lasciandone nella semioscurità la gran parte. Ma la scelta iconografica più nuova di queste due “natività povere” è quella di dipingere Maria stesa sulla nuda terra, senza quei piccoli sotterfugi con cui in genere l’arte aveva cercato di rendere meno brutalmente reale la rappresentazione del Natale (Giotto ad esempio, a Padova, ha immaginato Maria stesa su un giaciglio). Caravaggio non fa la retorica della povertà e neanche esaspera i toni per dare maggiore radicalità alla scena. Semplicemente dà l’impressione di seguire i fatti, di adeguarsi a come verosimilmente devono essere andate le cose. Maria stesa per terra, con il braccio appoggiato alla mangiatoia, nella versione di Messina tiene tra le braccia il bambino avvolto in fasce: visto da vicino, penetrando nella penombra, si scopre che le labbra di Gesù s’appoggiano teneramente al mento di Maria, mentre la manina si allunga verso la guancia quasi volesse fare una carezza. Ed è la povertà della scena a rendere ancora più acuta e commovente questa relazione affettiva tra la madre e il figlio: come se il destino dell’uomo non avesse bisogno di nient’altro oltre a questo legame di bene. «La Madonna con il minuto bambino», scrisse il più grande studioso di Caravaggio, Roberto Longhi, «sotto lo sguardo apprensivo dei pastori quasi colati in bronzo, appare spersa su quel poco di strame pungente, entro quel chiuso di animali immobili come oggetti, di assi e di stoppie…». Il riferimento allo “strame pungente” oltre che molto poetico fissa l’attenzione su un altro elemento di questa natività: è la paglia dispersa sul terreno. Una paglia che nella sua pochezza però riflette la luce e sembra accendersi, quasi trasfgormandosi in esili filamenti d’oro: la povertà ha in sé anche qualcosa di prezioso, sembra suggerire Caravaggio. Una preziosità che si deposita nel cuore di chiunque si trovi davanti a questa tela.
L’altra Natività ha una costruzione diversa, quasi che Caravaggio, ormai giunto al capolinea della sua breve avventura umana (morì nel 1610 a 39 anni), avesse recuperato reminiscenze dei suoi anni di formazione in Lombardia. È un quadro che richiama Savoldo o Moretto, grandi artisti che nel 500 avevano preparato la strada al realismo del Merisi. Anche in questa versione Maria è seduta per terra e fissa il Bambino che è nudo sul pagliericcio. Tutta la tradizione pittorica ha sempre rappresentato questa scena disponendo Maria in ginocchio davanti al figlio nella mangiatoia: una scelta che evidentemente incoraggiava la devozione, ma che nella testa di Caravaggio non corrispondeva alla verità dei fatti. Perciò riavvolge il film e prova a immaginare una situazione così come davvero può essere stata vissuta dai protagonisti di quella notte di 2014 anni fa. Ecco allora che Maria se ne sta quasi spossata per la fatica, con la mano sul ventre, il vestito ancora un po’ scompigliato che lascia intravvedere una spalla, e lo sguardo abbassato verso quel Bambino di cui sembra aver già intravisto il destino. Non ha veli in testa, come non li avevano altre due meravigliose Madonne “popolane” che aveva dipinto a Roma, quella dei Pellegrini e quella dei Palafrenieri.
Longhi 1914. Scrivere di storia dell’arte con la Guerra alle porte
«Infine vale ancora la pena di parlare d’arte o di pittura nel tardo Novembre 1914, sotto il brontolio della battaglia della Francia: se i soldati hanno freddo nelle trincee allagate io non ho caldo quassù, e voi sapete quanto sia grave pensare e scrivere a mani fredde». Esordiva così il giovane Longhi, giusto 100 anni fa, in un saggio che rileggo aprendo quasi a caso il suo libro con gli inediti giovanili (Palazzo non finito). È un saggio da “battaglia”, contrassegnato da una magnifica spavalderia: Longhi si permette giudizi tranchant verso l’arte nordica (il gotico come “maledizione di tabernacolini”), si lancia in una crociata per obbligare a distinguere ciò che è arte da ciò che è solo boria per innovazione tecnica (la pittura ad olio dei fiamminghi, che scivolano in “calligrafa degenerazione”, in “limpidezza banale”, in “ribrezzo lucertolare”). Certamente c’è da storicizzare. È il Longhi idealista, crociano, italofilo. Ma è anche il Longhi che inizia a a mettere a fuoco l’intuizione sulla centralità di Piero (il primo saggio su Piero è proprio dello stesso anno), che capisce come lo stile non sia solo una questione stilistica ma di elaborazione e visione del mondo. Quella a cui si dedica è quella storia che parte «dalle accettate e volontarie costrizioni create per la prima volta dai grandi romanici d’Italia e sollevate a sfere di classiche da Giotto e Michelangelo». È la storia della forma contro quella della “de-forma”…
Ma più che la pars costruens in queste pagine è fantastica la pars destruens. Così linguisticamente avvincente da diventare quasi diabolicamente convincente… verrebbe quasi voglia di proprorne un’antologia…
«Contorto di gotico questo paesaggio barocchio e cartoccioso, questo paesaggio raccontativo, topografico e non cosmico»; «…angoli sgnagherati, finestre cul di bottiglie…»; «questi tiranni inebetiti di borghesi; questi ermeiti abbruttiti di noia; questi piccioni di spirito santo…»; «questa grazie di porcospino…»
I giudizi ovviamente verrano presto rivisti, e saggiamente equilibrati. Ma nella vitalità di queste pagine si vede già lo scarto grazie al quale Longhi ha fatto diventare la storia dell’arte qualcosa di umanamente appassionante. Persino per chi in quel 1914 stava in trincea
Il momento dei maestri/2. Il maestro dei Maestri del Colore
Inizia a Casa Testori una mostra assolutamente originale, come devono esserlo le cose che vengono presentate in quel luogo. 4 curatrici per 4 maestri, sono in realtà quattro mostre in altrettante zone in cui è stata divisa la Casa. Le curatrici, casualmente tutte donne, sono dottorande nelle università milanesi che hanno accettato la sfida di fare delle loro tesi dei percorsi espositivi fruibili da un pubblico largo. Il mix dei “maestri” è sorprendente: si va da Aldo Rossi (a tema il suo pensiero sull’abitare, a cura di Claudia Tinazzi), a Giacomo Pozzi Bellini (fotografo trasversale di una stupenda Italia, da Giovanni Pisano a Sofia Loren, a cura di Carlotta Crosera), a Guido Guidi (fotografo con una dedizione quasi religiosa nei confronti di Carlo Scarpa, a cura di Giulia Lambertini). La quarta mostra è forse la più inattesa: è dedicata ad Alberto Martini, a cura di Federica Nurchis, il geniale inventore dei Maestri del Colore, la collana di Fabbri che negli anni 60 ebbe un successo clamoroso ed ebbe un ruolo fondamentale nell’alfabetizzazione artistica dell’Italia. È bellissimo scoprire come alle spalle di Martini e del suo tentativo ardito (c’era da fotografare tutto a colori, migliaia di immagini da scattare in ogni angolo del mondo) ci fosse Roberto Longhi. Era stato lui a incoraggiarlo e a fare da garante rispetto all’editore: segno di quanto fosse urgente per lui la necessità di fare buona e larga divulgazione. Longhi è stato un grande storico anche per questo suo sguardo sempre aperto sul presente (leggasi le pagine finali dell’introduzione alla mostra di Caravaggio). Divulgazione è cosa diversa da pedagogia: non è un inculcare ma è un mettere a disposizione strumenti. E i Maestri del colore, con il loro formato grande (35,5 x 27 cm) che ne faceva una sorta di pinacoteca casalinga, la loro architettura chiarissima, i testi di qualità, e soprattutto – come Longhi aveva chiesto – le foto a colori (colori che nella stragrande maggioranza dei casi non si erano mai visti), sono un modello straordinario di strumento messo a disposizione di tutti. Non perdetevi questa mostra e le sue tre “sorelle”!
Antonello contro Antonello
Antonello contro Antonello. A distanza di appena sette anni, una delle star del nostro 1400 torna protagonista di una grande mostra. Una prossimità cronologica che certo incuriosisce, visto che per rintracciare un’altra rassegna dedicata al genio messinese bisogna risalire al 1953, anno della leggendaria esposizione allestita a Messina da Carlo Scarpa. Ma la mostra di Roma 2006 e questa che si apre il 5 ottobre al Mart di Rovereto non sono soltanto molto diverse per impostazione. È profondamente diverso, soprattutto, l’Antonello che ne esce.
Basta mettere a paragone gli elenchi delle opere esposte per rendersene conto. A Roma Antonello era presenza assolutamente egemone, al Mart invece Antonello dialoga con tante figure rappresentative dei suoi anni, compresi grandi come Van Eyck, Jean Fouquet. A Roma era prevalsa l’idea dell’artista che nasce da se stesso, genio e quindi un po’ feticcio; la nuova mostra invece rilancia l’immagine di un artista nato dentro un crogiuolo straordinario di relazioni, che vanno dalla pittura fiamminga, passando per gli influssi valenciani e borgognoni sino all’incontro con la rivoluzionaria visione introdotta da Piero della Francesca. È l’Antonello nato dalle intuizioni e dagli studi del più grande storico dell’arte del 900, Roberto Longhi: cioè l’artista che meglio sintetizza la civiltà della circolazione mediterranea.
In occasione della mostra di Roma questa interpretazione longhiana era stata accantonata, suscitando perplessità e anche qualche stroncatura furiosa; al Mart invece la si rilancia, supportata da nuovi studi. Non a caso come curatore è arrivato Ferdinando Bologna, grande storico dell’arte, che era stato collaboratore di Longhi e che ha accettato la sfida con entusiasmo ed energia, a dispetto dei suoi 88 anni. Insieme a lui, a firmare la mostra, c’è un altro studioso di cultura longhiana, ma di un paio di generazioni più giovane, Federico De Melis. In catalogo (Electa), anziché il consueto saggio, ci sarà una sua lunga intervista a Ferdinando Bologna. Il titolo è molto indicativo: “Antonello e gli altri”
«Antonello è un pittore congiunturale», sottolinea De Melis. «Per questo il percorso della mostra si annuncia multistrato, ricco di incroci, con tante opere che vogliono documentare puntualmente tutti gli scambi da cui Antonello ha tratto linfa per dar vita alla sua meravigliosa poetica». Si approfondiscono i contatti determinanti degli inizi palermitani, città di cultura internazionale, come dimostra lo straordinario Trionfo della Morte oggi a Palazzo Abatellis; si scoprono le correlazioni con un grande artista mediterraneo come il Maestro di San Giovanni da Capestrano, presente in mostra con uno straordinario Sant’Antonio. Non manca naturalmente un riferimento a Piero, vera pietra angolare della visione longhiana, evocato da un Ritratto di Alfonso d’Aragona (dal Musée Jacquemart-André di Parigi), probabile replica di un originale perduto del genio di Borgo Sansepolcro: proprio a Napoli, secondo Fedrinando Bologna, potrebbe esserci stato l’incontro tra lui e Antonello.
La storia dell’arte e il tacco di Dolce e Gabbana
Tra i quesiti proposti nel recente sondaggio del Fai per le Primarie della cultura, c’era anche l’idea di investire nell’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole. Inutile dire che la cosa mi trova d’accordo, per motivi non solo sciovinistici, anche se la proposta non ha trovato consensi massicci come altre, certamente più scontate. La Storia dell’arte è una sorta di dio minore nei programmi scolastici: scelta vagamente suicida di una scuola plasmata da Croce e Gentile e quindi orientata sull’asse filosofia-letteratura. Ma come diceva Longhi, la lingua italiana conosciuta in tutto il mondo non è quella letteraria bensì quella figurativa. Non conoscerla e non farla conoscere è quindi un atto autolesionistico. Ne va della consapevolezza di chi siamo e ne va anche quanto ad opportunità di lavoro, di investimento rispetto ad un patrimonio e quindi ultimamente anche di lavoro.
Ma c’è dell’altro, e qui vengo alla parte eterodossa del mio ragionamento. La Storia dell’arte ha come componenti costitutive, conoscenza della storia, conoscenza delle forme, conoscenza della storia materiale (l’arte, per quanto sublime, ultimamente è sempre un manufatto): cioè è la disciplina sintetica per eccellenza di quell’uomo artigiano che secondo Richard Sennett sarà il vero motore del terzo millennio.
A questo proposito segnalo una bella intervista che Gian Antonio Stella ha realizzato per Sette a Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Dice Dolce, per spiegare cos’è davvero la macchina della moda: «Manca qualcuno che si interessi. Che studi. Che capisca cos’è il nostro settore. La considerano una cosa effimera e invece è il contrario. È un patrimonio enorme, tutto italiano, tutto nostro. Che si appoggia sugli artigiani, sulla manualità. Parli di moda e ti guardano come se parlassi di una cosa evanescente… Non capiscono che per esempio il tacco di una scarpa da donna è un capolavoro di ingegneria: chi porta quella scarpa deve stare in equilibrio perfetto. Non ha idea di quanto studio ci siano dietro particolari come questi ai quali non viene dato peso».
Ecco io penso che lo studio della Storia dell’arte non sia ben di più che un laboratorio di futuri specialisti dei beni culturali (che sarebbe già una cosa salutare, vista la quantità di beni che abbiamo la fortuna di avere), ma sia un modo per alimentare a 360 gradi questa vocazione alla bellezza (sfogliate l’ultimo catalogo primavera estate Dolce e Gabbana e capirete che non è un discorso retorico).
Ps: mi ha colpito che anche Anna Coliva, festeggiando la riapertura della Hertziana di Roma ha sottolineato questa trasversalità (seppur con amarezza): «..la perizia del genio italiano si riscontra nell’abilità raggiunta nella tecnica del trasporto delle opere d’arte, forse l’unico campo in cui manteniamo primato mondiale indiscusso».
Fare mostre in tempo di crisi
È stato utile lo scambio di vedute promosso dall’assessorato alla Cultura di Milano di Stefano Boeri sull’organizzazione delle mostre in tempo di crisi. Il “modello Bramantino”, mostra a budget basso, con ridotto spostamento di opere, ingresso gratuito e quindi grandissima fruizione da parte del pubblico ha rappresentato una novità che meritava di essere approfondita insieme a tutti gli operatori, in particolare quelli privati. Per la cronaca rimando ai tweet di Giulia Zanichelli (@giuzan, 19 ottobre)). C’è un punto sollevato da Enrica Pagella, direttrice di Palazzo Madama a Torino, che mi sembra “il punto” oggi da affrontare: cioè quello del pubblico. Ha detto Pagella che c’ è un «dovere imperativo di incontrare la domanda del pubblico», che non vuole dire assecondarla «ma farsi attraversare dalla domanda». Bellissima indicazione, soprattuttto perché viene da un funzionario pubblico che potrebbe starsene al riparo (non è un caso che Pagella sia stata nominata direttore dell’anno 2012). Farsi attraversare vuol dire indagarla, conoscerla e saperla interpretare provando a fornire così delle risposte che rappresentino anche un salto di qualità rispetto alla domanda stessa. Mi sembra una formula molto chiara e coraggiosa, che costringe ad uscire dall’angolo “sicuro” dello specialismo, obbliga a immaginare soluzioni nuove e coraggiose che stimolino il pubblcio ad un percorso di crescita e consapevolezza. I numeri del sistema torinese dicono che il coraggio viene ampiamente premiato
Ci si può chiedere in che senso la mostra di Bramantino abbia seguito questa logica. A me pare che un elemento vincente sia stato quello di aver saputo incrociare un artista di mezzo millennio fa con una sensibilità e uno sguardo contemporanei. Cioè di aver fatto un grande sforzo per far salire interesse e curiosità verso un autore che poteva essere soprattutto materia per specialisti, facendo leva su alcuni fattori che erano costitutivi della sua identità artistica, in primis la straordinaria bizzarria iconografica ben sintetizzata dall’immagine del manifesto con il rospo/demonio di scorcio a pancia in su. La stessa piena visibilità restituita agli arazzi nella Sala della Balla andava nella direzione di risucchiare lo sguardo dei visitatori verso la miriadi di particolari fantastici e fuori da ogni canone (la donna con il burka nella misteriosa scena che rappresenta il mese di febbraio è un po’ l’emblema), e quindi di far salire interesse e fascinazione per Bramantino.
Cosa significa questo? Che forse bisogna avere il coraggio e l’energia intellettuale per trovare, concependo mostre su artisti del passato (ma non solo quelle), un punto di incrocio con l’oggi. Il che non vuol dire trovare scorciatoie che accostino opere antiche con opere moderne… Ricorderò sempre come nell’introduzione al Caravaggio 1951 fosse questa la tensione sottesa al lavoro di Roberto Longhi. Tant’è che la sua lettura di Caravaggio insisteva poprio su questa capacità di riportare tutto al suo “oggi” (sottolineato con i corsivi nel testo…). Poi era stato quasi automatico, data la grandezza del personaggio, che l’oggi di Caravaggio si riversasse a piene mani sull’“oggi” di chi si metteva in coda a vedere quella mostra.
Un libro che raccomando: il Barocco di Montanari
«Il vero barocco di Roma è invece tutto in quella soluta felicità di una forma civile ed antica che, evocata dal canone classico, ora però si vede vibrare come attraverso un velo d’aria infiammata; come se il travertino scottasse gonfiando sotto lo scirocco romanesco». È facile riconoscere in queste righe la grande prosa di Roberto Longhi capace di aderire come un guanto all’oggetto di cui sta parlando (in questo caso è la Fontana dei Fiumi di Bernini in Piazza Navona). Ho trovato la citazione nel libro bello e utile di Tomaso Montanari sul Barocco, uscito nella Piccola storia dell’arte Einaudi. È un libro che consiglio perché capace di uno sguardo complessivo, sintetico e chiaro. Uno sguardo che giustamente non nasconde la propria meraviglia di fronte a quella stupefacente stagione della nostra storia culturale. In particolare il libro di Montanari risuona alla fine come un inno ragionato e insieme innamorato della Roma che va dagli affreschi della Galleria Farnese dei Carracci (1599/1600, in contemporanea Caravaggio era alla Cappella Contarelli…) sino alla volta del Gesù del Baciccio (1576/79). In mezzo, sotto la regia dei papi (è un libro giustamente molto “papalino”), ci sta l’eccezionale cavalcata di Bernini e di Borromini; e c’è la geniale e decisiva interferenza di Rubens. Montanari individua una data come momento di innesco di quel processo che portò ad una vera trasfigurazione di Roma: il 6 agosto 1623, quando il cardinale Maffeo Barberini venne eletto Papa, e diventa Urbano VIII. È lui ad avere una di quelle idee semplici che comportano però un salto di qualità nella storia di una città: si “inventa” il Bernini architetto e urbanista. In sostanza è lui a consegnare le chiavi del rinnovamento urbanistico di Roma a colui che sino ad allora era stato solo un grandissimo scultore. Ma più che di un rinnovamento urbanistico si trattò di un vero rinnovamento dell’immaginario della città, trasformata in uno scenario fantasmagorico, completamente immerso nelle dimensioni del mondo (quini nei sensi) ma insieme lievitante verso una dimensione superiore.
Montanari riconosce la genialità della strategia papalina innescata da Urbano VIII e perseguita con modalità diverse dai suoi successori. Ed è sinteticamente significativa la contrapposizione finale con quanto invece accadde con il “cambio della guardia” tra Roma e Parigi. Luigi XIV com’è noto pretese di avere il grande Bernini al proprio servizio. Un fatto che tutta l’Europa aveva seguito quasi aspettando qualcosa di epocale e inaudito. Invece il rapporto fallì clamorosamente. E la ragione la si capisce nel rapporto che uno scrittore inviò a Cosimo III di Toscana descrivendo la reggia che Luigi XIV si era fatto costruire, saltando Bernini. Versailles, scrive Lorenzo Magalotti, non lascerà particolari vestigia di sé. La cosa nuova è che «di dentro ogni cosa ride». In sostanza quello che a Roma era grande scena pubblica, era creazione aperta allo sguardo di tutti, a Parigi diventa scena di corte, chiusa, che taglia fuori dal mondo. Un cambio sostanziale, che ancora una volta ci fa capire quant’è stato grande il paese in cui viviamo. Non solo dal punto di vista artistico, ma anche da quello civile. Come appunto Longhi scriveva (da parte sua Francis Haskell individuò nella “grande cultura e tolleranza dei mecenati italiani” la causa originante di quella straordinaria stagione).