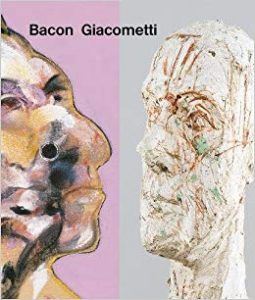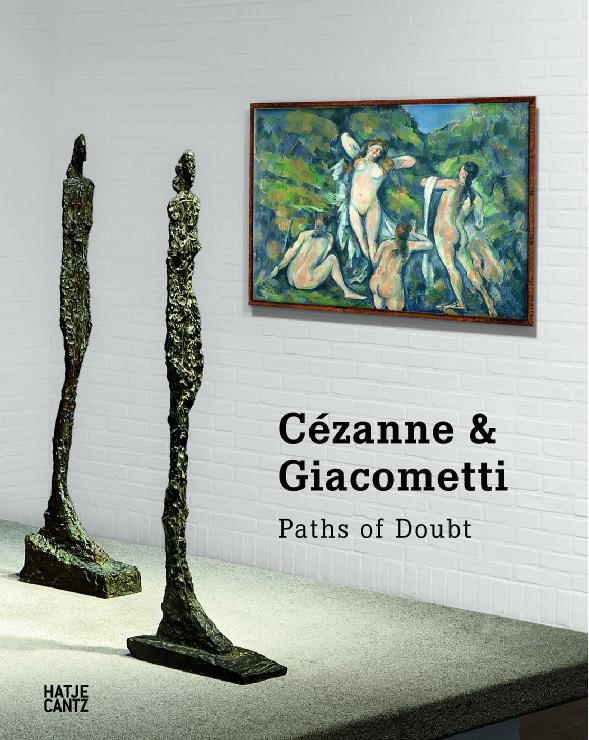«Giacometti iniziò a disegnare il mio volto con la matita su un foglio di giornale. Mi guardava in maniera talmente profonda che sembrava mi penetrasse, ma era una sensazione diversa da quella che si prova quando si viene fissati, era come se mi accarezzasse con gli occhi». In realtà più che di una carezza si era trattato di un vero colpo d’artigli. «Voglio fare il tuo ritratto», disse subito dopo Giacometti a Isaku Yanaihara, filosofo e poeta giapponese in missione a Parigi con una borsa di studio per approfondire la conoscenza dell’esistenzialismo. Erano seduti al tavolino di uno di bar di Montparnasse.
Yanaihara era agli sgoccioli della sua permanenza in Europa: aveva un biglietto aereo per il ritorno di lì a pochi giorni, il 10 ottobre 1956. Non poteva immaginare quello che invece lo aspettava: oltre due mesi di sedute, con la conseguenza di continui rinvii della partenza per accondiscendere a Giacometti e a quella sua ansia estenuante. Perché proprio Isaku Yanaihara? Perché far da modelli all’artista svizzero bisognava avere doti speciali di ascetismo zen e di pazienza. Per anni aveva “macinato” con pose infinite prima la madre Annetta, poi il fratello Diego e la moglie Annette. Ora gli era capitato a tiro questo giapponese dai lineamenti assiri, che sembrava non avere un muscolo nel volto; così aveva messo in atto tutte le armi per non farselo scappare. «Per me il tuo naso è già una piramide. Il tuo volto è già una sfinge», gli aveva confidato durante una delle tante lunghissime pose. Yanaihara riuscì a partire solo due mesi e mezzo dopo, ma con la promessa di ritornare appena possibile. Tornò infatti nelle estati successive, fino al 1961: alla fine sono state conteggiate circa 200 giornate di posa, che hanno fruttato 21 quadri e due sculture. Yanaihara finite le sedute, aveva preso l’abitudine di stendere un diario su cui annotare in particolare le cose che Giacometti diceva: frasi che sono il sismografo di un autore sommamente inquieto, sempre inappagato dal proprio lavoro, che tante volte veniva distrutto a fine giornata per la disperazione del povero modello. Questo diario, sistemato in una narrazione che a volte procede sin troppo libera, è diventato un libro uscito in Giappone nel 1969 e oggi opportunamente pubblicato in Italia da Giometti & Antonelli, con la traduzione di Isabella Dionisio (220 pagine, 26 euro).
Nei suoi aspetti più collaterali il libro è uno spaccato concreto della quotidianità di un artista che lavorava e viveva con la moglie Annette nello spazio angusto del leggendario studio di Rue Hippolyte-Maindron, una via così secondaria, da esser spesso fuori dai radar dei taxisti parigini. Non c’era acqua corrente e non c’era cucina, per cui la coppia non mangiava mai a casa. La lampadina che pendeva dal soffitto faceva una luce flebile così quando le pose si prolungavano nella notte, il ricordo di Yanaihara è quello di Giacometti che lavorava nel semibuio, mentre dalla stanza affianco arrivano le note dei dischi che Annette amava ascoltare aspettando che la seduta finisse. A volte capitava che fosse Annette a fargli notare che stava lavorando quasi completamente al buio. E in quei casi poteva ricevere risposte sibilline come queste: «Yanaihara lo vedo benissimo, quello che non vedo è il modo in cui riuscire a rappresentarlo. Eppure lo vedo così bene».
Non era semplice posare per Giacometti anche per un personaggio di calma glaciale come il filosofo giapponese. Il senso del fallimento incombeva su ogni istante. A volte erano vere esplosioni di rabbia contro se stesso, perché troppo lontano dal risultato atteso. «Dipingere un quadro è un po’ come partecipare a una guerra. Esattamente la stessa cosa, io stesso ne ho paura», diceva. Non c’è guerra se non c’è il nemico, e il nemico era il volto di Yanaihara. Sosteneva che quel volto lo terrorizzava, tanto da provare paura ad avvicinarlo: «La punta del naso è come una lama di un rasoio, fa paura. Non ho il coraggio di toccarla». «Oh, Yanaihara, profeta della mia disperazione e della mia miseria», si legge sulla pagina di diario del 15 ottobre.
Tante volte il discorso di Giacometti cade su Cézanne, con il precedente delle 120 sedute per il ritratto di Vollard. Sull’inserto letterario del “Figaro” era stato pubblicato un brano del diario inedito di Maurice Denis, dove era riportato anche un dialogo con il vecchio maestro post impressionista. «Le sensazioni sono importanti quanto le teorie. Ho tentato in tutti i modi di rappresentare la natura, ma alla fine no ci sono riuscito», erano le parole di Cézanne, che come un punteruolo producevano pensieri ossessivi nella testa di Giacometti. «Bisogna trovare un sistema di regole da seguire per rappresentare la realtà in maniera corretta. Qualcosa del genere deve per forza esistere. Gli egizi, per esempio, ci erano arrivati. Cézanne lo ha cercato per tutta la via. I pittori contemporanei ormai non lo cercano neanche più».
Nelle pause delle lunghe sedute di posa Giacometti si infilava in qualche bar o ristorante. Un giorno sedendosi al tavolino di “Aux Tamaris”. «un locale senza pretese», si era trovato davanti uno specchio ancora segnato dai fori degli scontri a fuoco tra nazisti e rappresentanti della Resistenza. È un’immagine che gli fa ricordare Francis Gruber un pittore, a cui era molto legato e di cui aveva grande stima, che aveva preso parte a quei combattimenti. «Guardando le spaccature dello specchio Giacometti parlò con grande commozione del lavoro e della vita di Gruber», scrive Yanaihara. Non riferisce cosa disse, ma basta questa semplice notazione di passaggio per evocare la sensazione di concordanze profonde.
Ogni tanto nello studio arrivava Jean Genet, l’unico che poteva permettersi di interrompere il lavoro di Giacometti. «Un vero mostro di seduzione», annota Yanaihara. «Si metteva di fianco a me, che non gli davo neanche la mano per evitare di muovermi e mi fissava dicendo: “Quanto zelo!”». Nel suo meraviglioso libro “L’atelier di Giacometti”, Genet riporta le sue impressioni su quelle visite: «Durante tutto il tempo in cui lottò con il viso di quel giapponese davanti a me vedevo lo spettacolo di un uomo che non commetteva nessun errore, ma che stava perdendo se stesso».
All’ansia di non riuscire ad agguantare il ritratto si aggiungeva anche quella di non poter disporre del modello a tempo indeterminato: Giacometti aveva sempre davanti la scadenza del nuovo biglietto aereo di Yanaihara che si avvicinava. Pur di trattenere l’amico giapponese e di convincerlo a nuovi rinvii, non esitò a favorire una sua relazione con la stessa Annette. Era stata la stessa Annette a prendere spavaldamente l’iniziativa facendosi invitare da Yanaihara nel suo albergo. «In breve si tolse di dosso tutti i vestiti che aveva e venne sul mio letto», racconta. Il giorno dopo, tornando a posare, il giapponese era preoccupato delle reazioni che l’artista avrebbe potuto avere. Ma Giacometti, che evidentemente sapeva tutto, sgombrò subito il campo: «La gelosia è ciò che odio di più e in me non ce n’è neanche un briciolo. Amare Annette significa rispettare la sua libertà, non sei d’accordo? Annette è sempre stata una donna molto libera ed è per questo che la amo». In sostanza l’artista aveva architettato un gioco a tre, con lui in posizione del tutto platonica ma certo di poter contare su quel modello, che sentiva lo avrebbe portato vicino ai volti agognati della ritrattistica di El Fayum. «Quello che c’è tra noi tre trascende la comprensione del mondo», concludeva Giacometti con un’enfasi un po’ sospetta… Con più sincerità in un’altra occasione aveva confessato il suo vero sentimento: «Come sarebbe bello poter dipingere il tuo volto come sto facendo ora, ma per tutta la vita, senza mai smettere». Il sogno di “un portrait sans fin”…
Pubblicato su Alias, il 20 febbraio 2020