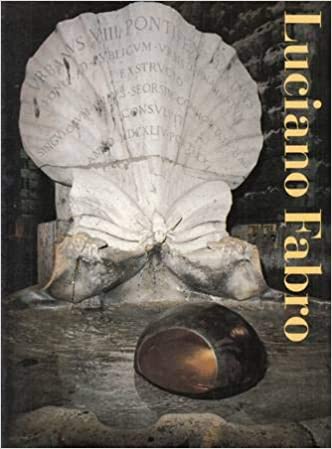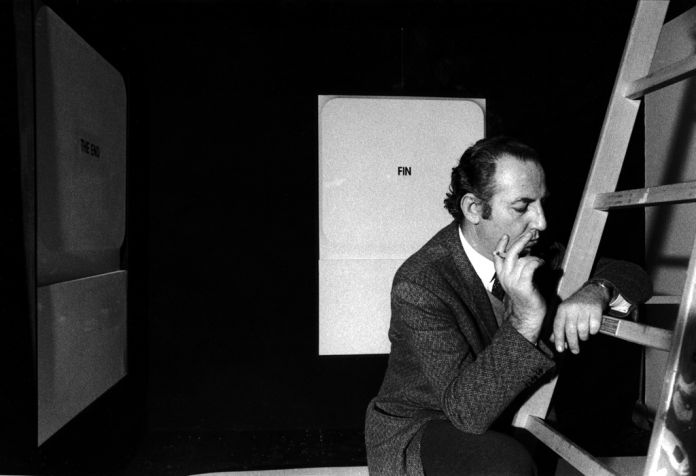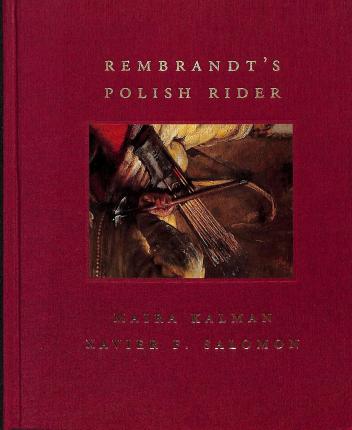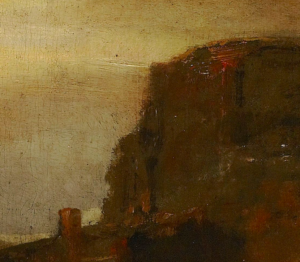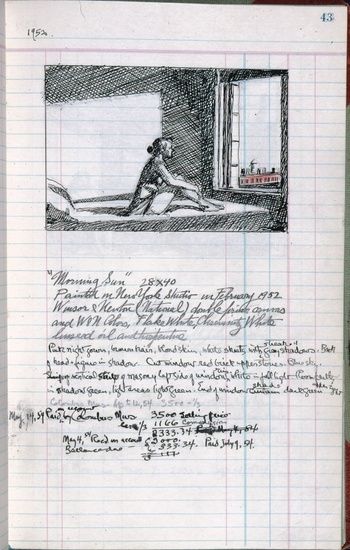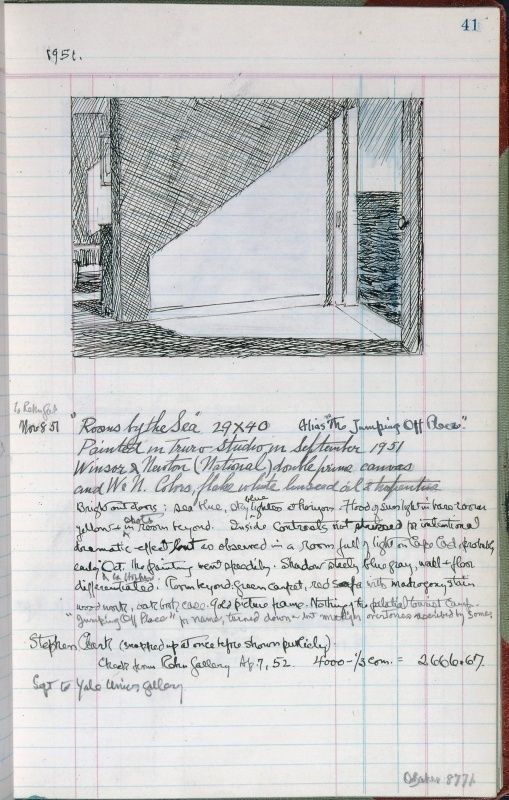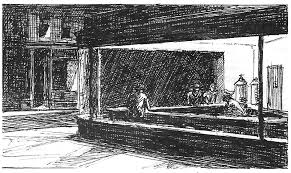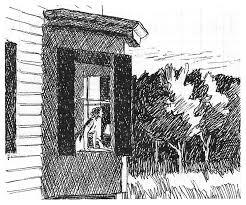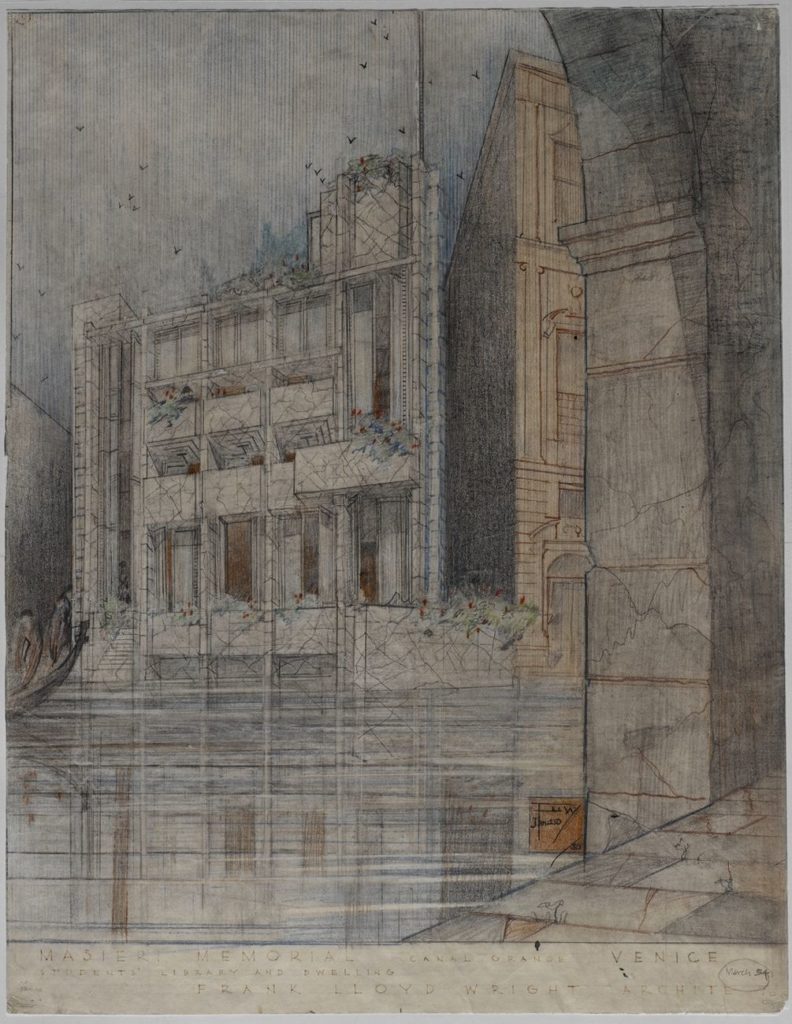«A me piace scrivere, quasi più che fare mostre». Paradossale che lo dica uno dei più importanti galleristi italiani, con oltre quaranta anni di successi alle spalle, presenza fissa al gotha di Art Basel, stimatissimo da tanti artisti star e inarrivabili. Massimo Minini è fatto così, è autorevole e corsaro nello stesso tempo. Per tutta la vita non si è certo negato la passione per la scrittura, che ha coltivato come esercizio complementare e necessario all’attività di gallerista.
Lo testimoniano le dimensioni del libro in cui ha voluto raccogliere, con un andamento creativo e imprevedibile, il meglio di quello che negli anni ha messo su carta. Il volume, edito da Silvana, non solo sfonda le 400 pagine, ma si presenta in formato atlante. Eppure dà un’impressione immediata di leggerezza, grazie anche all’impianto grafico firmato da Nicola Chemotti. Grande merito anche delle sovraccopertine che Minini ha chiesto a un artista amico della prima ora, presenza storica nella sua galleria, Daniel Buren. Si può scegliere il colore delle bande verticali, tra verde, rosa, arancio e azzurro, tutti di una tonalità affabile. La sovraccopertina è un’opera, con tanto di titolo, “Inchiostri per Massimo in 4 colori” e aprendosi a manifesto svela una delle verità di Minini: «Dire che siamo in un momento di grandi cambiamenti è un’ovvietà. Probabilmente anche una banalità. Siamo sempre stati, anzi siamo sempre in un momento di cambiamento. Quando mai la storia è stata ferma!».
Il libro è immune da banalità e ovvietà. Basta scorrere l’indice per rendersene conto. I materiali infatti sono raccolti in blocchi molto logici, ma i titoli e i sottotitoli dei singoli capitoli fanno schizzare l’attenzione e la curiosità del lettore, a iniziare dal primo, Autointervista. Dove l’autore finge domande cattive per darsi modo di rispondere. Tra le domande c’è quella rituale che riguarda la scelta di non lasciare mai Brescia, di restare come lui dice, «gallerista di provincia». La risposta è ragionevole e non priva d’orgoglio: «Primo, perché Brescia è una città importante (è la terza potenza economica d’Italia, dopo Milano e Torino), e poi perché qui ho avuto buoni maestri (Cavellini, Politi)». Achille Cavellini è un mitico collezionista. Giancarlo Politi è invece il fondatore di Flash Art, la rivista presso cui Minini, avvocato mancato, ha fatto un attivissimo apprendistato al mondo dell’arte. La rottura con Politi è uno dei tormentoni che torna tante volte nel libro, con accento divertito ed epico nello stesso tempo: infatti, una volta licenziato, Minini aveva aperto subito una galleria, Banco. Era il 1973: Cavellini, pur perplesso, gli era stato di sostegno a fare quel passo. Sulla scena locale sono subito scintille e anche qualche goliardata. Quando Ennio Morlotti era arrivato a Brescia per una mostra in Pinacoteca, lui con Sarenco, «persona di grande e pericolosa intelligenza», si presentarono buttando volantini polemici: «Ricordo che Morlotti scosse la testa senza dire niente».
Chi pensa a un Minini oltranzista sulla sponda dell’antipittura si sbaglia di grosso. «La Pittura (proprio così, con la P maiuscola, ndr), una vecchia zia…è un’esigenza insopprimibile, un vizio assurdo: salta fuori quando meno te l’aspetti», scrive. Nel capitolo, a tratti quasi esilarante, che raccoglie i contenziosi e anche imprevisti sussulti di simpatia con Vittorio Sgarbi, però mette in chiaro alcune cose. Secondo lui troppe volte la pittura si costringe a una figurazione dolente, sangue e budella. In questo modo si preclude «la libertà di ricerca…». E conclude con una fiondata: «La figura vissuta come rivincita è un vecchio modo di porsi… è lingua morta».
Lingua viva, supremamente viva, per lui è quella di Giulio Paolini e di Salvo, i due artisti che hanno cambiato il suo modo di guardare. Al primo dedica tutto un capitolo, apodittico fin dal titolo Giulio Paolini. Lui. Spiega che “lui” gli ha insegnato «la bellezza, la pratica dell’understatement, il bisogno di rarefare, che ahimè, ho disatteso». Di “lui” stima tutto, a partire da quella sua attitudine a «sottrarsi non tanto all’arte, quanto alla nostra curiosità». Con “lui” in quaranta anni di amicizia si è stabilito un rapporto di “CON SONANZE”, scritto proprio a caratteri maiuscoli. Salvo invece è la proiezione dell’autodidatta colto, «dell’artista che torna all’ordine dopo il disordine». Aveva visto una sua opera, Benedizione, in una galleria di Brescia e altre da Sperone, tutte opere dal linguaggio fortemente alternativo. «Ma un giorno», racconta Minini, «vediamo apparire dei dipinti enormi: che fosse impazzito? Allora (siamo nel 1973), dipingere era proibito». Risultato: nel 1975 allestisce la prima mostra di Salvo in galleria.
C’è solo un artista che nelle pagine del libro ricorre con maggior frequenza rispetto a questi due prediletti ed è inaspettatamente un artista di un’epoca lontana: il Romanino. La ragione è elementare: Minini è nato a Pisogne, dove il padre aveva un’aziendina, e quindi ha sempre considerato Romanino alla stregua di un vicino di casa per via del meraviglioso ciclo di affreschi della Madonna della Neve, che così spesso si trovava a frequentare. Lo sguardo di Minini verso le creature sgraziate, vernacolari, trasgressive dell’artista bresciano è uno sguardo innamorato. È frutto di una dichiarata e smaccatissima simpatia, che però non gli impedisce di tracciare parallelismi con il contemporaneo: ecco allora che Romanino diventa il profeta della bad painting, lo sperimentatore eretico che spezza i ponti con il linguaggio dominante, che dipinge quasi in una sorta di «trance visiva», l’artista che come tanti grandi del Novecento, da Bacon a Fontana, «fa uno scarto laterale che spiazza il pubblico, offre qualcosa di inatteso che apre su altre direzioni».
È su Romanino inoltre che matura un’imprevista convergenza con Giovanni Testori, un critico che per quanto concerneva il contemporaneo stava radicalmente su un’altra sponda. Testorie e altre storie è il titolo, creativo come sempre, che ripropone gli atti di questa strana relazione. Se la brescianità e Romanino sono un punto saldissimo di contatto, gli articoli sul “Corriere della Sera” a ponte tra anni Settanta e Ottanta, rappresentano invece l’oggetto di un conflitto senza possibilità di composizione. Testori è da una parte «il Polifemo accecato d’ira contro le avanguardie», ma allo stesso tempo lo studioso che ha sdoganato il grande Romanino, rivendicando davanti alla grande critica, la modernità della sua bad painting, una pittura che opponeva alla lingua ufficiale la forza deflagrante di un dialetto figurativo. Minini per rendergli un omaggio si inventa l’idea di un “processo a Testori”, idea lanciata pubblicamente dalle colonne delle pagine bresciane del Corriere della Sera. La sfida viene raccolta nel luglio 2013: il processo si consuma a Novate, proprio in quella che era stata la casa dell’imputato. La lunga requisitoria è tutta all’insegna di «un’ammirata avversione» e di una non celata simpatia.
Per Minini scrivere è scopertamente un piacere. La carta bianca è il territorio sul quale può dar fuoco alle polveri della sua natura estroversa e fuori dagli schemi, come nel caso celebre dei suoi “pizzini”, testi brevi e ficcanti, ora approdati in una rubrica nelle pagine che mensilmente Il Foglio dedica all’arte. La scrittura non è però un punto di fuga dalla sua attività di gallerista, perché in tante occasioni avviene una convergenza. È il caso dei comunicati stampa, che scrive di suo pugno e ai quali ha dedicato un capitolo in ogni senso esemplare. Il presupposto è che i comunicati così come sono impostati quando piovono sui tavoli delle redazioni sono materia inerte, vengono saltato a piè pari. Minini elargisce alcune raccomandazioni, ma quando le mette in atto supera le sue stesse intenzioni. I comunicati stampa sono dei piccoli gioielli inattesi, tutti da leggere in particolare per i loro incipit. «Le opere d’arte non si possono spiegare a parole», scrive nella prima riga del comunicato per una mostra di Landon Metz. «Come dire? A Vanessa voglio un gran bene. Potrei anche terminare qui il comunicato», è il lancio di una mostra di Vanessa Beecroft nel 2017. Seguono belle parole e non scontate, che ribadiscono l’affetto per l’artista e il suo lavoro. Il finale non è da meno, quanto a schiettezza: «Scritto a Brescia, città dalle mille sorprese, come la Galleria Massimo Minini». Letto questo libro, c’è davvero da credergli.
Pubblicato su Domani, 27 marzo 2022