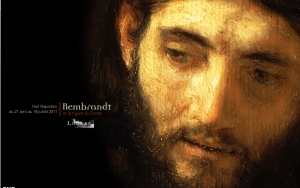Ne ha fatta di strada questo Cavaliere polacco, tra paesi e continenti, ma anche tanta strada nell’immaginario delle persone che ne sono rimaste stregate. Il Cavaliere polacco è un capolavoro di Rembrandt, dipinto intorno 1655, poco prima che la vita del grande artista venisse travolta dalla bancarotta. Dal dicembre 1935, cioè dal giorno della sua apertura al pubblico, il quadro è esposto alla Frick Collection di New York. La stessa Frick ha da poco pubblicato un libro, che è un piccolo e agile gioiello, affidato alla scrittura lucida e tenace di Xavier F. Salomon, curatore capo della collezione stessa. È un’iniziativa editoriale molto interessante (questo è il quarto volume della serie): al testo di Salomon, viene premessa una graphic novel di Maira Kalman che introduce il lettore a Rembrandt e al mistero delle sue connessioni polacche. Un modo intelligente di narrare, secondo due chiavi complementari, un capolavoro delle raccolte, aprendosi non banalmente a linguaggi contemporanei (“Rembrandt’s Polish Rider”, The Frick Collection, 82 pagine, 19,95 dollari).
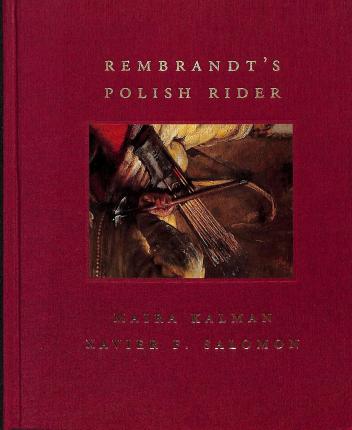
I primi passi del Cavaliere sono nel buio: il quadro infatti emerge dal nulla circa 136 anni dopo che era stato dipinto. Nell’agosto 1791 Michal Kazimirz Oginski, politico e generale polacco, ma anche collezionista, annuncia dall’Aja al re di Polonia, Stanislaw August, di avere tra le mani un quadro speciale di Rembrandt. Il re, salito al trono nel 1764, era molto sensibile all’arte: era stato lui a chiamare a Varsavia Bernardo Bellotto nel 1767, per l’ultima lunga stagione della sua vita artistica (morì in Polonia nel 1780). Il re amava in particolare i quadri con i cavalli, quindi questo insolito Rembrandt andava a pennello. Oginski, evidentemente eccitato per il colpo, si rivolge al re con un messaggio quasi sbarazzino: «Questo cavallo durante il soggiorno ha mangiato con me per 420 fiorini. La giustizia e la generosità di sua Maestà mi permette di sperare che gli alberi di arancio fioriranno nella stessa proporzione». In altre parole, Oginski aveva già comperato il quadro, certo dell’interesse del re, e avanzava la sua richiesta: avere le piante di arancio delle serre reali del palazzo di Lazienki, per la propria nuova casa di Helenow, alle porte di Varsavia. Insomma, un Rembrandt per degli aranci.

Il quadro entra negli inventari reali con il titolo un po’ diminutivo di “Cosacco e cavallo”. Il re non fa tempo a goderselo, visto che nel 1795 la Polonia viene cancellata e spartita tra Russia, Prussia e Austria, lui è costretto a dimettersi e a rifugiarsi a Grodno, vicino a San Pietroburgo, dove sarebbe morto nel 1798. Le 13 casse di quadri che dovevano raggiungerlo, in realtà non partirono mai dal palazzo di Lazienki.
Nel 1811 le raccolte reali sono messe in vendita; gran parte delle opere vengono rilevate dallo Zar Alessandro I, ma sul Rembrandt mette gli occhi, una giovane e dinamica nobildonna polacca, Waleria Stroynowska. Comincia così un nuovo viaggio del Cavaliere. È un viaggio in cui cambia anche di identità, perché la brillante Stroynowska, su suggerimento del marito, Jan Tarnowski, vi riconosce la divisa di un suo antenato che aveva combattuto nella Guerra dei Trent’anni sotto il comando Josef Lisowski. Per questo, un po’ arbitrariamente, il cavaliere da cosacco viene ribattezzato “Lisowczyk”. Stroynowska non si limita a questo, visto che nel giro di qualche anno il quadro approda nella sua collezione, attraverso una girandola di passaggi che Salomon ricostruisce con accuratezza. Del resto la nobildonna e suo marito potevano contare su un ottimo pedigree: nel 1806 avevano commissionato ad Antonio Canova una variante del “Perseo con la testa di Medusa”, oggi al Metropolitan di New York. Il Cavaliere di Rembrandt si aggiunse così alla collezione, custodita nel castello neo medievale che la coppia si era fatto costruire a Dzikow, nel sudest della Polonia.

Paradossalmente di questo quadro che aveva tanto colpito l’immaginario (e l’interesse) del collezionismo polacco, ad Amsterdam e nel resto d’Europa si sapeva poco o nulla. Il muro sarebbe caduto per una coincidenza rocambolesca, nel 1897. Abraham Bredius, collezionista e curatore olandese, era in missione tra Polonia e Russia in vista di una grande mostra dedicata a Rembrandt, programmata ad Amsterdam per l’anno successivo. Dalle finestre della hall dell’hotel di Cracovia dove alloggiava, Bredius era rimasto incuriosito dal passaggio di una fastosa carrozza nuziale. Aveva chiesto informazioni, venendo a sapere che si trattava di Zdzislaw Tarnowski, nipote ed erede della brillantissima Waleria. Aveva anche saputo che tra tante ricchezze lo sposo possedeva un meraviglioso quadro di Rembrandt. Bredius riuscì a ottenere il permesso di visitare il castello di Dzikow nel pieno dei preparativi per la festa nuziale, prevista per il 5 agosto. «Uno solo guardo, un’occhiata ravvicinata di qualche secondo sono bastati per convincermi che qui, nascosto in questo luogo isolato, stava appeso uno dei capolavori di Rembrandt da quasi 100 anni!», aveva scritto sul “De nederlandische spectator” per annunciare la scoperta.
Convincere Tarnowski al prestito non fu impresa semplice, ma alla fine il Rembrandt arrivò ad Amsterdam con un titolo onnicomprensivo: “Ritratto di un cavaliere polacco, con l’uniforme del Reggimento Lysowsky, in un paesaggio”. Per il New York Times era la vera sorpresa della mostra, un quadro che sembrava uscito da un racconto di Gogol.

Tarnosky che aveva fatto tanta fatica a privarsi temporaneamente del quadro nel 1898, nel 1910 un po’ a sorpresa lo metteva in vendita. La trattativa era stata affidata alla galleria londinese Carfax & Co. È qui che Roger Fry intercetta la notizia, avvertendo immediatamente per telegramma Henry Clay Frick. Il prezzo fissato è di 60mila sterline. Frick dà l’ok, ma sorge un altro imprevisto: Tarnosky vuole che l’affare si concluda nel suo castello di Dzikow. Così Fry suo malgrado deve sobbarcarsi la pesante trasferta. Tra le condizioni poste c’è anche quello di avere una copia del quadro da mettere sullo stesso muro (e addirittura nella stessa cornice che Fry aveva giudicato orribile e lasciato sul posto: cornice e quadro bruceranno in un disastroso incendio nel 1927). La copia viene fatta a Londra, dove il Rembrandt fa dunque un’ultima tappa prima di attraversare l’Atlantico. Il 21 luglio Frick lo riceve nella sua residenza estiva di Eagle Rock. Il telegramma che manda a Fry è di una sola parola: “Enchanted”. È un quadro che il collezionista sente immediatamente suo: al biografo confida che il paesaggio gli ricorda quello dei dintorni di Pittsburg, mentre nel volto efebico del giovane cavaliere ha addirittura scorto i tratti di sua figlia Ellen Clay. Il camaleontico capolavoro di Rembrandt aveva messo a segno la sua ultima trasformazione.
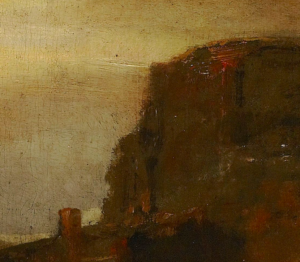
Resta da capire cosa ci facesse un cavaliere polacco nell’Amsterdam del 1655 e perché Rembrandt avesse dipinto un soggetto per lui così atipico. Nella sua ricerca Salomon raccoglie indizi che confermano più di una connessione tra l’artista e la Polonia: la sorella di Saskia, sua prima moglie, aveva sposato un teologo polacco; Hendrick van Uylenburgh, presso cui Rembrandt aveva vissuto appena arrivato ad Amsterdam, aveva padre e fratello impegnati come ebanisti e pittori a Cracovia e Danzica. I costumi della cavalleria polacca in quegli anni avevano acceso la fantasia e la curiosità in Europa, in particolare dopo le aperture delle due ambasciate a Roma e Parigi. Lo stesso inventario dei beni redatto dopo la bancarotta, rivela di quale armamentario di costumi e oggetti esotici Rembrandt si fosse dotato.
Resta il fatto che questo capolavoro si porta dentro qualcosa di irriducibilmente misterioso. Il suo viaggio è un viaggio in terre ignote e fuori dal tempo. Noi lo ammiriamo ma, come ha scritto Kenneth Clark, «non ci è possibile accompagnarlo».