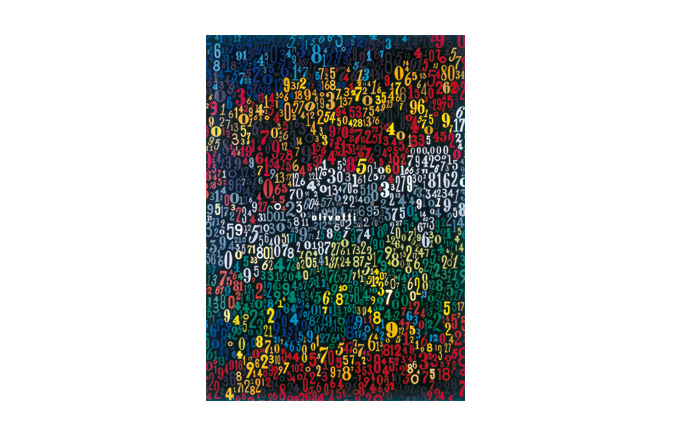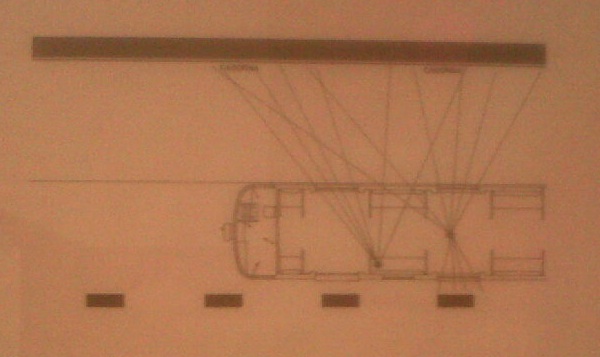Ho letto il libro di Aurelio Picca che giovedì presenteremo con Luca Doninelli a Casa Testori (giovedì 14, ore 21, tutti invitati). Inutile sottolineare che mi è sembrato un libro bellissimo, una galoppata struggente attraverso quella stagione della nostra storia in cui «il mondo accastava uno sull’altro Marylin Monroe, Jaguar E. Type, Black Panters, Woostock». A questo accatastamento si potrebbero aggiungere anche i nomi degli artisti che Picca, soprattutto nella prima parte del libro, convoca a raffica o per fissare in icona quei momenti di psicologia collettiva, o per rendere l’idea che in quella stagione i piani della vita reale e dell’arte rifluivano uno nell’altro in una continuità quasi ovvia. Questo ricorso alle immagini dell’arte come espansione della cronaca funziona in modo a tratti sorprendenti: il devastante incidente di moto che toglie di mezzo il personaggio chiave del romanzo, il Tenebroso, viene sottolineato con il ricorso ad Arman e Pollock: «Il volto del Tenebro era un cartone nero e sfasciato come i violini di Arman e il suo stesso sangue gli piovve addosso che sembrava lo sgocciolamento dei quadri di Jackson Pollock». Il pop domina come immaginario e anima di un’epoca. Bellissimo questo passaggio: «In quei giorni a girare in Giulia con Tutta la mia città a palla, pareva di entrare e uscire da un dipinto superlucido di James Rosenquist; o continuare a baciare, con la testa spezzata dai sogni, labbra rosse alla Pino Pascali». E ancora: «Nel buio si videro i lampi degli spari. Non galleggiare, ma tagliare la notte dall’ombelico in giù. Fu una serigrafia pop. La prima in assoluto. Magari di Richard Hamilton». E ancora: «Nulla offuscava la luminosità dei giorni, dunque scorrevano come tanti dipinti di Richard Estes, Ed Kienholz, Tom Wesselmann, David Hockney, mentre le ragazze che si incontravano erano identiche alla trasparenza di Perfect Match di Allen Jones, o argentate come quelle di Giosetta Fioroni».
Tra i tanti artisti evocati e convocati c’è anche Mark Rothko. La prima volta le bandiere nere con la grande A cerchiata di bianco di una manifestazione di anarchici, rimandavano «alle Pale di Rothko» (trovo che l’uso del termine “pala” per le opere di Rothko sia un’intuizione sintetica e geniale). La seconda volta invece il grande artista viene evocato per inadeguatezza: «Il cielo era altissimo più di Mario del Monaco. Arrivava oltre ogni canto di tenore. Quel cielo, come un quadro mai dipinto da Rothko, ma da Andrea Del Sarto sì…». Il parallelo è ardito, ma ci sta tutto.
Aurelio Picca, quando la vita entrava e usciva dai dipinti
Pasolini ritrae Longhi. Segni di una discepolanza totale
Non perdetevi la mostra su Pasolini a Casa Testori (dura sino al 1 luglio) (qui orari di apertura). Alla penultima sala, quella dedicata al ciclo dei disegni con i ritratti di Roberto Longhi si capisce qualcosa di importante circa Pasolini. Innanzitutto il ciclo è bellissimo, con quella sequenza seriale di fogli grandi, tutti della stessa dimensione e tutti lavorati sulla stessa immagine di Longhi, preso di profilo. Ogni foglio (sono 13 quelli in mostra sui 15 complessivi di cui è composto il ciclo) è lavorato con un tecnica diversa dall’altro, sino a quel foglio semi invisibile realizzato con un gessetto bianco. Quattro disegni sono datati 1974, i restanti 1975: di questa seconda fase ci resta anche la documentazione fotografica di Roberto Pedriali. Si vede Pasolini nel suo rifugio di Chia, accovacciato per terra. lavorare concentratissimo e in solitudine sui fogli sparsi per il pavimento. Mi sono chiesto a quale bisogno rispondesse la decisione di questo confronto così serrato con il volto del suo maestro, scomparso cinque anni prima. Il pretesto era certo la pubblicazione della raccolta di testi longhiani nei Meridiani, sulla cui custodia compariva proprio un Longhi di profilo. Ma sono i mesi di Salò e del cantiere di Petrolio, sono mesi su cui incombono tante visioni da incubo; mesi, visti a posteriori, precipitosamente terminali. Perché tornare così insistentemente a Longhi in un clima così? Non credo ci siano risposte, ma la recensione “innamorata” che Pasolini un anno prima aveva fatto del volume dei Meridiani sul settimanale Tempo qualche indizio lo fornisce. «Se penso alla piccola aula (con banchi molto alti e uno schermo dietro la cattedra) in cui nel 1938-39 (o 1939-40?) ho seguito i corsi bolognesi di Roberto Longhi, mi sembra di pensare a un’isola deserta, nel cuore di una notte senza più luce. E anche Longhi che veniva e parlava su quella cattedra, e poi se ne andava, ha l’irrealtà di un’apparizione. Era, infatti, un’apparizione… Il rapporto ontologico e negato assolutamente a ogni precisazione pratica. Forse anche per questo tutto ciò appartiene a un altro mondo». Pasolini poi conclude così il ricordo di quell’esperienza: «Allora, in quell’inverno bolognese di guerra, egli è stato semplicemente la Rivelazione». (I corsivi nella citazione sono corsivi di Longhi)
Senza avere la pretesa di una spiegazione pedissequa, questa pagina in qualche modo conferma come non sia affatto casuale che Pasolini in quell’estate feroce del 1975 cercasse una nuova “apparizione” del suo maestro. E spiega anche le vibrazioni che si avvertono entrando in questa indeminticabile sala a Casa Testori.
Ps: per capire il risvolto concreto della “Rivelazione” di cui parla Pasolini, ecco queste sue altre righe, dalla stessa recensione: «Il corso era quello memorabile sui Fatti di Masolini e di Masaccio… Sullo schermo venivano infatti proiettate delle diapositive, i totali e i dettagli dei lavori, coevi ed eseguiti nello stesso luogo, di Masolino e di Masaccio. Il cinema agiva, sia pur in quanto mera proiezione di fotografie. E agiva nel senso che una “inquadratura” rappresentante un campione del mondo masoliniano – in quella continuità che è appunto tipica del cinema – si “opponeva” drammaticamente a una “inquadratura” rappresentante a sua volta un campione del mondo masaccesco… il frammento di un mondo formale si opponeva quindi fisicamente, materialmente al frammento di un altro mondo formale»
Su Longhi avevo riportato anche questo pensiero di PPP
Una delicatissima Pietà tra le pagine de Il Manifesto
Imprevisti percorsi dell’informazione: è da Il Manifesto di domenica (inserto Alias) che sono venuto a sapere, attraverso un documentatissimo articolo, di questa Pietà recentemente acquisita dal Louvre. Un’acquisizione di grande importanza, perché il catalogo di questo artista arrivato dai Paesi Bassi alla corte di Borgogna nell’ultimo scorcio del 300, si conoscono solo altre tre opere, una delle quali è proprio al Louvre. Una pagina intera del quotidiano, con l’immagine che campeggia con la delicatezza delle sue linee e dei suoi colori: un colpo d’occhio davvero emozionante. La Pietà è di altissima poesia, con il corpo di Cristo nudo che s’allunga frontalmente senza dar nessuno scandalo per tutta la tavola. Le figure sembrano tutte disposte con l’ordine dei petali di un fiore. Scrive Claudio Gulli: «Si tratta di un’opera di una ricchezza rara: colori rari – sfoglie di lapislazzuli, miscele calde di lacca, minio e vermiglione, gli squilli del giallo di piombo-stagno – accendono il contrasto emotivo fra l’atterramento di Cristo e il doloroso contegno degli astanti». La tavola è arrivata al Louvre in modo rocambolesco (tant’è che sul sito del Museo non ne ho trovato ancora traccia): era infatti conservata nel presbiterio della parrocchia di Vic Le Comte paesino nel centro sud della Francia. Nessuno ne conosceva l’importanza, e il parroco decise di venderlo per far fronte a spese urgenti. Intercettato sul mercato da un privato, ora è arrivato al Louvre che lo ha pagato 7,8 milioni, alla condizione che 2,7 tornassero al comune che dell’opera si era visto improvvidamente privato. Dal 16 maggio è visibile alla Galerie Richelieu. «Un dipinto che sarebbe piaciuto a Luciano Bellosi», ha detto Dominique Thiébaut, la conservatrice della collezione dei primitivi del museo parigino (che ha pubblicato per l’occasione anche un agile libretto su quest’opera). Una ragione in più per ammirarla.
La Via Crucis perduta di Frank Stella
Frank Stella in una bella intervista a Letture del Corriere della Sera ritorna sull’episodio (2009) del rifiuto della sua Via Crucis per la chiesa di Tor Tre Teste progettata da Meier a Roma nel 2000. Oggi la Via Crucis è finita in casa di un collezionista svedese. Ne ho viste riproduzioni non buone, ma sufficienti a farmi questo pensiero: mi sembra un’assoluta idiozia essersi fatti sfuggire un’opera così (per poi ritrovarci chiese tempestate di cose orrende e sempre paurosamente incoerenti tra di loro).
Museo del Design, il design come feticcio
(Devo questi spunti a Massimiliano, tks)
Piccola riflessione dopo aver visitato la quinta edizione del Museo del Design alla Triennale di Milano, quest’anno dedicato alla Grafica Italiana. L’impaginazione è pulita ed elegante, tutta giocata su nette transizioni di colori: ma ala fine risulta un’impostazione un po’ vetrinistica, pensata per mettere in mostra il meglio, che nella gran parte dei casi è il solito “meglio” che abbiamo avuto modo di vedere in tante altre mostre o libri pamphlettistici sull’argomento. In questo modo secondo me si insiste nel dare un’idea sbagliata e tutta mediatica del design; roba appunto da vetrine di negozi trendy. Invece la realtà vera che ha fatto grande il design italiano è l’artigianalità anche faticosa del suo procedere. Ho in mente gli studi di Magistretti e Castiglioni e sono luoghi dove si avverte l’accumulo del lavoro materiale, la “sporcizia” lasciata dallo sperimentare, la fatica che precede l’illuminazione che risolve l’oggetto. Tutto questo viene come cancellato, per dare risalto solo all’oggetto finale: quasi fosse l’esito della magia di uomini dotati di particolare grazia creativa. Mi sembra un approccio poco interessante e pedagogicamente poco educativo. Il design così si trasforma in un feticcio, messo lì per riscuotere la nostra adorazione. Fosse stato per me, avrei preso solo una delle tante declinazioni della grafica (i giornali, solo per fare un esempio) e avrei ricostruito i vari percorsi, laboriosi e affascinanti, che avevano portato ad esiti tanto ammirati. È un approccio che permette confronti più serrati e anche culturalmente più interessanti. Avere la percezione della fatica e dei tentativi che stanno dietro alla bellezza sintetica e brillante di una soluzione, renderebbe più reale quella stessa bellezza.
Per spiegarmi meglio: c’è una piccola sezione della mostra in cui sono esposti alcuni studi di Bob Noorda per la segnaletica della Metropolitana milanese (un vero capolavoro distrutto da uno stillicidio di interventi scriteriati). In uno di quetsi che ho fotografato (male) prendendomi il rimprovero del guardiano si evde com Noorda si fosse preoccupato che le scritte con il nome delle stazioni fossero visibili sempre, in qualunque parte della carrozza uno si trovasse (mettendo così i nomi anche sui pilasti al centro, oggi colonizzati dalla pubblicità). Non a caso subito dopo lo chiamarono a sistemare la metropolitana di New York… È un esempio di quale lungo e paziente processo di pensiero, di sperimentazione e di semplificazione abbia dietro di sé ogni prodotto finito di grafica.
Fabio Novembre, Burri e Gibellina
Ho incontrato Fabio Novembre nel suo studio. Vagando per il suo sud, il discorso ad un certo punto fa capolino su Gibellina. Mi dice che il cretto di Burri è una delle cose che più hanno lasciato il segno su di lui. Nella desolazione di quel paese dimenticato da tutti, sembra che Burri avesse intuito il rischio che incombeva e quindi aveva pensato a quella crosta di cemento inespugnabile. Cemento bianco, che inghiotte le immense rovine del terremoto del 1968. Città morta che custodisce se stessa. Burri ci lavorò tra 1984 e 1989. Ecco come tante volte aveva ricordato la genesi di quell’intuizione: «Andammo a Gibellina con l’architetto Zanmatti, il quale era stato incaricato dal sindaco di occuparsi della cosa. Quando andai a visitare il posto, in Sicilia, il paese nuovo era stato quasi ultimato ed era pieno di opere. Qui non ci faccio niente di sicuro, dissi subito, andiamo a vedere dove sorgeva il vecchio paese. Era quasi a venti chilometri. Ne rimasi veramente colpito. Mi veniva quasi da piangere e subito mi venne l’idea: ecco, io qui sento che potrei fare qualcosa. Io farei così: compattiamo le macerie che tanto sono un problema per tutti, le armiamo per bene, e con il cemento facciamo un immenso cretto bianco, così che resti perenne ricordo di quest’avvenimento».
Ha ragione Novembre. Il Grande Cretto di Gibellina è land art nel senso più completo del termine. Forse è la cosa più bella e più grande che la Land art abbia mai prodotto. Ma è così perché è un’opera che si confronta con la storia, con la sua drammatica oggettività. Non mette in scena l’osmosi con la natura, come succede in tutta la Land art, perché non può nascondersi che la natura qui è stata terribilmente nemica. Per cui la sua è un’opera dialettica, costretta ad essere armonica e insieme titanica, quasi volesse imbrigliare per sempre quel demonio che aveva scatenato l’inferno nella vecchia Gibellina.
E, visto dall’alto, il Grande Cretto svela la sua griglia così giusta e piena di armonie. Sono quelle inventate dall’uomo quando sapeva rendere umano il proprio habitat.
Pedagogia testoriana, all’ombra di Beniamino Simoni
Oggi si tiene la Santa Crus di Cerveno. È una cosa unica che cade ogni 10 anni, una macchina scenica che coinvolge tutto questo paese della Valle Camonica (la Santa Crus non cade tradizionalmente nella Settimana Santa ma a maggio, perché legata alla festa del Ritrovamento della Croce, che nel vecchio calednario liturgico cadeva il 3 maggio). Ma soprattutto la Santa Crus è una sorta di memoria vivente dell’opera di quel grande scultore che è stato Beniamino Simoni. Lui ha lasciato a Cerveno il suo capolavoro, nelle 14 cappelle della Via Crucis allineate ai lati della scala di accesso alla parrocchiale. A quella Via Crucis ho leagto uno degli episodi più formativi della misa storia: ci ero salito con Testori che aveva in programma di realizzare per la Grafo di Roberto Montagnoli un libro che finalmente rendesse giustizia di quel capolavoro. Eravamo saliti con il fotografo e ricordo l’occhio quasi rapace e impetuoso di Testori che suggeriva (è un eufemismo, naturalmente: era una regia che non ammetteva discussioni, la sua) i particolari, e soprattutto il punto di vista da cui riprenderli. La fotografia doveva finalmente svelare la grandezza e l’energia plebea di Simoni, non doveva ammansirla come sin lì si era colpevolmente fatto (e come si sarebbe fatto anche in seguito, purtroppo). Il libro pubblicato nel 1976 è un gioiello, ampio, agile, graficamente impeccabile. Testori riprendeva un primo studio con tanto di campagna fotografica di dieci anni prima. Ma questa volta le dimensioni del volume, la maestria dell’editore e l’osmosi del fotografo di Roberto Pedriali con l’occhio di Testori. E nelle pagine irrompono i volti del popolo di Simoni, presenze che non si possono dimenticare per quel loro concentrato di energia umana. Lo sguardo ravvicinato esalta anche la pasta del legno, lavorato con la sgorbia, una specie di “pellaccia” più vera del vero.
Ma quello che conta è il metodo; l’arte vive perché uno sguardo non banale, intelligente criticamente e capace di immedesimazione (quindi non culturalmente supponente) la fa di nuovo sussultare.
Ecco un assaggio delle parole di Testori:
«…il Simoni, in effetti, non polemizza; si pianta lì, nel bel mezzo del secolo (il 1700, ndr), con le sue zampe da toro testardo e senza requie; si pianta lì e vive; vive e soffre fino all’ultima stilla di sudore e di sangue le presenti e passate sofferenze, ingiustizie, violenze, servitù, turpitudini, fami e vergogne del suo povero, disperato popolo, vive, soffre e constata; e constatando pietoso della sola pietà possibile a quei tempi (che era l’indignazione), una scultura gli cresce nelle mani, potente, tragica, nuovissima (quasi venisse trovata o inventata lì, ecco, proprio lì, a Cerveno, per la prima volta da che l’uomo era uomo)…»
Gina Pane, parole sante
Ma Gina Pane mi interessa perché è la riprova della gratuità dell’arte. Mi riferisco a quella serie di opere finali, che io ho solo visto riprodotte e raccontate, in cui chiusa la stagione della body art Pane si sposta dal proprio corpo al corpo dei santi. È un passaggio tanto intenso quanto imprevisto che illumina di senso anche la sua stagione precedente e che dimostra come sul rapporto tra arte e fede forse è meglio lasciar perdere teorie e discorsi e osservare umilmente l’imprevisto di certe esperienze.
Quella di Gina Pane, ad esempio, è davvero tanto semplice quanto sorprendente. Mi è capitata tra le mani una lettera scritta da un amico acuto (Camillo Ravasi) qualche anno fa in cui mi allegava una pagina della rivista Il contemporaneo con un ritratto dell’artista realizzato attraverso le sue parole. Vi riporto alcuni passaggi, che non hanno bisogno di nessuno commento.
Cos’è il corpo per Gina Pane?
«È il nucleo irriducibile dell’essere umano, la sua parte più fragile. È sempre stata tale, sotto tutti i sistemi sociali, in qualsiasi momento della storia. È la ferita è la memoria del corpo; essa memorizza la sua fragilità, il suo dolore, dunque la sua esistenza “reale”. È una difesa contro l’oggetto e contro la protesi mentale».
Perché l’attenzione al corpo dei santi?
«Ciò che mi interessa nel corpo del Santo è la sua capacità di svuotarsi, per poi riempirsi, il suo “non funzionamento” rispetto a una realtà di consumo. È il rapporto tra la fragilità di quella carne – il santo è là, ed è un corpo, un uomo – e la forza immateriale che lo abita. Soprattutto mi interessa il cammino, la strada da compiere per arrivare a questo. Mi interessa capire come San Francesco ha potuto essere quello che è stato. Non mi interessa certo fare dell’agiografia. Io colloco questo lavoro dei santi nella società attuale, nella nostra vita di ogni giorno».
Che cos’è l’avanguardia?
«Giotto e Cristo»
Come guardare a Bacon? Una riflessione illuminante
Oggi Maria Teresa Maiocchi su Il Sussidiario riprende una mia riflessione su Bacon e il cattolicesimo. La ringrazio, perché dice in modo intellettualmente ed esperienzalmente ineccepibile quale sia stata la fortuna di aver avuto nel 900 un artista come Bacon (fortuna per tutti, ma per chi è credente in particolare).
Riprendo il finale dell’intervento di Maria Teresa Maiocchi. Qui potete leggere l’integrale in integrale.
«Lasciamo allora che Bacon lanci – come può, come tutti facciamo – l’aggressione della sua domanda alla/dalla tela, perché più il grido sgraziato dei suoi folleggianti deformi sarà forte, meno gli Inquisitori d’ogni tempo potranno cancellare il paradosso grazioso della libertà come presenza, presenza dell’orrore di un mancamento di cui farsi responsabili, assumersi il rischio. Grazie a questo orrore figurabile, Bacon ci riserva anche un vantaggio, piccolo ma non trascurabile : le sue scimmie umane difficilmente saranno riducibili alla pubblicità di un caffè, pur “paradisiacamente” buono…
È di questo riduzionismo da gadget che una “estetica teologica” – come divina bellezza della forma – sicuramente oggi soffre, non delle voragini baconiane, allusioni – forse – a un nihil che non obstat».
Un consiglio al giovane curatore: osservare, osservare, osservare…
Ho trovato queste righe in un libro che vi suggerisco di leggere, Breve storia della curatela di Obrist (Postmedia Books). Le ho trovate nell’intervista (che fa parte del libro) ad Anne d’Harnoncourt, già direttore del Philadelphia Museum of Art (è morta nel 2008; l’intervista è del 2006). A Obrist che le chiede quale consiglio darebbe a un giovan curatore, lei risponde così:
«Credo che il mio consiglio non cambierebbe molto: osservare, osservare, osservare e osservare, e poi osservare di nuovo, perché niente sostituisce l’osservazione…. Non vorrei essere, in termini “duchampiani”, solo retinica, non è questo che voglio dire. Vorrei stare con l’arte: ho sempre pensato che fosse una bellissima frase quella di Gilbert & George “tutto quello che chiediamo è di stare con l’arte”… È un privilegio, è una responsabilità, è un onore; è scoraggiante passare molto tempo con l’arte e con gli artisti, perché vorrei rendere loro giustizia. In realtà questo l’ho imparato sia dai giovani curatori che dai miei insegnanti… Credo che prima di tutto non si smette mai di imparare, bisogna sperare di avere davanti una lunga corsa prima di non potere veder più nulla, prima di vedere solo cose che conoscevi e che già ti entusiasmavano. Credo anche che una delle maggiori opportunità nella vita di un curatore sia quella di cambiare idea, veder il lavoro di un artista che non capiva o che non gli piaceva, o che non riusciva a mettere insieme dieci o vent’anni fa, e improvvisamnte girare l’angolo e vdere magari la stessa cosa, o magari qualcosa di diverso dello stesso artista ed esclamare: “Wow! Questa è una cosa che è importante vedere”».
Ps: Come può una persona stare con l’arte? Sentite come rispondono Gilbert & George: «Oh arte da dove arrivi, chi dato vita ad una tale stranezza? Per che genere di persone sei fatta: sei per i forsennati, per i poveri di cuore, per chi è senza anima? Fai parte del fantastico mondo della natura o sei l’invenzione di qualche uomo ambizioso? Provieni da una lunga stirpe di arti? Diventare artista è rinascere oppure è una condizione della vita?» (dall’introduzione delle stesso libro di Obrist)