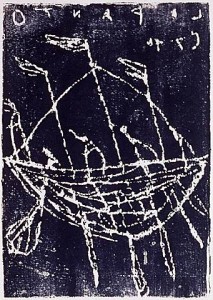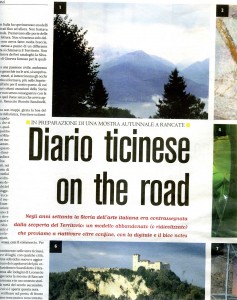In questi giorni di rinnovate e demenziali tensioni tra Islam e Occidente, il pensiero corre alla sala con il ciclo dedicato alla battaglia di Lepanto, appena visto al Museo Brandhorst di Monaco. Sono 12 tele di Cy Twombly, presentate alla Biennale del 2001 (il gioco delle date…), e che oggi occupano in sede definitiva la grande sala a mezzaluna al terzo piano del nuovo museo di Monaco. Non credo che nessuno risolverà l’enigma che sta dietro la scelta di Cy Twombly di concentrarsi su un tema del genere, in un momento come questo della nostra storia (ma c’entra certo il desiderio di esplorare il proprio dna occidentale). Ma l’arte va accettata anche con i suoi enigmi: inutile pretendere di risolvere tutto. Vista nella collocazione ideale del museo (illuminazione perfetta), il crescendo narrativo del ciclo emerge in modo molto più chiaro che non a Venezia. C’è un approccio lirico alla battaglia, con la narrazione affidata a codici semplici, quasi infantili, ma di un’incisività simbolica via via sempre più ferrea. Si comincia da sinistra con un mare che è ancora azzurro e con le flotte schierate, si intervallano immagini in cui il giallo e il rosso del fuoco e del sangue incendiano la tela raccontando l’acme della battaglia. Le pause si fanno sempre più disfatte e cupe, con le sagome delle navi che sembrano come insetti contratti e assediati.
Più che la dimensione di grandezza, Cy Twombly colpisce per questa sua capacità di essere elementare. Di saldare secoli di storia dentro codici semplici ma “archetipici”. Facile il riferimento al linguaggio delle incisioni rupestri (vedi a conferma, qui sotto, la versione della nave in multiplo inciso) che Cy Twombly fa reimergere dal profondo della coscienza e della storia, incendiandoli poi con un furore cinematografico laddove la battaglia non lascia più scampo. Ma la crudeltà e la ferocia non sono certo l’ultima parola: l’andamento, il legante direi, alla fine è irriducibilmente lirico. La storia ribolle, ma alla fine sfuma.