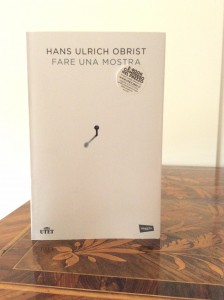Vista la mostra di sui papiers decoupés di Matisse alla Tate Gallery. Ecco alcune annotazioni.
Sicurezza e sperimentazione.
La mano di Matisse con la forbice va via decisa e sicura. Negli spezzoni filmati si vede che l’assistente gli tiene il foglio di carta per facilitare l’azione, ma lui con le forbici sembra muoversi avendo ben preciso nella testa la forma a cui tende. Quindi c’è un’esattezza e una pulizia di visione, che Matisse percepisce letteralmente come un “dono” (parole sue in Jazz). Non se ne prende i meriti…
Dall’altra c’è un aspetto sperimentale che è quello da cui si genera l’esperienza dei Cut-outs: mettere delle sagome su una superficie preparata per avvicinarsi via via alla giusta composizione. Nella grande Laguna polinesiana i ritagli bianchi sono punteggiati dai segni di spillo. Così funzionava il procedimento di Matisse, che spostava le sagome sulla grande superficie, in questo caso beige, sino a trovare il punto d’equilibrio.
Nel corpo del colore.
A Londra sono esposti gli originali di Jazz, conservati al Pompidou. È la prima volta che li vedevo, e così ho capito quella ritrosia che Matisse di fronte all’idea di tradurli in stampa. Matisse infatti non ritaglia semplicemente dei fogli colorati, ma ritaglia direttamente del colore. I fogli hanno una corposità, conferita dalla stesura delle tempere, che nella stampa si smarrisce. Si perde spesso la direzione della pennellata e quel mix di colore e di granuli di bianco che danno un peso specifico diverso al foglio. Si crea anche qualche confusione tra i bianchi, che negli originali non sono mai uguali tra il bianco del foglio di supporto e quello dei papiers inseriti nella composizione. Del resto il nome esatto della tecnica è chiaro: “papiers gouachés decoupés”. Quel “gouaché” non è secondario… Comunque è preziosa l’esposizione in parallelo di originali e stampa, con possibilità di leggere il fantastico testo di “riempitivo” scritto a mano da Matisse (paragonava la sua funzione a quello della paglia che si mette nelle scatole di bottiglie per proteggerle…).
La danza dei contrari.
Vedendo la mostra londinese colpisce questa agilità straordinaria acquisita da un uomo costretto di fatto all’immobilità. In Matisse non c’è mai un segnale di recriminazione rispetto alla propria condizione fisica. Lo si può capire, perché l’esperienza artistica diventa un surrogato più che sufficiente a quel che per il suo fisico era ormai proibito, Matisse danza con le forbici e sulla carta; Matisse si fa acrobata ed equilibrista pur senza muovere un passo. Forse è per questo che una mostra come questa dà un senso infinito di benessere a chi ha la fortuna di vederla…
Anche nei confronti del corpo femminile, sembra arrivare ad allacciare relazioni di una trasparenza che esalta una dimensione fisica di godimento. Se guardate le varianti dei nudi blu, osservate il lavoro sulla gamba destra, quella piegata verso l’alto. Nella piattezza pura del colore, Matisse non tralascia nulla della fisicità e della sensualità del corpo: l’apice, per me, è nel Nudo blu II, dove la coscia prende una forma agile, sensuale e insieme giunonica.
Infine, un vero capolavoro: Zulma, 1950. Ritratto in piedi, tra due tavolini, circa due metri di altezza. C’è una sintesi di tutto Matisse in questo gioiello: la sagoma blu del corpo questa volta si apre al centro, liberando una forma quasi color carne. È come una zip leggera, che si spalanca a sorpresa per svelare tutta la sensualità di questa “dea” planata nello studio di Matisse.
Infine…
Credo che ci sia una chiave solo per spiegare la felicità che Matisse riesce a comunicare. È un concetto che nella straordinaria mostra londinese sui Cut-offs emerge a ogni pie’ sospinto. Matisse “ama” ciò che ha davanti. È un amore pacato ma senza esitazioni il suo. Resta sempre su binari di equilibrio, non dà mai segni di esagitazione, ma s’impone come fattore decisivo, come innesco del suo agire in quanto artista. E’ l’amore la chiave che spiega la bellezza e la libertà di invenzioni di Matisse.

![042[amolenuvolette.it]1950 zulma pochoir](http://robedachiodi.associazionetestori.it/wp-content/uploads/2014/08/042amolenuvolette.it1950-zulma-pochoir-161x300.jpg)