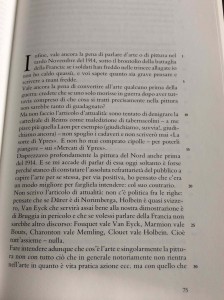Mi dicono voci amiche che i miei pensieri sulle mostre milanesi sono stati troppo cattivi. E che in fondo, con tutte i limiti oggettivi, rappresentano pur sempre occasioni per vedere e per conoscere: un “più” di cui tenere conto.
Provo a spiegarmi.
Amando orgogliosamente la città in cui vivo, la vorrei più ambiziosa, anche e soprattutto nel momento in cui entra in gioco la cultura.
Per questo non mi basta riconoscere che nella massa di quadri di Chagall c’è ne sono alcuni bellissimi, come quelli dettati dall’amore per Bella, come quel grande mazzo di fiori in cui c’è tutta la sorpresa della facilità dei fiori, che si rivela ai suoi occhi all’arrivo in Francia. Mi piacerebbe che dietro una mostra ci fosse un disegno, la messa a fuoco di un’idea, un lavoro che dice quanto a Milano si sa ancora pensare e studiare. Un qualcosa che faccia dire a chi abita a Lugano: questa di Milano non devo perdermela. Com’era capitato a chi interessa Chagall in occasione della mostra dello scorso anno di Zurigo, sui suoi primi anni. (Il fatto che Chagall non mi entusiasmi perché ci veda sempre una punta di infantilismo di troppo, è punto di vista del tutto personale).
Non penso che la mostra di Giacometti era meglio che non ci fosse. Giacometti vale il biglietto anche solo per la monumentale testa che chiude il percorso. Ma quando vedo che Giacometti non è entrato nel magnifico Pac di Gardella, mi viene da pensare che la ragione sia che non c’è stato tempo di preparare una mostra che reggesse quegli spazi. Che si è fatto un Giacometti un po’ di risulta. È allora che mi scattano i cattivi pensieri… Milano merita un Giacometti da Pac. Cioè da serie A. E poi perché non lavorare sul rapporto tra Giacometti e Milano. Bastava una saletta documentaria, avrebbe dato un connotato alla mostra…
Su Segantini insisto, l’allestimento è completamente sbagliato. E credo che sia lesivo di Segantini, perché lo chiude, lo ghettizza. Allontana da lui invece che avvicinarlo. Lo oscura. Guardate invece com’è esposto a St. Moritz. Lui si voleva così (foto sotto). E poi la font usta, che è font cubitale del ventennio, non c’entra nulla con lui. Guardare la sua firma per capire. È un peccato: amo Segantini e lo avrei voluto vedere liberato da ottocentismi e stereotipi.
Ora arriva Van Gogh. Non mi aspetto fuochi d’artificio. Ma almeno mi consolo con il fatto che l’allestimento è stato affidato a Kengo Kuma. Almeno con lui la luce è assicurata…
Pensieri un po’ meno cattivi sulle mostre di Milano (2)
Cattivi pensieri sulle mostre milanesi
Ho visto le tre mostre inaugurate in queste settimane, e liberamente esterno tutte le mie perplessità
Chagall, artista che ammetto di non amare. Una mostra un po’ all’ammasso, che certo non giova ad un artista che ha momenti di grandezza, che sbucano nel percorso contrassegnato da una bulimia produttiva, con ripetitività di motivi e di soluzioni. Ovviamente non c’è stato il coraggio di tentare una chiave d’approccio come esito di un percorso di esplorazione nuova, per il semplice motivo che queste mostre nascono escludendo a priori percorsi di questo tipo. Non si è tentata neanche una chiave tematica, ad esempio sul filone degli incroci religiosi che segnano Chagall e che forse oggi avrebbe avuto motivi di attualità.
Sulla scelte delle opere ho perso il conto di quante provengano da collezioni private. Pezzi in gran parte di modesta importanza, che dovrebbero dare un po’ di lustro ai salotti di collezionisti di medio livello. Ma c’era bisogno di riempire i muri, e in questo modo si sono fatti contenti tutti.
Segantini. Il livello è decisamente un altro, anche se non è mostra che aggiunga molto a quel che si conosce di lui. Quello che invece sconcerta è la scelta dell’allestimento, con un marrone scuro steso su tutti i muri, e una grafica pesante e invasiva per tutti i pannelli didattici. Oltretutto la mostra è al piano terra di Palazzo Reale, che ha locali bassi e “schiacciati”. Segantini è pittore che avrei esposto a piena luce e in piena chiarezza, guardando più ai milioni di watt degli esterni engadinesi che non alla luce fioca degli interni. Tutte scelte che purtroppo ghettizzano Segantini.
Giacometti. Quattro sale al piano terra della Galleria d’arte moderna di via Palestro. Un percorso che taglia fuori il museo (visitabile con un’aggiunta di due euro al biglietto, da 12 a 14), ed è un peccato perché così si butta un’occasione per valorizzare la Gam e si conferma l’idea di essere davanti ad un “affitto” di spazi. Quanto alla mostra, Giacometti non tradisce mai. C’è una una monumentale testa in gesso con tocchi di policromia in chiusura, che da sola vale la visita. Certo la meditazione di Giacometti sulla testa umana è uno dei grandi motivi dell’arte del 900.
PS: alla mostra manca senz’altro una sala, quella delle relazioni tra Giacometti e Milano. Ne riparlerò.
Un pomeriggio di meravigliosa Lombardia
Prima tappa a Castiglione delle Stiviere, dove Emilio Isgrò ha portato il suo progetto dedicato a Pico della Mirandola. La mostra è ospitata nel palazzo Bondoni Pastorio, gestito con passione e competenza da Giulio Busi e da Simona Greco. Le cancellature su 23 leggii che si incontrano nelle sale del palazzo, raccontano di un ampiezza di sguardo, su tutte le voci del sacro che quando entra nella storia, si presenta con il suo passo ardente. Il segno di Isgrò, che lavora su un’edizione antica delle celebri Propositiones, insegue questo palesarsi di un oltre che brulica misterioso e prende voce e soprattutto lettera a degli uomini. Pico a Castiglione arriva non a caso. A parte che Busi è uno dei suoi massimi conoscitori, qui soggiornò sua sorella Caterina, che fu sposa, in seconde nozze a Rodolfo, capostipite dei Gonzaga di Castiglione. La mostra resta aperta sino al 9 novembre.
Castiglione è paese nobile. Che allunga elegante e composto le sue vie nel pieno della pianura lombarda. È paese gonzagesco, di un ramo cadetto della famiglia, da cui nacque però San Luigi, di cui qui si venera la testa… Quanti fili s’intrecciano tra strade e questi muri.

Da Castiglione in pochi km siamo a Montichiari. Qui per vedere il piccolo museo nato dalla donazione dei conti Lechi. Anche qui paese ordinatissimo, capacità di valorizzazione del proprio patrimonio impeccabile. Il museo, a due passi dalla parrocchiale che custodisce la folle ultima cena di Romanino, con gli apostoli che tengono il tovagliolo sulla spalla e Giuda che compie quel gesto incomprensibile al capotavola (versa vino per terra?). Ma il colpo gobbo di Montichiari è quello di Ceruti, con la sua Filatrice, assoluto monumento di umanità. Uno di quei quadri che ti sembrano inimmaginabili, tanto sanno tenere insieme degli opposti: in questo caso la miseria e la monumentalità. Nudità di elementi che raccontano una vita fatta di niente e da questa ne traggono un’immagine di intensità grandiosa. Ad un certo punto guardo da vicino il grembiule che Ceruti dipinge con i buchi e le lacerazioni, e mi vien in mente Burri.

Gran finale le otto di sera in piazza del Duomo a Cremona. Ultimo aperitivo dell’anno all’aperto… Sopra la facciata illuminata che ti sembra spettacolo troppo bello per esser vero. Peccato solo che le meravigliose statue di Marco Romano siano state lasciate in contro luce. Le porte naturalmente sono chiuse. Dentro si possono solo immaginare i sonni rissosi di Romanino e Pordenone…
Tre mostre che, fossi in voi, non perderei
Domenica chiude Veronese, peccato lasciarselo scappare. Non entro nei dettagli della mostra, che mi sembra tutta giusta forse fuorché il titolo che non mi convinc (L’illusione della realtà: non mi sembra Veronese un maestro dell’illusione. Semmai rende reale anche ciò che può sembrare illusorio…). Comunque sia, accade alla mostra un effetto che mi è capitato raramente di sperimentare: appena si entra e la porta d’ingresso scatta alle nostre spalle, la sensazione è davvero di entrare in un mondo a parte, in un regno del benessere. L’allestimento di Alba Di Lieto e Nicola Brunelli luminoso, ben scandito, con punti di fuga che aprono le sale (nella foto), aiuta questo effetto. Ma Veronese non è solo a Verona. A Vicenza, nel Palladio Museum, c’è la bellissima appendice, con le due allegorie ritrovate da Cristina Moro alla villa San Remigio a Verbania Pallanza. Le due allegorie dopo secoli sono state riunite alle altre due conservate a Los Angeles. Un quartetto impreziosito da un tocco di classe: i due paesaggi cezanniani dell’ultimo Boccioni, dipinti proprio nella Villa sul Lago Maggiore. Anche a Vicenza si chiude domenica-
Sabato invece apre al Mart la mostra sulla Grande Guerra. Il titolo è da una poesia di Brecht (“La prossima guerra non sarà la prima”), e la mostra si annuncia come una mostra che non si è mai vista. Da un’intervista realizzata per Vita a Cristiana Collu: «Non è scontata e non poteva esserlo. Avremmo tradito la nostra funzione. Chiediamo alla storia una precisione rispetto a come sono andate le cose, ma poi resta aperta la questione del senso di quello che è accaduto, della verità che a volte può essere crudele, con il rischio di “pornografia delle immagini” che ogni racconto della guerra inevitabilmente porta con sé. Bisognava saper trasmettere un’empatia senza cedere al sentimentalismo. Ci voleva un’empatia consapevole, e per fortuna la poesia ci è venuta in soccorso». Sono curisossimo di vedere l’effetto che fa.
Per merito di Fulvio Irace (recensione sul Sole di domenica 21 settembre) ho scoperto la piccola mostra di Lina Bo Bardi alla Triennale di Milano. Andate a vederla, per scoprire un personaggio così dentro lo spirito del nostro tempo, senza protagonismi, ma con una vocazione ad un’architettura alla portata di chi la vive. Senza timori di essere povera o brutalista. Anche la mostra accompagna il suo stile, con filmati in cui le architetture vengono raccontate per come sono vissute: in particolare il filmato sul SESC Pompéia, il centro culturale realizzato a San Paolo nelle strutture di una vecchia industria.
L’amore di Malevich per le icone
Recensione scritta per Alias e pubblicata domenica 22 settembre
Era nato a Kiev, città appartenente all’allora impero russo, nel 1879, da genitori cattolici polacchi. Si era formato a Mosca come disegnatore tecnico e lavorando per le ferrovie. Nel 1915 si rivelava al mondo con una mostra in una galleria a San Pietroburgo. Città dove sarebbe morto nel 1935, e che nel frattempo aveva cambiato nome in Leningrado. Nel mezzo, anche un periodo di insegnamento a Vitebsk, in Bielorussia, dove aveva preso la cattedra a cui l’aveva chiamato l’ebreo Marc Chagall. Bastano pochi cenni dalla biografia di Kasimir Malevich per intuire come la mostra che la Tate Gallery gli ha dedicato (Malevich, a cura di Achim Borchardt-Hume, sino al 26 ottobre), sia oltre che l’occasione di esplorare uno dei grandi innovatori del 900, anche un’opportunità per capire quale siano la complessità e le stratificazioni che segnano un territorio e la sua cultura. Quella di Malevich, in un certo senso, è quindi una mostra di inattesa attualità.
Allestita al terzo piano della Tate Modern, l’esposizione non si fa e non ci fa mancare niente: solo il primo dei Quadrati neri, quello del 1915, non ha potuto arrivare da Mosca per la sua fragilità. Per il resto i prestiti sono di qualità eccezionale, grazie alla rete di istituzioni che hanno fatto da promotori della mostra: dallo Stedelijk Museum di Amsterdam, alla Khardzhiev Foundation, sempre olandese, sino alla Costakis Collection di Tessalonica (quella della Tate è la seconda tappa, dopo Amsterdam e prima della conclusione alla Bundeskunsthalle di Bonn).
«Un artista russo»: non è il sottotitolo della mostra, che ai sottotitoli accalappia-visitatori giustamente non ricorre, ma è il titolo che è stato assegnato alla seconda sala. Siamo intorno 1910 e l’identità di Malevich, per quanto sia artisticamente ancora incerta, intellettualmente e poeticamente è già ben delineata. Ha avuto modo di vedere quel che un grande collezionista come Sergei Shchukin aveva portato da Parigi, in particolare i Picasso e i Matisse della grande accelerazione di inizio secolo, ma non se ne è lasciato contaminare. Malevich da subito marca la sua differenza, a costo di pagare il dazio di qualche ingenuità di troppo e di sperimentare stili espressivi in modo che a volte sembrano un po’ random.
Ma lui è russo (per quanto parli anche polacco), e non ha né l’intenzione né la tentazione di sottrarsi a questo suo destino. Si capisce presto cammin facendo, che il suo è un obiettivo, o meglio una missione, precisa: portare l’antica Russia, rispettandone sono in fondo l’anima, in prima linea sulle frontiere della modernità. Il primo aggancio tra Russia e modernità prende forma non su una tela ma su un palcoscenico nel 1913, quando Malevitch cura, nell’allora San Pietroburgo, costumi e scenografie per Vittoria sul Sole, opera cubo-futurista musicata da Mihhail Matyushin con un tsto del poeta Velimir Khlebnikov. Le scene sono in bianco e nero, e dominate dalla ripetizione di forme quadrate: cinque in fuga, per dare profondità di campo, e uno alle spalle dello spettatore, per dargli la sensazione di essere chiuso nella dimensione intima di un cubo. Il Quadrato nero arriverà due anni dopo, anche se Malevich lo data al 1913. Lo avrebbe “svelato” il 15 dicembre 1915 con un’operazione che ha tutte le caratteristiche di un passaggio storico. La mostra “Ultima esposizione futurista di quadri 0,10“ si tiene alla Dobychina di San Pietroburgo. Lo zero sta indicare l’anno di inizio di una nuova storia, il 10 il numero di artisti che inizialmente avrebbero dovuto esporre (in realtà furono di più). Il riferimento al futurismo ha qualcosa quasi di canzonatorio: il futuro dell’arte non va nella direzione indicata dall’avanguardia che pur aveva fatto maggiormente breccia nella cultura artistica russa. A documentare quella sala ci resta un’unica, storica fotografia: dei 39 quadri esposti riconoscibili, è nota la sorte di 12. Ben nove di questi sono stati portati in mostra. Ma il cuore della sala è il Quadrato nero su fondo bianco, posizionato con una scelta che più “russa” non si sarebbe potuto, nell’angolo della stanza. Cioè rispettando la tradizione con cui venivano appese le icone nelle case.
Certamente più delle tambureggianti novità che venivano dall’Europa occidentale, Malevich fu interessato da quella mostra evento che si tenne a Mosca nel 1913, quando per la prima volta vennero presentate 147 icone, dal XIV al XVII secolo, liberate dalle ridipinture con cui nel tempo si era tentato di ovviare all’ingiallimento delle tavole. Fu una mostra evento che colpì tutta la nuova generazione di artisti, da Tatlin alla Gontcharova. Ma come ha scritto Tatjana Vlibinkova, «l’interesse più coerente mostrato per l’icona fu quello di Malevitch… Le composizione delle icone, costruite con nitore, facilmente riconducibili a forme geometriche impiegate talvolta in modo diretto, trovarono una prosecuzione nella sua aspirazione a creare una “nuova icona”». Quando qualche anno dopo iniziò a insegnare a Vitebsk, in classe teneva spesso un’icona. Non c’era un’adesione religiosa, evidentemente. Ma c’era un’adesione a quel principio per cui l’arte si è liberata dal dovere di un’espressività e anche da un contenuto, essendo che il contenuto dell’icona è qualcosa che non appartiene a chi le realizza. «L’arte nuova ha posto in primo piano il principio secondo cui l’arte può ammettere solo se stessa come contenuto. Così in essa troviamo non l’idea di qualche cosa, ma solo l’idea dell’arte stessa», scrive nel testo fondante del Suprematismo.
È un’idea che si radicalizza sino ai quadri bianco su bianco che Malevich ribattezza come “morte della pittura” e confluisce in un percorso pedagogico, negli anni dell’insegnamento a Vitebsk e poi a Leningrado. Alla mostra londinese questa esperienza viene illustrata in una magnifica sala dove trovano spazio le grandi tavole che spiegavano teorie e percorsi della Nuova arte (UNOVIS, il collettivo che Malevitch aveva messo insieme era l’acronimo di Utverditeli Novogo Iskusstva, cioè Campo della Nuova Arte). Sono frutto di un lavoro collettivo, con scritte a volte anche in tedesco, perché Malevich volle portarli con sé in una missione all’estero nel 1927, a Berlino e in Polonia. Durò poco quella missione. Perché venne richiamato in Russia e Malevich dovette lasciare quelle tavole a Berlino. Il colima, con la salita al potere di Stalin era cambiato, e l’oscillazione che questa svolta aveva sulla linea dell’arte russa la si può registrare nella grande sala posta come snodo centrale della mostra, dove sono allineati un centinaio di disegni, veri e proprio “pensieri” grafici messi su carta, che coprono tutto l’arco della carriera di Malevich. L’input era quello di tornare alla figurazione. Malevich non se ne sottrae e inizia un percorso per “reinventare la pittura”. Ancora l’icona funziona da ancoraggio per queste sagome semplificate e rigorosamente frontali che raccontano una Russia profonda e che contrassegnano la fine degli anni 20. Sono volti svuotati di identità, che diventano quasi emblema di quella stagione di totalitarismo cieco. Ma è chiaro che quella non è strada che possa convincere Malevich, tanto più che non lo protegge dalle malversazioni del potere (nel 1930 viene anche arrestato con l’accusa di spionaggio a favore della Germania).
Gli ultimi anni sono gli anni dell’eclissi. Malevich sparisce dalla sfera pubblica e s’abbandona ad una pittura strana, affascinante, forzosamente anacronistica. A chiudere la mostra c’è quel famoso Autoritratto in cui posa con una strana solennità, con il costume di Cristoforo Colombo. È un artista evidentemente rassegnato ad essere quello che non avrebbe dovuto essere; rassegnato a dipingere secondo un’idea per lui certamente fuori tempo massimo: ma per quanto costretto ad essere straniero a se stesso, con questo Autoritratto così scopertamente ingenuo, ci dice una cosa che colpisce e anche commuove. Che la libertà di un artista vive anche dentro i muri di una costrizione ideologica ed estetica che può sembrare intollerabile. Che la sua coscienza può restare intatta, anche se non ha più spazi per esprimersi, anche se costretta ad una sorta di mutismo. Non a caso nell’angolo, l’Autoritratto, al posto della firma, come tante altre opere di questi anni estremi, ha un piccolo quadrato nero, dipinto come lo dipingerebbe un bambino. È un segno distintivo, che non ha più l’esatta definizione di un tempo. Non ha più quella forza, quella chiarezza, quella baldanza. Ma è lì, anche nel momento dell’impotenza, a suggerire che quella comunque era la strada. Malevich morì nel 1935. Con lui venne accuratamente sepolta anche la sua opera. Per rivedere in pubblico il Quadrato nero bisognerà addirittura aspettare gli anni 80. Nel frattempo il monocromo aveva conquistato gli artisti di mezzo occidente. Ma a dispetto dell’apparente somiglianza, era tutta un’altra storia. Perché la Russia ha tutta un’altra storia.
Gubbio, pietra per pietra
L’Italia va sempre setacciata con la massima attenzione. Ho avuto la chance di una giornata a Gubbio, e non c’è come il muoversi a piedi, in lungo e in largo per capire a fondo la “chimica” che rende straordinario un luogo come questo. A Gubbio non ci sono grandi quadri o grandi cicli che “distraggono”. È il contesto così che assorbe giustamente tutta l’attenzione. Un contesto in cui l’architettura la fa da padrona, esaltando un topografia impossibile. C’è dell’orgoglio in questa sfida. Un orgoglio municipale che porta a creare la grande piazza che non c’era, appoggiandola ad un pendio scosceso: guardando da sotto, si scorge un potente segno di Roma negli arconi colossali che reggono la spianata. Un segno che incrocia in modo inedito le vertigini del gotico. La scala del palazzo dei Consoli di Angelo da Orvieto, è come un artiglio allungato sulla piazza (la firma dell’architetto è orgogliosamente sul portale); il palazzo poi si alza spavaldamente come un grattacielo tutto di pietra (idem, per quello di fronte, che fa da sentinella della piazza ad est); all’interno il salone si alza colossale: doveva accogliere le adunate del popolo nella stagione della democrazia comunale. Per capire le ragioni di tanta enormità bisogna salire alla sala che accoglie le Tavole Eugubine (la stele di Rosetta dell’antico umbro): lì si legge che una volta ritrovate nel 1456 vennero comperate dal Comune di Gubbio e subito consacrate (e custodite) come memoria e fonte di una storia di cui ci si sentiva orgogliosamente il prolungamento. È un senso di appartenenza che detta le regole di questo gotico sfrontato.
Si può scendere nei dettagli di questo gotico tanto monumentale quanto ardito, ma poi il percorso di Gubbio viene prodigiosamente spazzato dalla pulizia mentale del duca Federico, che qui nacque (e qui fece nascere l’attesissimo erede). Il Palazzo Ducale, inerpicato in alto, costruito rigorosamente secondo i crismi urbinati dalla coppia Laurana – Francesco Di Giorgio, è un’intromissione che non lacera affatto il tessuto di Gubbio, ma sembra portarlo alla sua naturale evoluzione. È la quadratura di tutte le intemperanze del gotico. Un palazzo senza sbavature, con il modulo della mattonella quadrata e incisa che fa da cellula genetica (il “tipo” lo avrebbe definito Aldo Rossi). La geografia di Gubbio non lascia spazio per un cortile a quattro lati di arcate; così quello verso la montagna è un muro, ricamato in alto da una sequenza di arcatelle che sembrano la tastiera di un pianoforte. Il cortile stesso, sempre per costrizione di spazi, è disegnato a trapezio, e sopra il lato di ingresso si vede sbucare la cuspide della facciata del vicinissimo Duomo. Ha un interno, a navata unica, che si distende in dieci stupende arcate di un gotico di ampio respiro. Verso est la città si allunga, senza variazioni urbanistiche, come un’addizione urbinate: i portoni si allargano, esaltando l’innovazione con il contorno di bugnato (la Gubbio gotica aveva invece le “porte del morto”, strette e sollevate di qualche gradino dal piano della strada…); le finestre si inquartano, con tanto di aggiunta di cornice di arenaria a sottolineare la ritrovata appropriatezza della forma.
Se andate a Gubbio, setacciatela pietra per pietra. Ne vale la pena…
I quadri, anche a costo della fame
Non è nuova ma è bello rileggerla. La ripropone oggi Tomaso Montanari, in un articolo sul Corriere del Mezzogiorno. L’aveva usata anche il Fai per una campagna soci nel 2009.
Epigrafe nel portico della Pieve del borgo bergamasco di Dossena, a 40 km dalla sua terra di Caravaggio dove si legge: «In tempi di dura carestia, al popolo di Dossena qui adunato a suono di campana, venne offerto frumento in cambio dei suoi qaudri. Ma la forte gente di questa terra a una voce il baratto rifiutò. Ed i suoi quadri prescelse e la sua fame».
Il Fontana “espatriato”
Articolo pubblicato sul Corriere della Sera, pagine milanesi, 26 agosto.
In questi giorni si è chiusa al Museo d’Arte moderna di Parigi una straordinaria mostra dedicata a Lucio Fontana. È una mostra che ha riscosso un grande successo di pubblico e che tra l’altro racconta a un pubblico internazionale una grande stagione di Milano. Ad esempio è stato ricostruito l’Ambiente spaziale, la storica installazione realizzata nel 1949 alla Galleria del Naviglio, installazione che aveva consacrato Milano come avamposto dell’innovazione artistica in quegli anni. Fontana era nato in Argentina da papà italiano e mamma sudamericana, ma la sua vita artistica ebbe come centro Milano e in particolare il mitico studio di corso Monforte, dove venne immortalato da tanti grandi fotografi e da Ugo Mulas in particolare.
Quella parigina è una mostra che sarebbe stato bello vedere a Milano, per la qualità altissima dei prestiti, per i tanti filmati rari o anche inediti, e per la documentazione precisa di tutta la parabola di Fontana. Tra i prestiti in particolare ce n’è uno che fa un po’ sussultare: è il monumentale “Torso italico”, un capolavoro in ceramica del 1938, che sino a pochi anni fa era visibile nell’atrio di un condominio milanese, in via Panizza 4, di proprietà degli eredi dell’architetto Giancarlo Palanti (un’opera importante a cui uno dei curatori della mostra parigina, tra i maggiori conoscitori dell’artista, Paolo Campiglio, ha dedicato un libro, di prossima uscita da Scalpendi editore). Lì l’aveva vista, solo nell’agosto di due anni fa, il giornalista del Corriere realizzando un bel servizio sulle opere di Fontana a Milano. Oggi quella scultura è in mostra a Parigi come proprietà di una grande galleria tedesca, che in questi anni ha raccolto tanti pezzi eccezionali, in particolare del Fontana ceramista.
Certo, desta rimpianto questa perdita, avvenuta quasi in contemporanea con il ritiro, da parte dei proprietari, delle due bellissime sculture che facevano il vanto del cinema Arlecchino. Sono tutte opere che documentano un momento davvero alto della cultura milanese, in cui artisti d’avanguardia erano coraggiosamente chiamati a interventi importanti nel tessuto della città, per quanto su commissione di privati. Fontana in particolare ha lasciato molti di questi segni, dalle decorazioni sul condominio di via Senato, alle balconate ceramiche in via Lanzone, dal soffitto della sede dei Carabinieri in via delle Fosse Ardeatine, sino al grande bassorilievo con Santa Margherita Alacoque e alla via Crucis in San Fedele. E l’elenco potrebbe continuare a lungo.
Milano ha certamente reso un giusto riconoscimento alla grandezza di Fontana dedicandogli la grande sala del Museo del 900 che si affaccia su Piazza Duomo e che suggestiona, con quel suo fantastico neon volante, chiunque dalla piazza alzi lo sguardo. Ma per raccontare la città ai tanti che verranno a scoprirla per l’Expo, rendere più visibile la presenza nevralgica di questo grande artista sarebbe strategia molto efficace. Per dimostrare come la forza di Milano sia stata quella di saper integrare pienamente nel proprio tessuto anche intelligenze innovative e audaci, come quella di Lucio Fontana.
Appunti piovosi di viaggio (Parigi e Londra)
Di Piano in Piano
Prima a Trento, al nuovo Muse e al quartiere delle Albere. Un Piano molto calligrafico, attento ad integrarsi con il contesto, a non fare troppo rumore. Il Muse è bello, con una sua poeticità che in qualche modo indirizza anche il contenuto. Il quartiere invece ha un che di troppo “dirigista”, con tutto quelle sue preoccupazioni di sostenibilità che alla fine lo rendono freddo, poco plasmabile da chi ci vive. È un po’ un villaggio vacanze, sobrio ed elegante. Un paio di settimane dopo sono a Parigi e Londra. E lì si incontra un altro Piano. Quello del Beaubourg e quello della “scheggia”: datano 40 anni l’uno dall’altro, ma li unisce la carica trasgressiva rispetto al tessuto. È il Piano che esce dal seminato, che osa, che accetta la sua funzione di mettere a nudo equilibri troppo fittizi. The Shard si alza come una guglia gotica impazzita, con quel finale divaricato e drammatico, quasi un grido; quasi una bocca di un uccello affamato. Ci vedo anche un’assimilazione architettonica di visioni come quelle di Franz Kline. Una grande intuizione formale, che lascia il segno negli occhi.
Il complesso Pompidou
Il Beaubourg è sempre quell’astronave affascinante e piena di mille anomalie. Ma la macchina interna è in grande affanno. C’è una stanchezza nel capirne la funzione, biblioteca a parte. Divora gente, ma non si capisce bene per fare e vedere cosa. L’allestimento del museo in questo agosto era qualcosa di sconcertante. Una parte storica tutta pasticciata, seguendo un filo delle riviste che hanno fatto la storia del secolo, ma senza un minimo di continuità e di coerenza. Qualche capolavoro spuntava qua e là, perché tenerli in deposito è un controsenso. Sono 25 anni dalla grande mostra Les Magiciens de la Terre. Il complesso verso le culture altre è tutt’altro che risolto. I due piani del museo sono pieni di opere acquisite da ogni angolo del mondo. Ma affastellate senza criterio e con un livellamento complessivo che lascia solo una sensazione di confusione. Dobbiamo pur convincerci che il ritratto di Monsieur Pellerin di Matisse è qualcosa che non ha bisogno di una par condicio con una pur nobile scultura africana per legittimare il proprio spazio di muro…
La macchina della Tate
Al confronto con il complessato cugino parigino, la Tate sembra una macchina da guerra. Due mostre straordinarie (Matisse e Malevitch), un cantiere esterno che già svela l’enorme ampiamento, firmato sempre Herzog De Meuron: un corpo geometrico ruotante altissimo, che con uno spigolo s’appoggia sulla Turbine Hall. Nella presentazione del progetto si nota che l’investimento sulla parte eductaional è enorme e che gli spazi nuovi sono in buona arte pensati per quella funzione. Così vanno i grandi musei… Non convince invece, come sempre, il criterio espositivo tematico che da sempre caratterizza la Tate Modern. Ogni volta ci si trova davanti a soluzioni superficiali ed arbitrarie. Mi chiedo perché quando si affronta il 900 non si possa proporre un percorso storico, come un museo d’arte antica. C’è sempre bisogno degli effetti speciali curatoriali (vedi anche alla Gam di Torino). Cioè la mostra che si mangia il museo…
Le chiese di Parigi
Difficile che venga voglia di entrarci. Hanno un che di esagerato e respingente. Ma stavolta mi sono preso l’impegno di vincere la ritrosia, anche per vedere un po’ di quadri che comunque vi sono custoditi. Entrarvi fa sentir grati di essere italiani: non c’è mai senso dell’architettura in questi edifici così magniloquenti, né quando perpetuano un gotico con due secoli di ritardo, né quando si prendono la rivincita dai violenti sgarbi della rivoluzione. Basta alzare lo sguardo verso le volte dell’immensa Saint Eustache: le volte si reggono con un groviglio disperato e insensato di archi. Si vedono bei quadri, qua e là. Magnifico Simon Vouet a Saint Nicholas des Camps, con gli apostoli che “stregati” dal sepolcro lasciato vuoto dalla Vergine; disperato Delacroix nella Pietà di Saint Benoît (nel Marais) ispirata chiaramente dalla Deposizione di Rosso Fiorentino del Louvre.
Longhi 1914. Scrivere di storia dell’arte con la Guerra alle porte
«Infine vale ancora la pena di parlare d’arte o di pittura nel tardo Novembre 1914, sotto il brontolio della battaglia della Francia: se i soldati hanno freddo nelle trincee allagate io non ho caldo quassù, e voi sapete quanto sia grave pensare e scrivere a mani fredde». Esordiva così il giovane Longhi, giusto 100 anni fa, in un saggio che rileggo aprendo quasi a caso il suo libro con gli inediti giovanili (Palazzo non finito). È un saggio da “battaglia”, contrassegnato da una magnifica spavalderia: Longhi si permette giudizi tranchant verso l’arte nordica (il gotico come “maledizione di tabernacolini”), si lancia in una crociata per obbligare a distinguere ciò che è arte da ciò che è solo boria per innovazione tecnica (la pittura ad olio dei fiamminghi, che scivolano in “calligrafa degenerazione”, in “limpidezza banale”, in “ribrezzo lucertolare”). Certamente c’è da storicizzare. È il Longhi idealista, crociano, italofilo. Ma è anche il Longhi che inizia a a mettere a fuoco l’intuizione sulla centralità di Piero (il primo saggio su Piero è proprio dello stesso anno), che capisce come lo stile non sia solo una questione stilistica ma di elaborazione e visione del mondo. Quella a cui si dedica è quella storia che parte «dalle accettate e volontarie costrizioni create per la prima volta dai grandi romanici d’Italia e sollevate a sfere di classiche da Giotto e Michelangelo». È la storia della forma contro quella della “de-forma”…
Ma più che la pars costruens in queste pagine è fantastica la pars destruens. Così linguisticamente avvincente da diventare quasi diabolicamente convincente… verrebbe quasi voglia di proprorne un’antologia…
«Contorto di gotico questo paesaggio barocchio e cartoccioso, questo paesaggio raccontativo, topografico e non cosmico»; «…angoli sgnagherati, finestre cul di bottiglie…»; «questi tiranni inebetiti di borghesi; questi ermeiti abbruttiti di noia; questi piccioni di spirito santo…»; «questa grazie di porcospino…»
I giudizi ovviamente verrano presto rivisti, e saggiamente equilibrati. Ma nella vitalità di queste pagine si vede già lo scarto grazie al quale Longhi ha fatto diventare la storia dell’arte qualcosa di umanamente appassionante. Persino per chi in quel 1914 stava in trincea