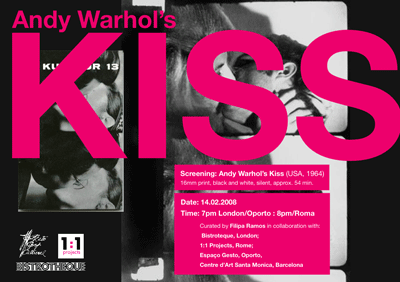«Caro Thelonious Monk, ho avuto l’occasione di ascoltarla la notte scorsa grazie ad una fortunata coincidenza inaspettata… ». Vi dicessi di indovinare chi è il mittente di questa lettera spedita al grande jazzista americano il 22 aprile 1961, non ci arrivereste mai… Ebbene, è Giorgio Morandi. Che scrive da Bologna dopo essere stato la sera prima al teatro Lirico di Milano al concerto di Monk. La lettera è pubblicata su Exibart on Paper (tks a Giovanni che me l’ha segnalata). Fa effetto pensare al riservatissimo (quasi scontroso) e ormai anziano Morandi che, prima si lascia stupire dai suoni di un musicista così lontano dai suoi mondi («… ho ancora impresso il movimento delle sue dita tese come bacchette sulla tastiera, che invece di muoversi velocemente scolpivano il ritmo con un’economia di note sorprendente»: l’economia di note, ecco una categoria molto morandiana…). E poi prende carta e penna senza lasciar passare tempo per raccontare per iscritto a Monk molto più che una semplice impressione. È come una confessione aperta a un uomo che è bastato un attimo per sentire amico. Ecco alcuni passaggi della lettera. Inutile sottolineare che è di un’acutezza spiazzante. E che verrebbe voglia di ripassarsela a memoria tanto accarezza le misteriose dinamiche del fare arte.
Le ragioni di questa lettera provengono da alcuni interrogativi recenti, a cui la sua musica, con modalità a me sconosciute, sembra rispondere. La ricerca artistica genera sempre domande a cui, in alcuni casi, soltanto l’autore può dare risposta e quando questa risposta non si genera dall’interno del proprio linguaggio, l’ascolto di ieri mi conferma che può giungere dall’esterno… Le scrivo a riguardo una confidenza di quelle che si fanno ad una persona sconosciuta che in un particolare momento della propria vita si percepisce come un amico di vecchia data. Le spiego meglio. Da circa un mese lavoro, nella mia casa di Grizzana, ad una serie di paesaggi in cui cerco un nuovo rapporto spaziale e cromatico tra gli elementi della composizione. Così per qualche giorno ho installato il cavalletto nel giardino di fronte ai due alberi da cui si intravvede nel retro uno scorcio della casa, costretto però a lasciare puntualmente la tela bianca dopo essermi arreso più volte.
La sua musica, se mi permette signor Monk, mi sembra di questa qualità, in grado di cogliere l’essenza di un discorso musicale calato non tanto nella capacità dell’autore di dare dignità allo strumento, quanto piuttosto del servirsene per metterlo da parte, lasciando il suono come unico protagonista della scena. Una stessa essenza che si rinnova nella forma, come in Bach o in Mozart, la cui arte è quella che scavalca civiltà e storia, attraverso un’utopia, tutta squisitamente umana, di dare un peso alla breve vita di un uomo.
Con rinnovata stima e gratitudine
Suo Giorgio Morandi