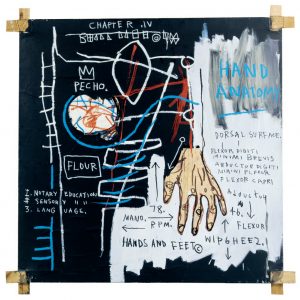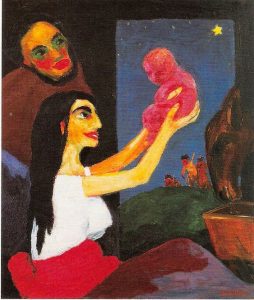Questo articolo è stato scritto per Il Sussidiario del 2 febbraio, giorno in cui si festeggia la Presentazione al Tempio di Gesù.
Per capire cosa significa essere un grande artista basterebbe osservare come sono state immaginate tante raffigurazioni della Presentazione al Tempio di Gesù . La dinamica dei fatti è elementare e non fornisce spunti spettacolari. È quasi una situazione da routine. L’immaginazione di un artista può tutt’al più fantasticare sulle architetture del grande tempio, può aggiungere dettagli nel descrivere i doni che Giuseppe porta con sé. In realtà in quell’episodio dalla dinamica così normale gli artisti si trovano a dover affrontare un qualcosa che esce dalla routine: ed è la figura dell’anziano Simeone. I quadri sono per antonomasia muti, non hanno parole, invece quell’episodio vive e fa sussultare ogni volta che lo si rilegge, proprio per delle parole che Simeone pronuncia: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo / vada in pace secondo la tua parola; / perché i miei occhi han visto la tua salvezza / preparata da te davanti a tutti i popoli, / luce per illuminare le genti / e gloria del tuo popolo Israele».
In sostanza il cuore della scena è un cuore verbale, e così all’artista tocca render quel cuore, lavorando solo sulla figura e facendola “parlare”. Guardiamo, ad esempio, quale strategia usa Duccio nella predella della Maestà senese: Simeone, si china e curva la sua vecchia schiena verso Gesù, che Maria ha messo tra le sue braccia. Già questo incurvarsi è un’immagine che parla, che racconta di un’attrazione carica di dolcezza. Ma Duccio aggiunge dell’altro: Simeone ha le mani coperte dal mantello in segno di rispetto e tiene una distanza devota dal Bambino. Gli occhi sono quelli logorati dall’uso di un sapiente anziano: ma lo sguardo è quello di chi consiste tutto in ciò che vede.
Giotto per natura è diverso. È un artista di corpi solidi e ben piantati per terra. Il suo Simeone alla cappella degli Scrovegni sta infatti saldo e a schiena dritta, nonostante l’età. Per questo Giotto gioca tutta la partita sullo sguardo, che è sottile, profondo, totale e che si incrocia con quello già pieno di consapevolezza del Bambino: una corrispondenza che davvero “parla” di una salvezza vista, incontrata, toccata.
«Lo prese tra le braccia», racconta il Vangelo di Luca: a volte gli artisti si concentrano sull’attimo che precede o su quello che segue. Mantegna, l’austero e “terribile” Mantegna, dispone le figure dentro una scatola spaziale. Simeone è di profilo e sta allungando le mani per prendere il Bambino in fasce: è ancora nella situazione di un attimo prima, cioé di colui che «aspettava il conforto d’Israele», come sempre scrive Luca introducendo l’episodio.
All’opposto di Mantegna c’è il grande e commosso Bergognone, lombardo capaci di straordinarie intensità affettive. Lui si sofferma invece sull’atto finale, la riconsegna del Bambino a Maria: il suo volto, nella sobrietà della vecchiezza, “parla” di una felicità che si è compiuta. È il momento del “Dimitte nobis Domine”.
Bisognerebbe poi raccontare dell’immenso Rembrandt, che dipinse la Presentazione in più varianti, sempre con una libertà interpretativa assolutamente moderna. Nella più folgorante (quella conservata al Museo di Stoccolma) sulla scena restano solo Simeone e Anna. Lui sta seduto, sprofondato in una vecchiezza quasi terminale: eppure, anche in quella condizione di sfinimento fisico, c’è spazio per uno stupore totale. È un quadro meraviglioso dell’ultimo Rembrandt, il quale, dipingendolo, parla a sé e per sé. Un quadro implorazione, verrebbe da dire, in cui l’artista chiede con parlando con i suoi colori rabbuiati, che anche a lui accada come a Simeone. È quasi una preghiera da guardare. Un quadro, in fondo, dipinto anche per noi.