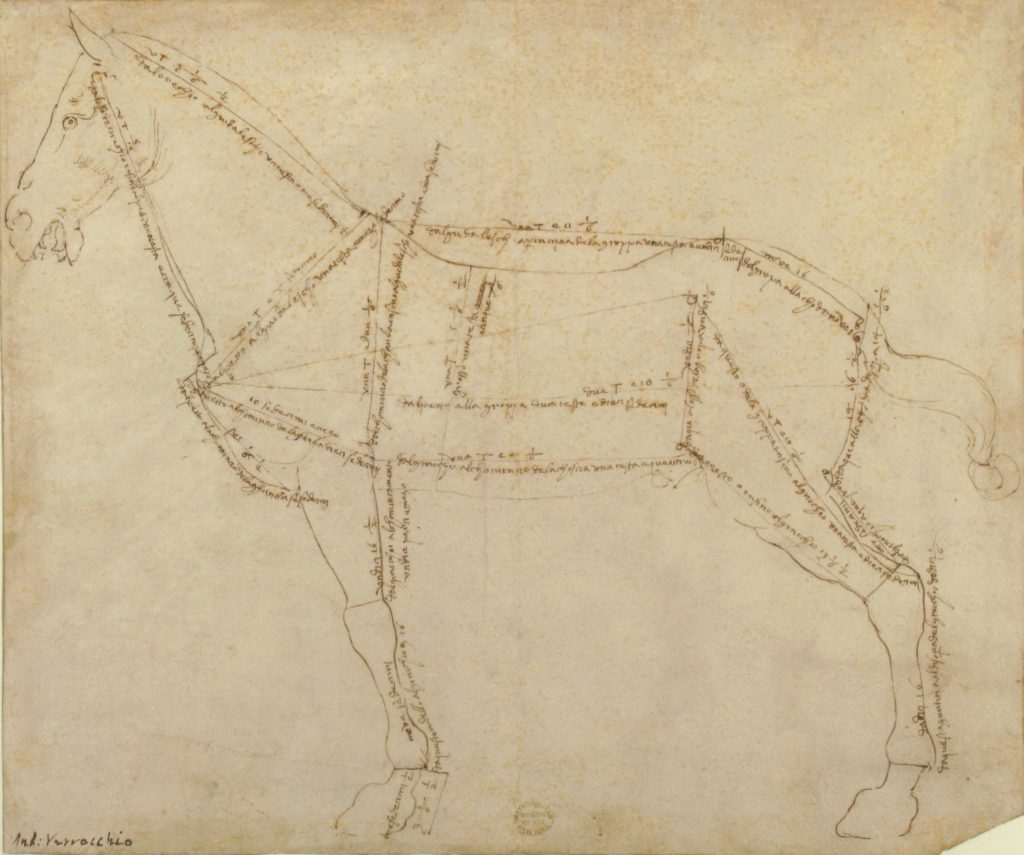Recensione alla mostra di Leoncillo Leonardi vista alla Galleria dello Scudo di Verona. Uscita su Alias, 3 febbraio 2019. Le foto della mostra sono di Agostino Osio – Alto Piano

«All’improvviso io mi sentii, come un vecchio ragno, la necessità di fare una tela traendo dal dentro di me stesso questa saliva mia, fatta del mio corpo presente, esaurendomi in questo atto sicuro, sicuro come gli atti elementari della vita». È una delle prime pagine del Piccolo Diario di Leoncillo, datata 1957. Per l’artista spoletino è un momento chiave di presa di coscienza e di distacco anche radicale dal proprio recente passato: «Nel 1957 mi cascarono addosso i miei ultimi dieci anni e io ne restai sconvolto, del tutto smarrito», scrive in un’altra pagina di quel meraviglioso testo, dove le parole sembrano correlarsi in modo sempre stringente al farsi della sua “nuova” scultura. Come sottolinea Enrico Mascelloni, uno dei più profondi conoscitori della sua opera, «Leoncillo mette in campo dal 1958 una tra le più vertiginose esperienze dell’arte dei suoi anni: recuperare la ragione profonda della forma, e persino le forme sue, quelle che aveva modellato sin dagli anni trenta, procedendo alla loro radicale negazione».
È una doppia occasione quella che riporta l’attenzione su Leoncillo. Da una parte Skira ha pubblicato il Piccolo Diario, con riproduzione in fac simile dei fogli dattiloscritti volanti che lo compongono oltre alla loro trascrizione. Dall’altra la Galleria dello Scudo a Verona propone una selezione, curata dallo stesso Enrico Mascelloni, di 16 lavori dell’ultima stagione dello scultore, avviata proprio a partire da quella “radicale negazione” della propria storia. Una selezione ampia e molto rappresentativa, se si pensa che il catalogo degli ultimi 10 anni di Leoncillo, contando le sculture di ogni dimensione, non supera le 150 opere. Tra queste i grandi lavori, cioè quelli che lo hanno reso celebre, non sono più di 40: oltre un terzo sono dunque raccolti negli spazi della galleria veronese.

La rottura di Leoncillo con il suo passato si consuma attorno alla realizzazione dell’ultima opera pubblica, il “Monumento ai Caduti” oggi sul lungomare di Albisola. È in quella situazione che l’artista avverte tutta l’inadeguatezza formale di un lavoro nato da un’idea (un’idea culturale e politica che Leoncillo aveva pur sempre fatta sua, essendo comunista convinto). «Avevo pensato al fregio dei caduti come un bel teatrino, ogni morto con la sua posa diversa, “composta” come le altre. A poco a poco i fondi mi vennero avanti, i morti mi affondarono tra i detriti, le oscurità, le fratture del terreno… Ero io stesso quei morti», scrive nel foglio 19 del suo Piccolo Diario. È una confessione che fotografa la transizione, quasi lo scivolamento ineluttabile da una scultura di contenuto, ad una radicalmente autobiografica: «Lo scrupolo mio più forte è quello della verità, voglio dire la verità ed oggi non vedo altro modo di dirla in modo sicuro che quello autobiografico: offrire semplicemente la propria testimonianza» (Piccolo Diario, foglio 24). In questo modo Leoncillo affrontava di petto il problema drammatico messo sul tavolo da Arturo Martini nel 1945 con le sue celebri riflessioni sulla scultura come “lingua morta”: curioso il fatto che anche Martini si fosse affidato alla metafora di un insetto. «L’artista», aveva scritto, «è come il baco da seta che nello spurgo trova la sua trasparenza». Leoncillo, come detto, si affida invece alla metafora del ragno, che «trae la sua tela dal dentro» di se stesso.

Nel Piccolo Diario questo concetto è ribadito in continuazione, con straordinaria autoconsapevolezza. Leoncillo parla dell’arte come di «un’espressione che nasce da una necessità interna»; di una volontà di «esprimere la contraddittorietà dei miei sentimenti, andarci lentamente dentro per trovarne il nucleo profondo». Racconta di un’esigenza di «dire semplicemente le cose mie. Come gli ubbriaconi che di notte ti vogliono dire i loro fatti. Come chi è innamorato e racconta anche ciò che non dovrebbe. Come chi ha avuto un gran dolore, una gran perdita, che di notte al buio nel letto ripete ancora certe parole a voce alta e poi le parole diventano fuori di lui nel silenzio della notte ormai un’altra cosa».
Riportata all’osso di questa esigenza elementare, la scultura torna così a vivere, in quanto forma che nasce da «atti che traducono il nostro essere»; è «sentimento che prende immagine». Per questo Leoncillo senza nessuna retorica può arrivare ad affermare che «la creta è come carne mia»; o, con ancor più chiarezza, che «la creta diviene materia nostra per gli atti che compiamo su di essa e con essa, atti che nascono da una reazione del nostro essere».

Attraverso le parole eccoci dunque arrivare sul corpo e nel corpo della scultura “nuova” di Leoncillo. La prima constatazione da cui non si sfugge è che siamo davanti a forme mutilate. Il taglio è il segno più incontrovertibile di queste ripetute mutilazioni. Tagli secchi, quasi che una lama di ghigliottina fosse calata sulla creta. È lo stesso gesto che aveva segnato l’arte di Lucio Fontana, ma se in quel caso il taglio era rimasto dentro una dimensione aniconica, qui accade l’opposto. L’atto che amputa la materia, in realtà finisce con l’aprirla come un forcipe, che libera forme di inedita potenza. Sono forme ricondotte ad un’elementarità ancestrale ma sempre decifrabili, che siano corpi, o zolle arroventate o coaguli di incubi. Il taglio di Leoncillo è un’operazione che ferendo con precisa determinazione la creta, in realtà immette vita attraverso un corto circuito espressivo che dopo oltre 50 anni non ha perso un briciolo di forza e di suggestione. Il taglio ha poi un altro valore: è infatti un gesto fondamentalmente meccanico, che recidendo la materia recide anche qualsiasi rischio di cedimento ad un soggettivismo plastico. Al contrario, come ha sottolineato giustamente Mascelloni, è la Storia con la sua implacabile oggettività a rientrare in campo «in un corpo a corpo portato alle estreme conseguenze». È infatti proprio la Storia «inaggirabile e tirannica» a sottoporre a costante pressione, dentro uno spazio claustrofobico, le forme dell’ultimo Leoncillo.
Ma Leoncillo ogni volta dimostra di saper rompere l’assedio e di dar luogo a geniali palingenesi. Lo si vede nelle proiezioni verticali dei suoi San Sebastiani, che si alzano trainando verso l’alto la loro massa di monoliti tormentati. Si appoggiano su sottili basi di legno dal sapore instabile che lo scultore ha congegnato per rafforzare la dimensione “anti monumentale”. Il bianco degli smalti ci parlano poi di una luce che si incrosta, di uno splendore che si fa largo da sotto la pelle della materia. In mostra a Verona un cannocchiale visivo collega i due San Sebastiani datati 1962, con “Tempo ferito” dell’anno successivo, uno degli esiti più alti di Leoncillo: qui davvero il taglio sembra liberare il tumulto della Storia, che come un magma rosso divarica la massa nera, facendola balzare verso l’alto, anche a dispetto del suo peso.
Se la verticalità è la dimensione a lui più congeniale, quella che meglio esprime la solitudine radicale del suo fare, Leoncillo sorprende nel momento in cui sceglie la soluzione ardita e opposta di una scultura tutta orizzontale. È il caso stupefacente di “Vento Rosso” del 1958, opera “sdraiata” e appoggiata a livello terra su una lastra di lavagna dove la creta ribolle, con quei neri cupi e quei rossi brace. È un’intuizione con la quale Leoncillo sembra precorrere addirittura soluzioni proprie della “land art”. Anche se la sua orizzontalità non ha nulla di distensivo e pacificante, ma assomiglia a quella del soldato che striscia nella sua trincea.