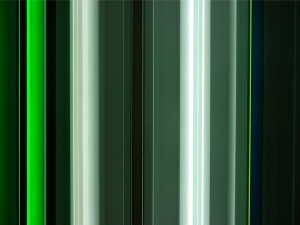«Il collezionista in qualche modo lascia la sua anima nella collezione. Quando essa diventa pubblica, il collezionista per così dire le appartiene».
Sono parole di Giuseppe Panza, tratte dal libro che raccoglie le conversazioni con Philippe Ungar (Giuseppe e Giovanna Panza collezionisti, Silvana editoriale, 2011). L’“anima” nel caso di Panza coincide con quella tensione spirituale che lo ha guidato nelle scelte degli artisti e delle opere, creando un cosmo perfetto in cui ogni frammento si trova ricomposto dentro un insieme coerente. A 10 anni dalla morte del grande collezionista, avvenuta il 24 aprile del 2010, il Fai, oggi proprietario della villa di Biumo, ha deciso di ripresentare l’allestimento integrale originale della collezione permanente, secondo i criteri museografici indicati da Panza stesso al momento della donazione nel 1996. È un allestimento che dimostra in modo palese quella «stretta relazione tra il suo “occhio esplorativo” e il suo pensiero che hanno fatto di lui uno tra i più importanti collezionisti del Novecento», come ha scritto Anna Bernardini, direttrice di Villa Panza. A distanza di anni si potrebbe pensare che l’orizzonte di una collezione come questa sia ormai ampiamente storicizzato e in un certo senso “musealizzato”. Invece il riallestimento mette in evidenza proprio come quell’“occhio esplorativo” di Panza, agisca, sorprenda ed emozioni ancora il visitatore. Ce ne si rende conto ad esempio entrando nei meravigliosi spazi delle Scuderie, che ora accolgono una grande scultura in legno di Martin Puryear, artista afroamericano, protagonista del padiglione Usa all’ultima Biennale. S’intitola “Desire” ed è un’opera di straordinaria perizia artigianale, che si slancia nell’ambiente luminoso con l’afflato proprio di uno struggente desiderio: da una gabbia rovesciata, che suggerisce lo stato di costrizione delle popolazioni nere, parte una lunga asta che si fa perno di un’immensa ruota di bicicletta, evocazione incantata di un sogno di liberazione. L’opera è del 1981 e lascia stupiti pensando a come l’occhio esploratore di Giuseppe Panza sapesse inoltrarsi anche nei territori periferici del minimalismo americano, accettando la scommessa di opere così materialmente impegnative. C’è infatti un aspetto pionieristico nel suo stile collezionistico, che convive perfettamente con quell’ansia di rarefazione formale che fa da modulazione di fondo dell’intera raccolta.
Così si spiega la predilezione per un artista formidabile come Allan Graham, che occupa una sala del primo piano, con quelle sue opere dalle forme che esplodono dentro i telai, ibridi tra pittura e scultura, dense di un’energia primitiva, tutte costrette nella rigorosa elementarità del nero e del bianco.


Si coglie spirito pionieristico anche nell’attenzione ad un artista che lavora sul suono, senza essere musicista, come Michael Brewster. La sua installazione, che occupa una stanza sigillata da ogni fonte luminosa nell’ala dei rustici, è appena stata restaurata e rimessa in funzione. “Aerosplane” è una scultura acustica che riempie lo spazio plasmando una serie di rumori confusi di un aereo: anche in questo caso Panza è affascinato sia dal rigore formale dell’operazione, sia dalla capacità dell’arte di mettere in atto un’espansione sensoriale. La Villa per Panza è infatti anche terreno di sperimentazione di nuovi criteri estetici e museografici, come nel caso delle celebri sale dedicate a Dan Flavin, dove il collezionista propone e alla fine impone un’idea di allestimento inedito ed emotivamente forte per le sculture luminose dell’artista americano.
Altro tema a cui Panza si dimostra sempre molto sensibile è il dialogo con il contesto e in particolare con lo scenario naturale che circonda la Villa: in tanti casi la relazione interno/esterno diventa la leva che molti artisti hanno usato per installazioni site specific entrate nella storia dell’arte contemporanea, quelle di Robert Irwin e di James Turrell su tutte. La natura è vista da Panza naturalmente non in senso naturalistico, ma in quanto proiezione verso un’idea di infinito: anche nel caso dell’infinitamente piccolo, il che spiega la predilezione negli ultimi anni per le opere di Christiane Lohr, con le sue sculture vegetali minuziosamente costruite con materiali essiccati.
Infine un’altra dimensione centrale della collezione è certamente quella del tempo. È un’idea di tempo sottratto all’erosione della transitorietà, un tempo sospeso nella calma di tante opere, come i grandi monocromi di Phil Sims o le trame infinite delle tele di Ann Fredenthal. Un tempo che ha a che fare con quell’aspirazione all’assoluto che stava sempre al cuore delle scelte di Giuseppe Panza. Speriamo dunque arrivi presto il tempo per poter inoltrarci alla riscoperta di questa collezione, che è unica anche per la capacità di aprire orizzonti al di là delle tante ansie di una stagione come quella che stiamo vivendo.
Pubblicato su Alias, 12 aprile 2020