Venerdì scorso presentazione del libro di Mariella Guzzoni su Van Gogh con Rocco Ronchi, alla Biblioteca Sormani. Personalmente ho insistito su quel punto chiave della storia di VG che è il momento in cui decide di immaginarsi pittore. È il 1879, quando racconta al fratello dell’incontro con il reverendo Pieterszen, che lo aveva spinto a continuare sulla strada dei disegni realizzati in quei mesi nel Borinage. Scrive nella lettera: «Spesso sto a disegnare sino a tarda notte per fissare qualche ricordo e per rafforzare i pensieri che mi arrivano in mente da soli nel vedere le cose». Rafforzare i pensieri: è un’indicazione chiara quella di Van Gogh. La pittura è uno strumento per meglio vedere, che significa rafforzare la presa di pensiero sulla realtà. L’anno dopo il 24 giugno 1880, scrive un’altra lettera, la prima in francese, di una lucidità ancora più decisiva: «J’ai preferé une mélancholie active qui aspire, qui espère et qui cherche à celle qui morne et stagnante désespère». la malinconia che che spera, che aspira e che cerca: “Ora sono in cammino” scrive non a caso nel settembre di quell’anno, poco prima di lasciare il Borinage e andare a Bruxelles per un corso di pittura.
Si capisce qual è la necessità di essere pittore, che va oltre la rappresentazione dei soggetti, ma come ha detto bene Ronchi, riguarda l’apparire dei soggetti. La pittura di VG è una pittura dell’apparire, non di ciò che è già apparso. O meglio la sua pittura porta in superficie l’apparire di ciò che è già apparso. Quella condizione che è slegata alla contingenza e che trova una chiave sintetica in un’altra parola suggerita da Van Gogh in una sua lettera del 1883: «sarò pittore, uomo o cane, enfin un uomo con sensibilità». La pittura di Van Gogh parla una lingua che alla fine va oltre se stessa, si libera da se stessa, perché si trasfigura in sensibilità. Una sensibilità più larga, un’aura, un accensione. Anche Testori nella introduzione al volumetto con tutte le opere di VG di Sansoni, scrive che VG rappresenta l’atto finale della pittura. Per questo pensare che l’espressionismo sia quel che da Van Gogh discende è assolutamente fuorviante. Piuttosto ci vedo Klein e la sua folle idea di vendere sensibilità artistica. (Tutti ragionamenti possibili grazie agli spunti che un buon libro garantisce. E quello di Mariella Guzzoni è appunto un buon libro) .
Borinage, 1880. Quel primo passo di Van Gogh nella pittura
Wenders, il sole sopra Ground Zero
La bella mostra con le foto di Wim Wenders curata da Anna Bernardini a Villa Panza ha il suo apice nella scuderia piccola, dove sono “raccolte” le foto scattate Ground Zero. Sono immagini che tolgono il respiro, ma che insieme al senso di disastro riescono a comunicare una inspeigabile dimensione di speranza. Le parole di Wenders nell’intervista pubblicata in catalogo spiegano, con molta umiltà, l’origine di questa speranza.
Domanda: Dopo l’attentato alle Twin Towers sei andato a fotografare Ground Zero, apoteosi di qualsiasi maceria e archeologia, relitto di un millennio appena cominciato, simbolo per eccellenza della conclusione di un’intera epoca. Perché hai scelto di utilizzare la fotografia per documentare la fine di molte cose? Credi che sia questa la natura (o il destino) di questo mezzo? Immortalare?
Wwnders: Direi diversamente: testimoniare il tempo. Forse è la stessa cosa… Ma c’era qualcos’altro in quel desiderio di fotografare Ground Zero. Una sensazione di impotenza. Tutti avevamo visto le torri cadere, aggrappati ai televisori senza riuscire a credere ai nostri occhi. In realtà, dopo qualche giorno, desiderai di non aver mai visto nulla di simile! Avrei voluto cancellare quelle immagini. Ma non potevo. Nessuno poteva. Avevano letteralmente invaso la nostra coscienza. Per quanto mi riguarda, avevo gli incubi e mi svegliavo madido di sudore freddo. Mi sentivo come se avessi preso un brutto virus da cui non riuscivo a guarire. Così andai a New York, convinto che avrei potuto curare questa malattia solo vedendo le cose con i miei occhi. All’epoca, nessuno poteva più accedere a Ground Zero. L’intera zona era off-limits per i fotografi. Il sindaco di New York aveva autorizzato un solo fotografo, Joel Meyerowitz, a recarsi sul posto in veste di testimone ufficiale, e Joel ci andava ogni giorno. Essere presente e seguire i lavori era per lui un preciso dovere. Joel fu molto generoso e un giorno mi portò con sé. Fece una fotocopia del suo permesso in cui mi inserì come suo “assistente”. Andammo a Ground Zero il mattino presto e ci restammo diverse ore. Joel conosceva ogni vigile del fuoco per nome. Ce n’erano molti che lavoravano lì, spalando macerie e soprattutto cercando resti umani. Era un enorme cimitero. Al centro, il terreno fumava ancora. C’era un odore terribile, pungente. Tutti lavoravano in silenzio, con il viso coperto da una maschera. C’era una sensazione di grande dolore e di serenità. Ogni tanto si sentiva un segnale, una sirena che annunciava il ritrovamento di qualcosa da parte di una delle tante squadre. La gente si toglieva il cappello e c’era un momento di silenzio assoluto, poi tutti si rimettevano al lavoro in quell’inferno. Enormi camion spruzzavano acqua per evitare che la polvere si alzasse e volasse ovunque. Joel e io continuavamo a fotografare anche nel silenzio, senza scambiarci parola. Avevo portato la mia macchina fotografica panoramica, per essere in grado di cogliere l’ampiezza del luogo, e la natura stessa delle foto che scattavamo ci costringeva a rivolgere lo sguardo soprattutto verso il basso. All’improvviso vidi una luce diversa splendere attraverso la polvere e il fumo. Sollevai lo sguardo e mi resi conto che il riflesso del sole aveva immerso per qualche istante Ground Zero in una luce accecante. Era ancora mattina, e fino a quel momento i grattacieli intorno avevano impedito ai raggi del sole di illuminare direttamente lo spazio rado di Ground Zero. Ma adesso gli edifici circostanti contribuivano a deviare la luce. Anche gli operai lo notarono. Vidi Joel guardare su, incredulo, borbottando di non aver mai visto nulla di simile in tutti i suoi giorni “di servizio”. Non durò a lungo, e il sole scomparve di nuovo. Ma in quei momenti, nelle poche foto scattate con quella luce, mi sembrò di essere il testimone di un messaggio che il luogo stesso ci consegnava. Era un messaggio di pace. Quel luogo aveva visto un orrore indicibile. Ma ora, per un attimo, mostrava un lampo di bellezza surreale che voleva dire: “Il tempo guarirà le ferite! Questo luogo guarirà! Questo paese guarirà! Ma tutto ciò non deve essere la causa di altri morti! Non lasciamo che questo diventi motivo di ulteriori orrori…”. Questo è ciò che ho capito mentre scattavo le mie foto in quegli attimi beati. E sì, spero di aver immortalato quel messaggio. Anche se in seguito la politica non ha seguito questa strada, provocando la delusione e lo sgomento di molti. La politica ha deciso di iniziare una “guerra contro il terrorismo”, una combinazione assurda di parole, tanto per cominciare. Quella politica non ha fatto altro che ingrandire il danno compiuto. Per una scheggia di tempo, per un brevissimo intervallo, c’era stata una diversa opportunità, una possibilità di pace e solidarietà sul nostro pianeta. La gente di tutto il mondo, indipendentemente dalla razza, dalla nazionalità o dalla religione, si era ribellata contro l’atto compiuto a Ground Zero. C’erano funzioni e cerimonie celebrate da tutte le grandi religioni del mondo, unite. Era un’esplosione di desiderio di pace! Ma la politica americana ha frainteso tragicamente la situazione, e si è imbarcata in una assurda vendetta, invadendo un paese che non aveva niente a che fare con l’attacco a Ground Zero, e giustificando le proprie azioni illecite con bugie e motivi fasulli.
Moroni a Piccadilly Circus
Ultimo weekend per la mostra di Moroni alla Royal Academy di Londra. I numeri dicono che è stato un successo, con 90mila visitatori. Nella metropoli globale, ipermulticulturale l’appordo di un maestro “incistato” nel fazzoletto di terra (o più precisamente, di provincia) che l’aveva visto nascere, poteva essere un azzardo. Invece Moroni ha attirato a sé e conquistato occhi così geneticamente lontani. È interessante capire che cosa quegli occhi abbiano visto nei suoi personaggi; probabilmente hanno intercettato substrati che il nostro occhio troppo affezionato, troppo sentimentalemente coinvolto, ci impedisce di cogliere. Purtroppo a Londra non ci siamo potuti andare ma l’amico Simone Facchinetti che ha curato la mostra ci ha fatto avere queste immagini dell’allestimento, scattate da Lidia Patelli. Immagini che sono pubblicate in un libretto
Moroni a Londra riepilogativo di questa straordinaria trasferta.
Perché Roy Lichtenstein sembra sempre nuovo?
Recensione della mostra Lichtenstein, Opera prima, alla Gam di Torino, uscita su Alias domenica 18 gennaio.
(l’immagine è una foto dello studio di Lichtenstein di Ugo Mulas, vista sabato alla mostra della Galleria Lia Rumma: una foto che “fotografa” meglio delle mie parole quel che ho tentato di dire nella recensione)
Interessante destino quello di Roy Lichtenstein. Artista a una dimensione, programmato sui codici elementari della comunicazione mediatica, stranamente non smette mai di svelare prospettive inattese su se stesso. Si poteva pensare che dopo la grande mostra passata nel 2013 da Chicago a Londra e Parigi (recensita su Alias da Stefano Jossa il 18 marzo 2013), ci fosse poco da aggiungere, senza cadere nelle solite rassegne rimediate alla bell’e meglio per far cassetta. Invece Lichtenstein smentisce ancora una volta lo scetticismo dei nostri occhi collaudati: la mostra in corso alla Galleria d’Arte Moderna di Torino (sino al 25 gennaio, a cura di Danilo Eccher, catalogo Skira) riesce ad essere “inattesa”. Sin dal titolo si intuisce che l’approccio non è banale. Infatti introduce subito un’ambiguità: “Opera prima” può essere inteso come qualcosa di fondativo, di minimo comun denominatore dell’universo di Lichtenstein. Ma andrebbe anche letto, ribaltando i termini, e trasformandolo in un “prima dell’opera”: cioè tutto quel che riguarda il cantiere dei quadri più famosi dell’artista americano. Le due accezioni in realtà convivono, perché lo sperimentalismo proprio dei work in progress di Lichtenstein si muove all’interno di prototipi mentali non solo chiari ma anche dichiarati.
La mostra è quindi intrigante perché indaga su complessità e “problemi”, laddove conosciamo Lichtenstein proprio per il suo procedere sempre per semplificazioni. Ma le due azioni non entrano mai conflitto, anzi lavorano l’una per l’altra, come in un gioco di incastri in cui l’esito semplificato si rivela, a monte, più articolato di come sospettassimo.
Lichtenstein disegnava tantissimo, come racconta la moglie Dorothy nella breve testimonianza in catalogo. Disegnava ovunque, anche a casa, dopo tutta una giornata passata in studio. Strano a dirsi per un artista “parassita” che succhiava immagini da altre immagini, a partire dalla mitica appropriazione dei fumetti, scoperti a 40 anni vedendoli in mano ai suoi figli David e Mitchell. Ma le immagini per Lichtenstein costituiscono soprattutto momenti di attivazione di un lavoro che il percorso della mostra svela in tutta la sua sorprendente coerenza e disciplina. Diceva che «gli oggetti sono segni da organizzare, collegare e ricostruire in una visione unificata». E, ovviamente, assolutamente bidimensionale. È interessante notare come il procedimento preparatorio di Lichtenstein non preveda tanto l’appunto visivo o lo schizzo, ma si protenda subito in quello che Bernice Rose, nel saggio di catalogo, definisce “enclosure drawing”. I disegni infatti sono spesso chiusi dentro celle spaziali (il prestito dalla geometria propria dei fumetti è ben evidente) che richiamano già le proporzioni della tela finale e che vengono ricavati all’interno del foglio di carta. È dentro quelle celle, disposte senza un ordine preciso, che Lichtenstein lavora all’organizzazione delle sue visioni. Un lavoro che Diane Waldman, tra le maggiori conoscitrici del Lichtenstein disegnatore, ha sintetizzato come «unione di un’immagine reale con una forma astratta».
Lo schema della cella riquadrata sul foglio con un segno nero più o meno deciso, si ripete quasi per istinto anche laddove Lichtenstein sembra mettersi più disteso e libero, come nel caso della bella serie di cieli a matita e pastello del 1964 che troviamo in apertura di percorso. Trent’anni dopo, per il Chinese style landscape (Study), il dispositivo è ancora assolutamente lo stesso. Spiega Bernice Rose in catalogo: «L’artista costruì un mondo nuovo, strutturato su queste immagini, ma la sua costruzione dipendeva dalla creazione di una nuova realtà nella sua interezza. Perché questo accadesse, l’oggetto andava rimosso dal suo contesto abituale e scomposto nei suoi elementi costruttivi. Ecco perché Lichtenstein ripeteva che i suoi oggetti erano innanzitutto segni da organizzare, collegare e ricostruire in una visione unificata».
L’interesse della mostra consiste proprio nella messa a nudo di questo processo e nello disvelamento di quella coerenza interna propria delle immagini, mai create ab novo ma sempre rimontate da Lichtenstein. È questa coerenza che determina quel senso “sempre nuovo” delle sue opere, sulle quali il tempo sembra non lasciare nessuna patina. Figlie di una stagione ben identificata culturalmente e sociologicamente, in realtà riescono a sfilarsi da quell’identificazione. Il percorso si popola così di tante, continue reinvenzioni di quel mondo che Lichtenstein aveva davanti agli occhi. Un mondo in cui le immagini non hanno più gerarchie, perché sono tutte chiamate indistamente a far parte di questa “nuova realtà”. Emblematica ad esempio è quella sontuosa carta (sontuosa anche per le sue dimensioni: 2,44 m. di altezza) Picture and Pichter (Study) del 1978. Qui Lichtenstein ricorre a un meccanismo linguistico sofisticato, in quanto rappresenta sullo sfondo della brocca picassiana, un suo quadro filtrato dal consueto lavoro di ricomposizione. Eppure l’immagine s’impone al nostro sguardo – sinceramente ammirato – con chiarezza sia stilistica e senza nessuna ambiguità concettuale.
L’unico appunto per la mostra è la compressione del percorso, che ad un certo punto crea un inganno per via della sala alla fine del primo corridoio, in cui ci troviamo davanti un gioiello come il Landscape with boat del 1996 (con i relativi lavori di cantiere). La tela appartiene all’ultima stagione, straordinariamente rarefatta, di Lichtenstein. Quell’apparizione anticipata da una parte crea un cortoircuito nell’occhio del visitatore. Dall’altra però finisce con il darci la conferma di quanto sia coerente e tutta sempre perfettamente concatenata la parabola di Lichtenstein.
Wim Wenders a Villa Panza. L’America in interno lombardo
Apre la mostra delle fotografie di Wim Wenders a Villa Panza. Le immagini dell’allestimento parlano da sole: dopo Turrel e Irwin, continua il dialogo tra la Lombardia e l’America. Amo Wenders fotografo, perché è risucchiato dallo spazio americano, così cinematografico e così carico di suggestioni di infinito, così necessario al suo occhio da regista (ricordo sempre il suo magnifico “L’amico americano”). Lui dice: «Attraverso il mirino, colui che fotografa può uscire da sé ed essere dall’altra parte, nel mondo, può meglio comprendere, vedere meglio, sentire meglio, amare di più».
La parola alle immagini degli allestimenti.
Abbuffata di mostre alla torinese
Una giornata torinese con Angela, Teo, Ale e Carolina. Non ci siamo fatti mancare niente…


Castello di Rivoli. Sempre così bello e così vuoto… un vero delitto non riuscire a farlo decollare. Siamo lì per Sophie Calle, per le recensioni lette e per una bella e dettagliatissima mail ricevuta da Giulietta Riva dopo la visita alla mostra. Che è bellissima, disposta con molto amore e molto pudore, con piena consapevolezza della delicatezza del tema e del rischio di cedere a un voyeurismo. Souci è la parola chiave, l’ultima detta dalla mamma di Sophie prima di morire, che è una parola tenera e imprendibile. Souci è preoccupazione, inquietudine (ma la madre la pronuncia con un “non” davanti: non dovete preoccuparvi per me); ed è anche prendersi cura, avere a cuore. Ricamata sulle gentili tende divisorie tra le stanze, rievocata ovunque e in tutte le forme, è un po’ la risposta all’immagine sempre ritornante della/delle tombe. Souci è quell’alito alito di tenerezza che sopravvive alla morte della madre e che è così reale, da prendere questa forma di percorso/mostra. E diventando addirittura fatto pubblico, non più privato. Bellissima mostra, non perdetela. Dimostra quanto gli artisti di oggi sappiano spesso inoltrarsi nelle fibre più intime e segrete della vita. Non solo della loro.
(A margine: la mostra si apre con i video già noti girati da Sophie Calle a Istanbul, filmando cinque persone semplici che per la prima volta vedono il mare, pur abitandovi a pochi chilometri. Mi viene in mente quella pagina stupenda di don Giussani in cui immaginava lo sguardo di un uomo che avesse la ventura di nascere con la coscienza già di un adulto. Il video è quella “cosa” lì, quella commozione lì).
Al Castello c’è pure Manifesta Intenzione, una rassegna dedicata al “disegno in tutte le sue forme”. Non mi soffermo, ma la sala finale con i meravigliosi video di Kentridge alle prese con i disegni da sola vale la visita. Si capisce che per disegnare si deve essere un po’ maliardi.
###################################################################################
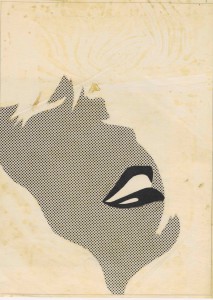
Gam. La sorpresa della giornata è la mostra su Lichtenstein. “Opera prima” (titolo della mostra) significa che è un’indagine sulla genesi delle sue opere, e quindi ancora una volta sul disegno e sul pensiero che vi sottostà. Sorpresa, perché di Lichtenstein sembra di aver visto anche troppo. È tutto sempre così dichiarato, sempre estrinseco, anche programmaticamente piatto, che non si capisce cosa ci sia da scoprire. Invece c’è da scoprire la genesi di immagini che diventano semplici grazie ad un processo molto determinato e lucido di semplificazione. Lo spazio dentro nel quale opera prima di essere tela è una specie di cella, riquadrata dentro i fogli di carta, in cui, come lui diceva, “gli oggetti sono segni da organizzare, collegare e ricostruire in una visione unificata”. E, ovviamente, assolutamente bidimensionale. Oserei sostenere che il cantiere delle immagini in Lichtenstein è più affascinante delle immagini finali. È affascinante il percorso di strutturazione delle immagini, che è un percorso per fare “quadrare” l’opera, accettando tutta le complessità e le implicazioni connesse, ma senza mai “complicare” l’immagine. L’apparenza volutamente effimera dell’esito, in realtà nasconde un lavoro di messa a fuoco compositiva, che probabilmente ne spiega l’energia iconica.
Sono tanti i cantieri interessanti di cui siamo resi partecipi. Il più bello, per me è quello per Shipboard girl (immagine qui sopra), una sua celebre opera del 1965. Il “separation drawing for red”, cioè l’emersione grafica delle sole parti che nell’opera finale dovevano andare in rosso, da una parte documenta il rigore del percorso di Lichtenstein, dall’altra lascia pensare che il non detto, che il rosso solo evocato, che il sorriso lasciato a mezza bocca, sia alla fine qualcosa di più compiuto (nel senso di più sinteticamente semplice) che non l’immagine finale.
Alla Gam anche Cecily Brown. È una delle esponenti più in vista di una nuova figurazione. C’è in lei un mix di carnalità che si scioglie in lirismo selvaggio. Certamente interessante, vitale, anche coraggiosamente oltranzista. Non so quanto alla fine un po’ avvitata su se stessa (è un po’ il destino di tutti i “baconiani”). Ci voglio pensare su…
###################################################################################
Infine Shit and Die, la mostra curata da Cattelan in occasione di Altissima e allestita a Palazzo Cavour. Francamente deludente, vecchia per quell’eclettismo cercato a tutti i costi, alla fine abbastanza confusa anche nei suoi tentativi di richiamare componenti dell’antropologia torinese. Insopportabile a tratti in quei rigurgiti di un nichilismo che ha fatto il suo tempo. Molto più magico, bello, inquietante e anche tenero, il Cattelan visto la mattina nelle raccolte di Rivoli con il bambino (lui stesso?) con le mani inchiodate al banco con due matite.
Dieci visioni del 2014 che non dimenticherò
La sala con disegni e tela della fauno e la ninfa di Matisse alla Mostra di Ferrara. Ovvero, volere ma non toccare. La dimensione che lui stesso definisce della “voluttà sublimata”.
La sfilata delle quattro allegorie dell’Amore di Veronese alla mostra di Verona. La spinta della sensualità tenuta sotto il controllo della geometria quadrata del formato delle tele. Cose da Paradiso.
La Comunione di San Carlo agli appestati in via Toledo. Il capolavoro di Tanzio a Napoli, visibile dalle vetrate di palazzo Zervallos. Una convergenza tra Lombardia e Napoli d’amore per i corpi, pur nella condizione di livore.
L’allestimento della mostra di Luini a Palazzo reale a Milano. In quanto simbolo di una mostra dettata da un senso civile della cultura che per fortuna sa ancora prendere voce.
La foto di Giulia Zini con occhi spalancati e felici davanti al suo gigantesco disegno di animale esposto e premiato a Monaco per Euward6. Lunga vita all’Atelier dell’errore.
L’immensa carta dell’Italia come scenario della mostra Monditalia alle Corderie, all’interno della Biennale architettura di Rem Koohlas. Un colpo di genio per raccontare come il DNA di un paese possa resistere a tutte le sue devastazioni.
La visita a Gubbio, pietra su pietra in una bellissima giornata di settembre. Scoprire l’essere dell’Italia nelle sue incredibili stratificazioni.
La sala con le Olivestone di Beuys alla Kunsthaus di Zurigo. Sono le vasche di pietra in cui si faceva decantare l’olio, che Beuys trasforma in sepolcri con lampi di resurrezione. Nella sala c’era una Deposizione tedesca del 400, a evocare quale cammino può percorrere un tema iconografico.
La sala finale della mostra Klein Fontana alla museo del 900 di Milano. La galoppata di due artisti che avevano tanta libera e trasparente dimestichezza con il mistero.
La stanza di Elisabetta Falanga a Giorni Felici a Casa Testori. Documentazione straziante e poetica di un dolore. Ma soprattutto testimonianza di come l’arte ostinatamente proponga nessi con la vita.
Rassegna stampa domenicale, sull’arte e la fisica
Una pacifica domenica di fine anno. Dalla lettura dei giornali (Repubblica in particolare) mi sono segnato queste piccole spigolature degne di nota.
Intervista a Fabiola Gianotti, prossima direttrice del CERN: «Ho sempre pensato che il mestiere del fisico si avvicini a quello dell’artista perché la sua intelligenza deve andare aldilà della realtà che ha ogni giorno davanti agli occhi. Credo che la pittura e la musica siano le arti più prossime alla fisica» (mi viene in mente che Fontana diceva la stessa cosa, assegnando però un primato alla fisica, come “arte” del futuro).
La barzelletta di Wislawa Szymborska: «Giunto al cospetto di Dio, Einstein si permette di chiedergli quale sia la formula del creato. Dio si mette a tracciare complicatissime formule matematiche su una lavagna. Einstein lo osserva e, a un certo punto,mai fa coraggio e gli fa notare che c’è forse un errore, una piccola incongruenza. Dio lo guarda, e gli dice: “Esatto, quello ê l’uomo”».
Mario Luzi su Montale:«gli dispiaceva spingere il discorso in una direzione troppo impegnativa e rimettere in discussione principii e idee che gli appartenevano troppo a fondo ed erano per lui un modo di essere piuttosto che di volere e pensare… Direttamente la sua frequentazione non era punto proficua e tanto meno eccitante».
Recensione al libro di Simone Verde, Cultura senza capitale: «… Rilevante è la vicenda di James Smithson che , morendo nel 1829, lascia agli Stati Uniti una grande somma «per il progresso e la diffusione del sapere». Da cui sorgono Smithsonian Institution il più grande complesso museale del mondo (1 miliardo di dollari di bilancio, pari all’intero budget del Mibac, per il 60% soldi pubblici… L’esempio americano induce Verde a smontare un luogo comune, quello secondo detli Stati Uniti Paradiso di una cultura in mano ai privati: su 43 miliardi di dollari investiti nel 2012, 30 sono pubblici e solo 13 privati. Ma non è di solo soldi che vive il patrimonio, bensì se oltre a questi “ritrova un’utilità e una significazione contemporanea”». (Recensione di Francesco Erbani)
Bella la recensione della mostra romana di Memling di Claudio Gulli, su Alias il Manifesto. «… La notizia c’è e il fatto è serio: l’infausta saga sulla pittura veneziana che ha avuto spazio negli ultimi anni alle Scuderie del Quirinale ha esaurito il suo corso. Ora sembra maturo il momento di ripensare una sede espositiva che ha buone potenzialità di cambiare rotta». Di Memlimg mi sono segnato il giudizio di Panofsky citato da Gulli: «Un pittore che a volte incanta, non urta mai, non travolge mai».
Maria su nuda terra. Le “natività povere” di Caravaggio
La cosiddetta “natività povera”, ovvero la rappresentazione del Natale secondo un’adesione alla lettera al racconto del Vangelo: Caravaggio dipinse due volte questo soggetto, in un arco di tempo molto ravvicinato, cioè durante il soggiorno siciliano a cavallo tra 1608 e 1609. Una delle tele rappresenta un’Adorazione dei pastori, ed è custodita al Museo Regionale di Messina. La seconda, una Natività con San Francesco e San Lorenzo, è stata purtroppo oggetto, nel 1969, di uno dei più clamorosi furti della storia. Era custodita a Palermo, all’Oratorio di San Lorenzo. Ciò che unisce le due opere è una comune committenza francescana: era una chiesa dei Cappuccini la destinazione originaria dell’opera di Messina; ed era invece tenuta da una Confraternita di San Francesco l’oratorio palermitano. Questo è un fattore chiave che spiega in buona parte l’origine dell’innovazione di Caravaggio: il santo di Assisi non solo aveva una devozione speciale per il Natale, tanto da inventare nel 1223 il primo presepe della storia (quello vivente di Greccio). Ma sperimentava una indicibile commozione davanti al racconto di quella radicale povertà in cui Gesù si trovò a nascere.
Caravaggio da lì partì per concepire queste due grandi tele, incoraggiato nelle sue scelte anche dal fatto che vescovo di Messina in quel momento era un francescano di grande prestigio e fascino, il frate minore Bernardino Secusio. E concepì così queste stupende “natività povere”. La povertà , prima ancora che dalla rappresentazione, è data dal tono così sobrio e antiretorico delle tele: la materia è scarna, e la costruzione dell’immagine, soprattutto nella tela di Messina, lascia tanto spazio “vuoto” destinato a rendere la sensazione di un ambiente nudo e privo di tutto. Anche la luce è fioca, e, a differenza degli effetti potenti a cui Caravaggio ci aveva abituato, qui non riesce a stanare dal buio tanti particolari delle figure presenti. È luce che si intrufola nella stalla, lasciandone nella semioscurità la gran parte. Ma la scelta iconografica più nuova di queste due “natività povere” è quella di dipingere Maria stesa sulla nuda terra, senza quei piccoli sotterfugi con cui in genere l’arte aveva cercato di rendere meno brutalmente reale la rappresentazione del Natale (Giotto ad esempio, a Padova, ha immaginato Maria stesa su un giaciglio). Caravaggio non fa la retorica della povertà e neanche esaspera i toni per dare maggiore radicalità alla scena. Semplicemente dà l’impressione di seguire i fatti, di adeguarsi a come verosimilmente devono essere andate le cose. Maria stesa per terra, con il braccio appoggiato alla mangiatoia, nella versione di Messina tiene tra le braccia il bambino avvolto in fasce: visto da vicino, penetrando nella penombra, si scopre che le labbra di Gesù s’appoggiano teneramente al mento di Maria, mentre la manina si allunga verso la guancia quasi volesse fare una carezza. Ed è la povertà della scena a rendere ancora più acuta e commovente questa relazione affettiva tra la madre e il figlio: come se il destino dell’uomo non avesse bisogno di nient’altro oltre a questo legame di bene. «La Madonna con il minuto bambino», scrisse il più grande studioso di Caravaggio, Roberto Longhi, «sotto lo sguardo apprensivo dei pastori quasi colati in bronzo, appare spersa su quel poco di strame pungente, entro quel chiuso di animali immobili come oggetti, di assi e di stoppie…». Il riferimento allo “strame pungente” oltre che molto poetico fissa l’attenzione su un altro elemento di questa natività: è la paglia dispersa sul terreno. Una paglia che nella sua pochezza però riflette la luce e sembra accendersi, quasi trasfgormandosi in esili filamenti d’oro: la povertà ha in sé anche qualcosa di prezioso, sembra suggerire Caravaggio. Una preziosità che si deposita nel cuore di chiunque si trovi davanti a questa tela.
L’altra Natività ha una costruzione diversa, quasi che Caravaggio, ormai giunto al capolinea della sua breve avventura umana (morì nel 1610 a 39 anni), avesse recuperato reminiscenze dei suoi anni di formazione in Lombardia. È un quadro che richiama Savoldo o Moretto, grandi artisti che nel 500 avevano preparato la strada al realismo del Merisi. Anche in questa versione Maria è seduta per terra e fissa il Bambino che è nudo sul pagliericcio. Tutta la tradizione pittorica ha sempre rappresentato questa scena disponendo Maria in ginocchio davanti al figlio nella mangiatoia: una scelta che evidentemente incoraggiava la devozione, ma che nella testa di Caravaggio non corrispondeva alla verità dei fatti. Perciò riavvolge il film e prova a immaginare una situazione così come davvero può essere stata vissuta dai protagonisti di quella notte di 2014 anni fa. Ecco allora che Maria se ne sta quasi spossata per la fatica, con la mano sul ventre, il vestito ancora un po’ scompigliato che lascia intravvedere una spalla, e lo sguardo abbassato verso quel Bambino di cui sembra aver già intravisto il destino. Non ha veli in testa, come non li avevano altre due meravigliose Madonne “popolane” che aveva dipinto a Roma, quella dei Pellegrini e quella dei Palafrenieri.
Giacometti e le stelle
Sabato scorso avevo fatto visita guidata alla mostra di Giacometti a Villa Reale. Una mostra discreta, purtroppo allestita come una bomboniera (proprio Giacometti che aveva vissuto in una specie di studio caverna, con i graffiti sui muri, nel cuore di Parigi). Ma Giacometti è sempre Giacometti…. Ho fatto la visita seguendo con testi di Giacometti (o con testimonianze dirette) stesso e davanti a un ritratto della serie di Isaku Yanaihara, ho letto questa pagina di diario dello stesso Yanaihara: «Ricominciando sotto la nuda lampada elettrica, Giacometti ha gridato: “Un istante fa ho visto un grazioso lago dietro di lei, era un grande lago quasi abbagliante su cui si rifletteva la luce del tramonto. Sfortunatamente si è spento un istante dopo, ma devo dipingere il fondo trasparente, luminoso, immenso all’infinito, come l’ho appena visto”. In realtà dietro di me c’era un’umile stufa a carbone e il muro sporco e scrostato su cui si vedevano diversi graffiti.
“Più si vede il volto con densità, più lo spazio che lo circonda diventa immenso; è veramente curioso! Il suo viso è molto, molto bello, quasi terribilmente compatto. A fianco del suo viso, perfino un ritratto di Frans Hals, perfino uno di Rembrandt non sono che immagini buffe!”. E ha ripetuto: “Oggi posso vedere la costruzione del suo viso meglio di prima. Sì, è vero! A meno che non si colga l’architettura dell’interno, non si possono dipingere le cose”».
Viene in mente la celebre lettera di Van Gogh sul ritratto all’amico poeta Eugene Bloch, il biondo sul blu stellato. Uscendo dalla visita non a caso Luca Doninellli mi ha fatto notare che l’etimologia di “considerare” era affine a quella visione di Giacometti: per capire (prendere in considerazione) il volto di una persona bisogna metterlo in relazione con il suo destino (“sidera” cioè le stelle: le stesse che Van Gogh accende alle spalle del suo poeta). Vedere “il lago” alle spalle del giapponese significa capire che si può stringere su quel volto solo dopo aver dilatato lo sguardo all’infinito di cui è fatto o a cui è destinato.
Ecco perché il togliere di Giacometti, il suo affilare senza tregua le figure è in realtà un aggiungere, un mettere sempre più a fuoco. Se le figure gli scappano via dalle mani e non si consolidano mai in esiti per lui definitivi, è proprio per la consapevolezza che non è possibile arrivare a nessuna forma di possesso, proprio come non si possono possedere le stelle.
(Questo per dire che la lettura esistenzialista e sartriana della scultura di Giacometti, è più che altro un comodo stereotipo per ricondurlo dentro una gabbia culturale. Ma lui è più affine ai bizantini, che non a caso amava e guardava, come testimoniano le su Copie dal passato).







![Immagine1[1]](http://robedachiodi.associazionetestori.it/wp-content/uploads/2015/01/Immagine11-300x180.jpg)








