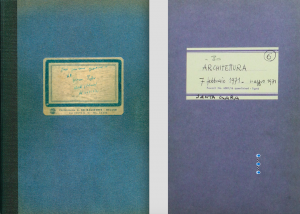Quanti incroci e quanti punti di contatto tra Aldo Rossi e Giovanni Testori. L’ipotesi di lavoro messa a verifica ieri con l’incontro alla Triennale per Milano Arch week con Giovanni Agosti e Alberto Ferlenga, non solo ha tenuto, ma ora stimola ed obbliga ad ulteriori dialoghi. Elencare gli spunti è impossibile, ma certamente il tema della mostra del 600 Lombardo, del manifesto della Città analoga in cui Rossi inserisce il David di Tanzio; certamente il tema del teatro e del cinema; certamente quello lanciato in conclusione da Ferlenga della “cura della città”. Erano in tanti ad ascoltare, e c’era anche Fabio Reinhart, architetto svizzero, che sin dai tempi dell’esilio zurighese è stato assistente di Rossi. Era stato lui ad accompagnare Rossi da Testori nella primavera del 1992, dando seguito alla telefonata ricevuta e annotata sui Quaderni azzurri (dicembre 1991). Testori era malato, e stava all’hotel Palace di Varese. Reinhart ricorda un Rossi che sentiva molto l’appuntamento. Ci fu un dialogo lungo tra i due, a cui lui aveva assistito un po’ appartato. Si parlava dell’idea di Testori di fare un libro dei disegni di Rossi: un’idea che a cui Rossi teneva moltissimo pur nella triste sensazione che la salute di Testori non lo avrebbe permesso.
Nota finale: tutt’e due avevano una preferenza per i quaderni con copertina carta da zucchero. Lo ha fatto vedere Giovanni Agosti tirando fuori “Questo quaderno appartiene a Giovanni Testori”, il libro di Paola Gallerani, con la copertina in fac simile di uno dei quaderni usati da Giovanni Testori per scrivere i suoi libri.
Concludo con quel che ha detto Stefano Boeri, che tanto ha voluto questo dialogo a distanza: «Da Testori ho imparato l’arte sofisticata dell’indecenza, da Rossi quella spregiudicata della nostalgia».
Rossi e Testori, quelli dei “quaderni azzurri”
A proposito di Rocco
Il piccolo Rocco (oggi è il suo giorno) scoprirà quanta vita, quanta pienezza c’è del dentro quel meraviglioso nome che gli è stato dato, da sua mamma Maria e da suo papà Massimiliano. Rocco è un nome denso, un nome che aderisce come una ventosa alla realtà. Un nome- sponda; un nome – roccia, data l’assonanza; un nome sollecito, che si palesa appena lo pronunci; e che oltretutto pronunci rapido, con quelle due sillabe che si chiamano l’un l’altra. Soprattutto è un nome che “si fa corpo” con chi lo porta. In una pagina bellissima di uno dei suoi ultimi libri Giovanni Testori scrive di un momento della sua storia in cui c’era «non solo la necessità della più assoluta esattezza nel riferire i nomi, ma ricordo che con stupore ogni volta si rinnovava l’assoluta coincidenza che quei nomi avevano con gli esseri a cui appartenevano… Insomma quegli esseri non erano pensabili dotati d’altro nome e cognome se non quelli che, in realtà, possedevano». Poi, lo sappiamo, si è aperta la lunga stagione della separazione tra i nomi e le cose, la stagione dei nomi svuotati di realtà. Rocco, è invece un nome che non arretra, che ricuce. Un nome irriducibile alle riduzioni. Il suo stesso suono contiene così tanta realtà…
Rocco è anche una traccia di storia, una storia tra le più belle che mi sia stato dato d’incontrare (ed è una storia che conferma in modo inconfutabile quanto detto sin qui). Parte dalle campagne della Bassa Bresciana e arriva alle prime pendici che salgono verso il Rosa. Parte dal Rocco di Vincenzo Foppa nello Stendardo di Orzinuovi. Una tela povera, scarna, dipinta su ambo i lati. Più che un quadro, una bandiera: bandiera che rivendica la possibilità di una grandezza che aderisce alla terra e che si è spogliata di ogni intellettualismo. Su uno dei due lati, c’è proprio Rocco, il santo con il suo cane e gli stivali da infaticabile e appassionato viandante. Ha il volto un po’ oblungo, di quelli che non dovrebbero finire in posa per un quadro. Ma Rocco è nome che chiama realtà, è antitetica alle logiche del glamour di ogni epoca.
L’altro Rocco è quello di Tanzio da Varallo, dipinto per la parrocchiale di Camasco, frazioncina sperduta di Varallo, nella valle del Mastellone. Volto indimenticabile, il cui sguardo dice tutto del suo cuore: una passione senza riserve, per chi incontra e per chi lo chiama. Notava sempre Testori (che per primo aveva tolto questo quadro dall’ombra), che il Rocco di Tanzio avanza di continuo «verso l’esterno», come per «una marcia che sembra non arrestarsi mai». Tutto «per un bisogno di invadere lo spazio fisico», per «una necessità di occupare una dimensione che non sia più e solo quella del dipinto». Rocco è questo: uno che esce sempre allo scoperto, che arriva puntuale e fedele quando lo attendi. Forza e dolcezza in unico corpo, con quel nome addosso (…il Rocco- Alain Delon di Visconti).
Auguri piccolo Rocco, e tieniti sempre stretto a questo tuo meraviglioso nome.
Paladino a Brescia, scultura diffusa

Mimmo Paladino, scultura in brnzo dipinto, nella Cappella di Sant’Obizio affrescata da Romanino. FOTO di Ferdinando Scianna
Questo articolo dedicato a Ouverture”, la mostra diffusa di Paladino a Brescia, è stato pubblicato su Alias domenica 4 giugno.
A Mimmo Paladino va riconosciuta una qualità che è di pochi artisti: quando arriva in un luogo è come se fosse stato lì da sempre. Ogni volta trova il suo spazio senza necessità di farsi largo o di “imporsi”. Una qualità che è giusto sottolineare, visto che spesso assistiamo a interventi di artisti contemporanei che consumano i contesti storici forzandone valori ed equilibri, con obiettivi mediatici e quindi mercantili. Non è una strategia quella di Paladino. È una predisposizione: la sua opera osserva più che voler essere osservata. È arte in ascolto; intrinsecamente dialogante, che lascia sempre la prima parola a chi viene incontro.
Si ha conferma di questa natura dell’opera di Paladino nella grande “invasione” che l’artista a realizzato nel cuore di Brescia. Un’operazione inedita, per caratteristiche e per dimensioni. Un’operazione partecipata che ha visto coinvolti e alleati in modo non formale tanti soggetti della città e che merita di essere riassunta nella sua dinamica. L’idea parte da Massimo Minini, che giustamente la giunta guidata da Emilio Del Bono ha voluto come presidente della Fondazione Brescia Musei. Gallerista di levatura internazionale, ha sempre mantenuto un legame forte con la sua città senza cedere alle sirene globaliste che avrebbero potuto indurlo a trasferirsi ad esempio nella vicina Milano. È stato lui proporre un progetto, ribattezzato Brixia Contemporary, che prevede, come lui spiega, «che ogni anno un artista internazionale sia chiamato a svelare un nuovo punto di vista sullo spazio urbano del centro storico bresciano, grazie al dialogo tra le opere selezionate e create per l’occasione e i luoghi che le accoglieranno». Ruolo chiave nella scelta dell’artista per questo esordio e nella concretizzazione delle scelte lo ha poi avuto Luigi Di Corato, direttore di Brescia Musei. «Paladino», spiega, «ci è sembrato perfetto per la sua capacità di alimentare la storia trasformando i simboli della cultura figurativa del Mediterraneo, dagli archetipi al Novecento».
Per rendere possibile e sostenibile un’operazione comunque molto ambiziosa, è stata cruciale l’adesione della Brescia produttiva, che non solo ha sponsorizzato il progetto, ma che ha messo a volte il suo know how a disposizione per realizzare alcune delle opere, di notevole complessità, come i cinque grandi “Specchi ustori” che Paladino ha immaginato appositamente per lo spazio del Teatro Romano: sculture in ottone serigrafato e dipinto, di cinque metri di diametro. La città insomma ha fatto rete attorno a questa che in ogni senso ha il sapore di un’“Ouverture”, come dice il titolo scelto da Paladino: un’operazione modello di arte a destinazione larga, di arte “per tutti”, che non grava sui conti dell’amministrazione pubblica (sino all’8 gennaio; catalogo con campagna fotografica di Ferdinando Scianna e testo narrativo di Aldo Nove in corso di pubblicazione)
Paladino con Brescia ha un legame biografico particolare: qui nel febbraio 1976 aveva tenuto la sua prima personale alla galleria Nuovi Strumenti di Pietro Cavellini, una galleria molto attiva che in quegli anni esponeva, tra gli altri, artisti come Zorio, Parmiggiani, Anselmo. “Spirale, arco, ottagono, ruota”, era il titolo della mostra, ed è un titolo che evocando forme di geometrie archetipe, rivela un filo rosso di continuità con l’ambizioso ritorno di oggi. Altro legame è poi quello della comune matrice longobarda che unisce, pur nella grande distanza geografica, Brescia con Benevento, la città di origine dell’artista (che ancora ha il suo studio a Paduli, suo paese natale). È un’affinità storica che Paladino ha voluto sottolineare nel percorso, esponendo un’opera del 1998, la “Cattedra di San Barbato” in dialogo con la celebre “Croce di Desiderio”, uno dei gioielli del Museo di Santa Giulia. San Barbato fu il vescovo beneventano che nel VII secolo aveva portato i longobardi al cristianesimo; Desiderio a sua volta fu re degli stessi longobardi un secolo dopo. La Cattedra è un trono spartano, scevro da ogni retorica, quasi una reliquia che se ne sta appartata, più a far da spettatrice che in attesa di adoratori.
Paladino non è un artista calcolatore. È naturaliter prolifico e generoso.
A Brescia è arrivato portando oltre una settantina di opere, in gran parte sculture. Non ha però cercato palcoscenici; piuttosto, nel dialogo con Di Corato, è andato a insediarsi in gangli emblematici della città, facendone riemergere potenzialità e fascino. Emblematico, da questo punto di vista, l’intervento in Piazza Vittoria. Poteva essere un innesto rischioso, perché la piazza realizzata da Marcello Piacentini nel 1932, si prestava a scivolate declamatorie. Invece la riflessione con Di Corato ha portato a immaginare un insieme di innesti che funzionano da cuciture e da aperture di prospettive. Le sculture sono in molti casi posizionate su assi che propongono inediti canali prospettici in direzione della piazza: il “Cerchio” sull’asse verso Piazza Duomo; il grande Cavallo su quello verso la Stazione. Il “Sant’Elmo”, opera-feticcio tante volte proposta da Paladino, qui in versione in alluminio, dialoga con il pulpito mussolinano in pietra rosa e i relativi bassorilievi di Antonio Maraini: quasi un’operazione di disseppellimento critico di una memoria storica della città. L’intervento più delicato e mediaticamente più caldo è stato quello della grande “Stele” in marmo nero, sul plinto destinato al famigerato Bigio di Antonio Dazzi, rimosso nel 1946. L’opera è stata realizzata da Paladino ad hoc, quasi forzando la propria mano: ha rinunciato infatti alle forme arrotondate, misteriose ma cordiali, della sua scultura, per una scelta aggressiva, di tagli violenti, di volumi che si disputano lo spazio. È un’immagine che ha qualcosa di allarmante, quasi un richiamo, o un avvertimento, rispetto al rischio di un totalitarismo che non è stato affatto estirpato dalla storia.
Per scoprire come Paladino sappia emergere restando dietro le quinte bisogna spostarsi al Parco Archeologico. Qui tra le colonne del Capitolium ha portato i 20 “Testimoni” (opera del 2009) scolpiti nel tufo. Si presentano come delle sentinelle silenziose, custodi chiamati a tessere un colloquio tra il grande passato testimoniato da quei resti e il presente. Sono figure riservate, che stanno rispettosamente dentro lo spazio a uovo per loro concepito. Ma spiccano perché sanno instaurare una relazione immediata con ciò che li circonda e soprattutto con chi si affaccia all’area. Verrebbe da dire che con quella pietra porosa e“tiepida” di cui sono fatti reimmettano un calore di vita tra quei resti di un lontano passato.
Come spiega Di Corato, il criterio di “Ouverture” – criterio condiviso pienamente con Paladino – è stato quello di un investimento sul patrimonio: le sculture funzionano come leve per restituire una centralità strategica ai reperti con i quali sono messe in dialogo. Così il risultato è duplice: si rispetta ed esalta la natura dell’opera paladiniana e si restituisce attrattività culturale ed emotiva al patrimonio. Per questo si è scelto come epicentro del percorso il Museo di Santa Giulia, il museo della città, straordinario scrigno a strati che affonda nella storia di Brescia: qui Paladino è presente con una trentina di opere, ciascuna chiamata a cucire un dialogo, libero e aperto, con gli spazi o i singoli reperti del Museo. Dialoghi che a volte risentono delle cesure del tempo, come accade nella cappella di Sant’Obizio. Qui, davanti al gigante tenero dipinto dal magnifico Romanino, spunta invece una creatura un po’ algida e lunare di Paladino, che sembra essersi però voluta sporcare con i colori dell’affresco (è di bronzo dipinto). Un inatteso teatrino, cordiale e surreale che accende di imprevisti anche questo angolo della chiesa di San Salvatore.
Stefano Arienti, la poesia della responsabilità
Questa intervista a Stefano Arienti, in occasione della mostra “Antipolvere” al Museo Civico di Modena, è stata pubblicata su Alias domenica 7 maggio.
Una grande finestra a riquadri si apre su un panorama vasto e indefinito: sembra una griglia per imbrigliare il cielo e abbreviare la distanza che separa lo studio di Stefano Arienti dalla sua Asola, pianura mantovana, dove è nato nel 1961. Siamo ai margini di Milano, oltre il Parco Lambro. Qui la città dà l’illusione di essere finita. Lo studio è in un vecchio casale contadino lombardo, di quelli che sembrano dimenticati dalla storia. I soffitti sono alti. C’è molto ordine e un senso di equilibrio quasi monacale. Un grande muro è lasciato libero: lì Arienti lavora le sue carte o i suoi grandi teli antipolvere. Sul lato opposto c’è “Stimmung”, una serie lunga e fitta di scaffali bianchi, macchiati dai colori di centinaia e centinaia di cd: sembra quasi una delle sequenze di Robert Irwin. È un’opera di Arienti. L’unica che ha diritto di cittadinanza permanente nel suo studio. «Il titolo è un omaggio a Stockhausen», racconta l’artista. «Si tratta di un work in progress: raccolgo musiche tradizionali da tutto il mondo. Le catalogo per nazioni. Proprio in questi giorni con il Lussemburgo ho completato l’Europa». Sono, per ora, 4mila cd che alla sola vista suggeriscono l’idea di una partitura musicale visiva e che funzionano da strumenti per un affascinante workshop che Arienti tiene in questo periodo, ogni domenica, a Palazzo Te a Mantova. «È come la saldatura di un debito», racconta. «Io arrivo alle arti visive dalla frequentazione della musica negli anni 80. Da lì è scattata la predisposizione che poi ha segnato la mia vita».
Lo studio di Arienti non è solo un luogo in cui progettare e lavorare. È un avamposto protetto dalle interferenze del grande circo dell’arte. «Vengo dalla campagna. Non sono fatto per andare alla conquista del mondo», racconta. «Il mio è un imprinting segnato dalla laurea in agraria, con tesi sulla malattia delle piante». Eppure tra questi muri si avverte che l’isolamento non è affatto una schermatura dalle interferenze del mondo. Si avverte nell’aria e nella luce stessa una fibrillazione sottile e continua per cercare quella che lui definisce «un’estetica possibile di un mondo che vogliamo». 160 chilometri più a sud, a Modena, si può assistere alla versione visiva di quel che questo luogo evoca. È la nuova mostra intitolata “Antipolvere” (Museo Civico, fino al 16 luglio), in cui Arienti ha raccolto una selezione di lavori in gran parte realizzati su questi teloni poveri che vengono usati per proteggere le impalcature. Antipolvere indica il desiderio di togliere la patina del passato da immagini che Arienti ritiene nevralgiche per il presente. A Modena non siamo semplicemente chiamati a guardare le opere. Ci camminiamo in mezzo. Siamo tirati dentro, per assorbirne gli umori e quella dimensione estetica che nelle opere di Arienti è così naturalmente contigua a quella etica.
«Mi interessa molto la parola responsabilità», dice. «Penso che un artista possa riconoscersi tale se qualcuno accetta la sua sfida ad essere artista. È un’investitura che si riceve. Non basta pensarsi artisti, proporsi come artisti. Bisogna anche trovare qualcuno che faccia il gesto di risposta di riconoscerti tale. La condizione dell’artista è sempre e soltanto una condizione condivisa, pubblica, sociale. Non ci si può nascondere dietro una maschera, dietro un anonimato o delle vie di fuga».
È anche per questo che Arienti nei mesi scorsi ha accettato la proposta lanciata da Casa Testori, un hub culturale alle porte di Milano, di confrontarsi su un terreno inedito, quello delle responsabilità dell’arte rispetto alla corruzione. Prima è sceso in campo per un confronto pubblico con il procuratore generale antimafia Franco Ruberti e con don Luigi Ciotti. Poi ha voluto essere presente alla mostra organizzata sempre sul tema, con un’opera poetica e sorprendente: “Lame”. Tre oggetti di taglio che vengono da un armamentario contadino e che oggi Arienti sorprende in una zona insidiosa e tacitamente aggressiva di “cambio d’uso”. Com’è nel suo stile, senza salire di tono, suona però un allarme.
A dispetto del ricercato isolamento del suo studio, Arienti è artista strutturalmente collaborativo. Se ne ha conferma immediata nella scelta delle opere che ha voluto esporre a Modena. Gran parte nascono da un rapporto di committenza; un rapporto che non è semplicemente meccanicistico ma che si sviluppa dentro un dialogo e con momenti di percorso comune. «Mi piace lavorare su committenza. Mi stimola. Non lo sento affatto come una limitazione. Mi piace anche la committenza ecclesiale, che ultimamente si è fatta anche più frequente», spiega Arienti. A Modena sono infatti presenti gli studi per il motivo per l’altare della Parrocchiale di Sedrina, in Val Seriana. Ma sono presenti anche i lavori realizzati per Zegna e per Kartell. «Sono aziende che hanno un’immagine molto precisa, e hanno una lunga storia di attenzione al contesto umano e naturale in cui producono. Ammiro il volto di quest’Italia produttiva e in un certo senso voglio fare la mia parte…». Non c’è invece a Modena (e non potrebbe esserci…) un intervento che Arienti ama molto, realizzato per la Fondazione Zegna: un impianto wifi portato nel comune di Trivero, nel Biellese, che l’artista ha voluto marcare con opere di natura opposta, vagamente primordiale: sassi con dipinte sopra delle facce, “I Telepati”. «Mi piaceva che le sculture incarnassero quest’idea di comunicazione immateriale. Come se una tecnologia contemporanea quale Internet realizzasse un sogno antichissimo dell’umanità: quello di comunicare a distanza, “senza fili”».
A proposito di committenza, Arienti ha avuto recentemente anche l’occasione felice di tornare a casa. Il piccolo Museo di Asola gli ha chiesto infatti un’opera che prendesse spunto dal capolavoro più periferico e “selvaggio” del Romanino: il ciclo con le tavole per la cantorie e le ante d’organo del Duomo. Come sempre nel suo stile, l’approccio è un’operazione di svelamento. «Ho incontrato Romanino sin da bambino», racconta. «Ma solo pochi anni fa ho scoperto qualcosa che mi era sempre rimasto nascosto: le ante d’organo vengono sempre tenute aperte e i rettro quindi non si vedono. Romanino vi dipinse due santi, Andrea ed Erasmo, in dimensioni monumentali. Ne ho ripreso il tracciato, con inchiostro metallico, su telo antipolvere, riducendo leggermente le dimensioni per adattarmi all’altezza delle pareti del museo. Ho pensato che in questo modo tutti potessero finalmente vedere e immaginare il Romanino che non si vede». Opera di svelamento, quindi. Un’immagine aperta, che probabilmente ha a che vedere con quella possibile «descrizione di un mondo che vogliamo».
Nell’immagine: l’allestimento della mostra di Modena. In primo piano, I nomi di Ciserano (2001); sullo sfondo, Ailanto d’oro (2009)
L’Ultima Cena. Avventura con Leonardo
Ho scritto queste righe per il sito de Il Sussidiario, in occasione del Giovedì santo. Lo ripropongo qui, perché in un certo senso per me ha rappresentato un’avventura. Nel momento in cui l’ho affrontato avevo un’idea vaga di quel che volevo dire. Poi nel confronto serrato con l’immagine e con l’obbligo di dare chiarezza all’idea attraverso ali scrittura, il pensiero ha preso una sua forma, credo, precisa. Ma quello che mi interessa segnalare è come le grandi opere costringano sempre all’avventura. Innanzitutto hanno una profondità che non si smette mai di raggiungere: più indaghi e più le devi inseguire. In secondo luogo non stanno mai ferme. In terzo luogo non sono mai le stesse: in ogni tempo, in ogni istante lo sguardo che si pone su di loro in un certo senso le cambia. Questa è l’avventura che ho sperimentato affrontando un po’ impunemente l’Ultima Cena di Leonardo.
C’è un dettaglio dell’Ultima Cena di Leonardo a cui bisogna prestare molta attenzione: è il secondo gruppo di apostoli da sinistra. È lì il vero cuore della scena. Seguendo il racconto di Giovanni Leonardo si sofferma in modo insolito rispetto alla consuetudine sul versetto 24 (il capitolo è il 31). Cioè gioca di anticipo. Gesù ha appena annunciato che qualcuno lo sta per tradire, la tavolata è stata come colta da una scossa emotiva che rompe le fila. C’è chi sia alza e per la concitazione quasi si avventa su Gesù, chi un po’ pavidamente si ritrae; c’è poi il capannello di chi un po’ spaesato cerca di raccapezzarsi circa quello che sta accadendo. Solo quei tre sembrano invece lucidi e anche determinati. Il più lucido è Pietro che ha individuato subito la strategia: deve convincere Giovanni, il più amato da Gesù, a farsi dire il nome del traditore. Ed è proprio questo l’istante che Leonardo blocca nel fotogramma della sua Ultima Cena. Pietro ha appoggiato la mano sulla spalla di Giovanni e all’orecchio gli sta dando quel consiglio che suona un po’ come un ordine: nell’altra mano del resto Pietro tiene già il coltello che userà poche ore dopo quando per difendere Gesù da chi lo voleva arrestare, avrebbe tagliato l’orecchio al servo del sommo sacerdote Malco. Giovanni ascolta il leader. Ha lo sguardo chinato, già pieno di una infinita tristezza. Si chinerà di lì a poco sul petto di Gesù, ma sembra che per l’intesa profonda che lo lega al Signore abbia pieno presentimento di quel che accadrà. Leonardo, poi, con un colpo di genio, chiude questo triangolo con la figura di Giuda. Tra tutte le figure è l’unica in controluce: ne vediamo solo il profilo nell’ombra, ma basta quello per capire che ormai è caduto prigioniero della disperazione. Con una mano stringe il sacchetto dei denari. Con l’altra sta invece per prendere un pezzo di pane, disponendosi in questo modo, del tutto inconsapevolmente, al segno di riconoscimento che tra qualche istante Gesù avrebbe dato. Tra Pietro, Giovanni e Giuda ci troviamo di fronte ad un triangolo che concentra tutto il dramma, le paure, la ribellione rispetto a quello che stava accadendo attorno al tavolo. È un momento in cui nessuno può più nascondersi, nemmeno Giuda; in cui l’umano viene messo a nudo.
In genere le rappresentazioni delle Ultime cene prediligono invece l’attimo successivo. Quello in cui Giovanni mette il suo volto sul petto di Gesù e sembra che le cose si possano mettere a posto: il traditore ha un nome, gli altri sono scagionati, forse qualcuno pensa di poter addirittura arginare l’azione del male. È una pia illusione, come le vicende avrebbero dimostrato. Ma un’Ultima Cena così è più consolante per il cuore dei fedeli. E il cuore dei fedeli ha sempre bisogno di consolazione…
Leonardo invece sceglie di lasciare aperta la ferita. Pur con la meravigliosa e slanciata armonia che tutti riconosciamo nella sua composizione è paradossalmente il più inquieto. In questo lo sentiamo anche tanto più moderno (non è un caso che anche un “modernissimo” come Andy Warhol ne sia stato conquistato e ne abbia dipinte decine e decine di varianti). La sua Ultima Cena è quella in cui tutte le domande sono aperte e non è ancora arrivata quell’unica fragile risposta a cui potersi appigliare. È il momento in cui l’onda di un’umanità in subbuglio cerca uno sguardo a cui appoggiarsi. Lo cerca e lo domanda, con le sue (e nostre) povertà e a volte con la sua (e nostra) pusillanimità. Quella di Leonardo non è un’icona. È piuttosto il fotogramma di un film. Un film per il nostro Giovedì Santo di uomini del terzo millennio.
Adrian Paci, tra Rasha e Masaccio
Con Adrian Paci alla nuova mostra alla Cappella Portinari e al Museo Diocesano di Milano, curata da Gabi Scarbi. Paci parla delle opere esposte, e ne parla come se fossero non innanzitutto sue ma di chi ne è il soggetto. Ne parla mettendo al centro le storie; perché lo stile dipende sempre dalle storie. Si genera dalle storie e dalle situazioni. La mostra è segnata in particolare dai video. Due sono inediti. Il primo girato a Cascina Monluè, tra migranti impegnati in cucina. Il loro lavoro è interrotto da una banda musicale italiana che suona motivi tradizionali albanesi. La scia della musica non lascia più quel luogo…
Il secondo video è stato girato a Roma, nella struttura che Sant’Egidio ha messo a disposizione delle famiglie arrivate in Italia grazie ai corridoi umanitari. È un video che proiettato su un grande schermo, “riempie” con la sua presenza la grande sala, stile refettorio del Museo. Lo si vede in fondo alla sala entrando e si ha la sensazione di trovarsi davanti al frammento di un grande affresco. Infatti il video è a inquadratura unica: la camera è puntata sul volto di Rasha. È dall’incontro con lei che è nata l’opera (c’è scritto proprio così nella piccola guida che viene distribuita ai visitatori: è arte che scaturisce da incontri quella di Paci). Rasha è siriana, ha tre figli, ed è cieca per via delle schegge di una bomba che l’hanno colpita quando era nel campo profughi, alle porte di Damasco. Paci ne ha raccolto la storia facendo due scelte: quella di inquadrare senza muovere mai l’obiettivo dal volto di Rasha («Avevo in testa i volti di Masaccio», mi dice Paci. E il riferimento nella solidità drammatico di quel taglio quasi scolpito sullo schermo, è molto pertinente). E poi la scelta, in fase di montaggio, di tenere solo le inquadrature in cui Rasha non parla, o perché sta mettendo a raccontato. È un racconto muto, sotto il quale però scorre il sonoro della sua voce. L’effetto è semplice e impressionante, perché il volto intercettato nei momenti di pausa e di silenzio sembra un volto “bloccato” dal suo stesso racconto. Sono i momenti in cui lei tiene dentro la sua storia, in cui fa i conti con i suoi pensieri. I visitatori poi possono prendere un manifesto accumulato sul pavimento, che da una parte ha il volto di Rasha e dall’altra la traduzione del suo racconto. È parte dell’opera anche questo gesto a cui siamo chiamati, per tenerci attaccati la storia di Rasha.
Uno, dieci, cento Rauschenberg
Giornata londinese in gruppo, per vedere in sequenza Rauschenberg, Michelangelo&Sebastiano e Hockney. Cominciamo da Rauschenberg che è alla Tate Modern, sino al 2 aprile, poi si trasferisce al Moma. La mostra è un utilissimo ripasso di uno dei personaggi chiave dell’arte del secondo 900. Personaggio generoso, che non sta mai sui risultati raggiunti perché sempre in cerca di sguardi ed esperienze nuove. Le sale più belle sono le prime, dedicate agli esordi. C’è una dimensione di esplorazione in tutte le direzioni, senza riserve è aperto ad ogni esito. Rauschenberg osa ma non per provocare. Osa anche con una certa ingenuità, come uno che voglia verificare sempre prima di chiudersi una strada. Automobile tire print del 1953 (nell’immagine sopra un dettaglio), è l’impronta della Ford di Rauschenberg guidata da John Cage: ruota anteriore che ha lasciato una sinopia, quella posteriore che invece è passata nella vernice nera ha lasciato il segno profondo. L’opera è esito di un processo meccanico anche se il copione è ben studiato. È immagine lunga e sottile che racconta tante cose: di un’amicizia, di una densità di sentimenti, di un’affinità di strade. Di fronte il “glossy black”, quadro immerso nel nero, così grande e così grumoso da sembrare uno spezzone di superficie lunare strappata alla notte. E poi l’opera a quattro mani con la sua Susan Weil, Double Rauschenberg (Monoprint exposed blueprint paper): figure speculari verticali che navigano nel blu. E poi le Scatole personali, titolo in italiano, piccoli reliquiari con frammenti di memorie concepite con l’amico Cy Twombly. E poi il De Kooning erased, disegno cancellato di cui si salva un’ombra (un’anima) con la complicità dello stesso De Kooning. E poi le prime sculture poveriste: un sasso incatenato ad uno spezzone di vecchia trave. E poi il White painting, di un bianco artificiale, quadri senza mano d’uomo, che aprono già al minimalismo. Tutto questo (e altro ancora) in una sola sala. Tutto questo in due soli anni, tra 1951 e 1953. Diciamo che Rauschenberg è artista senza riserve e senza preclusioni. È questo è il suo fascino. Esplora e arriva prima, anche se poi non sarà “il primo”.
Entrate a Santa Maria Rossa quando si fa sera…
Entrare quando di si fa sera e scende il buio sulla città nella chiesa di Santa Maria Rossa a Milano è un’esperienza che una volta nella vita va fatta. È la chiesa “accesa” dai neon di Dan Flavin. Già da fuori si è catturati dalla luce blu diffusa nella navata che passa dalle vetrate; ma quando si entra lo spettacolo purissimo delle transizioni verso il rosso drammatico che taglia il transetto sino al giallo “glorioso” dell’abside, riempie davvero di commozione. Mi sono sempre chiesto come un artista che non aveva mai visto questa chiesa e che aveva mandato le sue indicazioni molto precise via posta dall’America poco prima di morire nel 1996, sia potuto arrivare a risultati non solo così belli, ma anche così esatti rispetto al luogo inteso come architettura e soprattutto così intrinsecamente coerenti rispetto al luogo, inteso come senso e funzione. L’arte religiosa nel nostro tempo è davvero figlia dell’imprevisto. Forse può essere solo figlia dell’imprevisto.
Questa pagina, ambientata a Santa Maria Rossa, tratta dal libro di Tiziano Scarpa, Il brevetto del geco, rende l’idea…
«Il tuo spazio è qui sotto. Ma questo cielo è un’illusione protettiva: è ridotto a una forma a una forma elementare; una piccola volta geometrica, la metà di un cilindro, tinteggiato da una luce colorata (è la volta disegnata da Giovanni Muzio, architetto della chiesa, ndr). Guarda là in fondo, invece. Davanti a te. Oltre questa sala d’aria blu c’è tutta un’altra luce, più chiara, speciale, come quella che si concentra nelle sorgenti luminose: la gialla doratura del sole. Ma per raggiungerla bisogna passare attraverso una ferita, un’effusione di sangue, bisogna incrociare la luce rosse, attraversarla. Il blu, poi il rosso, poi il giallo. E tuttavia anche quella ferita rossa, quel dramma che si mette di traverso interrompendo lo slancio del blu verso il giallo, non è un velo di sangue; è una luce anche quella, irradiante, che sanguina luce».
Bellotto rompe la misura. Il paesaggio come vastità
«Qui la grafia prodigiosa del Bellotto, quasi un alfabeto Morse di linee, punti, tratteggi d’ogni specie e colore, svela il segreto sintattico di un trapasso all’“ottico” al “narrativo” che è quasi da leggere come certi brani del famoso Ottocento russo… La stessa precisione stregata».
Uso questa illuminante frase di Roberto Longhi (da un articolo scritto per l’Europeo nel 1965) per cercare di approcciare la grandezza di Bernardo Bellotto. L’occasione è stata la mostra alle Gallerie d’Italia chiusa domenica (con record di visitatori e coda infinita per gli ultimi giorni). Una mostra scoperta all’ultimo momento che è stata una rivelazione. Bellotto ha qualcosa che non ti aspetti, che va oltre non solo l’idea che ti eri fatto ma soprattutto oltre il posto in cui per comodità lo si colloca. Bellotto innanzitutto rompe la misura del vedutismo, perché la marcia che innesca con la serie di paesaggi di Dresda e Varsavia lo porta fuori misura. Il paesaggio, pur nella sua pacata naturalezza, prende una dimensione di vastità. S’allarga, sino ad assumere una dimensione che viene da definire monumentale. Ma dentro quel dilatarsi resta infallibile nella precisione del dettaglio: è l’ottico che si distende nel narrativo. Cioè in una grandiosità di respiro. Colpisce la predilezione per i fiumi, che assicurano prospettive in cui il paesaggio si apre e si allarga.
C’è poi il segreto tecnico della pittura di Bellotto: il paesaggio non è mai preso da un punto di vista, ma da una sequenza di punti di vista. Quindi non va mai a stringersi verso un punto focale. Per questo ci passa davanti allo sguardo in una sequenza di visioni che sono una parallela all’altra. È un paesaggio che scorre e che ci trova in ogni punto in una posizione di frontalità. Il nostro occhio è sempre in asse. Viene da fare il parallelo con le grandi di foto di Andreas Gurky che sembrano scattate con un obbiettivo il cui fuoco è identico in ogni parte dell’immagine: immagini senza un centro, perché tutto è centro.
All’interno di queste visioni, salite di scala in modo imprevisto, Bellotto si muove con una padronanza e una libertà impeccabili. C’è infatti un’esattezza nella sua pittura, che è esattezza non fredda o mentale, ma sempre vissuta e impastata di atmosfericità. Soprattutto è un’esattezza che non perde mai di vista l’insieme. Ogni dettaglio a suo modo è al centro, ma non si richiude mai su di sé. È un microcosmo sempre in collegamento con il macrocosmo che lo circonda.
Basquiat e Haring, fuori dalla storia
Jean-Michel Basquiat e ora Keith Haring sono tornati a Milano, dieci anni dopo. Basquiat al Mudec con una mostra un po’ rimediata, Haring a Palazzo Reale più strutturata e “costruita”. Comunque vedere quei due è sempre un bel pieno di energia. Pensavo alla concomitanza di vedere questi due protagonisti della New York nell’anno uno del reaganismo, proprio mentre l’America si inoltra nel suo corrispettivo da terzo millennio: il trumpismo. La mostra di Basquiat seguiva un filo sommariamente cronologico (con l’anomalia della mostra a quattro mani con Warhol come sala finale, mentre è di tre anni prima). Quella di Haring invece segue una scansione tematica, secondo una consuetudine sciagurata che sta prendendo sempre più piede. Risultato si chiude con l’ultima sala, per altro molto bella, presenta i “subway drawings” degli inizi.. Risultato in un caso e nell’altro, la storia comunque si perde. In Basquiat il percorso è tutto centrato su di lui senza nessun nesso di contesto se non strettamente necessario. In Basquiat l’avanti e indietro cronologico (pur su cronologie così strette) non permette di fissare dei riferimenti. Eppure sarebbe stato interessante dar spazio ai nessi e ai ricorsi storici (pensate che nel 1981 un certo Trump si presentava alla Factory per commissionare un’opera a Warhol, da piazzare nella edificanda Trump Tower; l’opera venne realizzata, ma il miliardario alla fine non la prese).
Comunque, a posteriori, colpisce la differenza di energia antagonistica di una città come New York, tra allora e oggi. Agli inizi degli anni 80 aveva espresso quei talenti irregolari, incontenibili e affascinanti. Oggi invece la reazione è tutta molto più complessata e intellettualistica. Vedere le mostre serve anche a fare questi piccoli esami di storia. L’arte, volenti o nolenti, è sempre storia.
(Comunque Haring andate a vederlo, merita. Ne riparleremo)