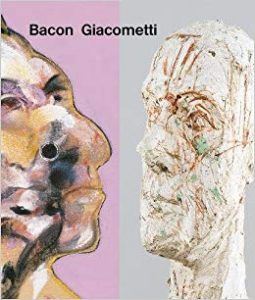Questa recensione alla mostra di Sean Scully a Villa Panza a Varese è stata pubblicata su Alias il 19 maggio, con il titolo “Associazioni e redenzioni”.
Ad un certo punto della mostra che Villa Panza ha dedicato a Sean Scully si assiste ad un colpo di scena. Dopo essere passati per le prime sale che raccolgono i lavori degli anni 70, regolati da griglie molto controllate, in molti casi eseguite con l’ausilio di un nastro che teneva sotto controllo pennellate e colori, ci si trova davanti ad un’opera immensa che si presenta come un felice terremoto. L’opera è “Backs and Fronts” ed è datata 1981. «È veramente il mio manifesto, è un quadro fondamentale», ha sempre spiegato Scully, che non a caso non ha mai voluto venderla. Le dimensioni non sono indifferenti, 2,40 metri x 6,10. E anche la forma salta all’occhio: è un polittico di 12 elementi, disposti con un andamento musicale come se il muro fosse il foglio di un pentagramma (di «note retiniche» non a caso parla Kelly Grovier nel breve saggio in catalogo, dedicato a questa opera chiave).
All’origine il quadro si intitolava “The Musicians” come omaggio ai “Tre musici” di Picasso, opera del 1921. Scully inizialmente aggiunse un musico. Poi si accorse che non bastava. «Era come se un numero sempre maggiore di musicisti si unisse alla nostra banda affermata… e finalmente, dopo un lungo viaggio, è stata rinominata “Backs and Fronts”». «Ricordo di averlo esposto a PS1», ha raccontato sempre Scully in un lungo dialogo con Hans-Michael Herzog. «Tutti quelli a cui piaceva erano punk. Allora ho capito che stavo facendo la cosa giusta perché il quadro aveva in sé un’energia molto provocatoria, se si pensa al minimalismo e a tutta la sua rarefazione… È stato un vero salto. Come una superficie che si ribalta». Quanto al titolo cambiato, l’intenzione era di fare riferimento alla figura umana. «Lo pensavo come una fila di figure in attesa. In attesa che succedesse qualcosa».
Aver portato “Backs and Fronts” è un doppio merito per l’organizzazione di Villa Panza e per la sua direttrice, oltre che curatrice della mostra, Anna Bernardini (“Sean Scully. Long Light, Varese Villa Panza, fino al 6 gennaio 2020). Infatti è la prima volta che quest’opera chiave viene presentata in Italia (dove per altro negli ultimi ci sono state molte occasioni di conoscere il lavoro di Scully). Ed è un’opera che per la sua natura crea un’intrigante e anche tesa dialettica con il contesto.
Infatti è noto che Giuseppe Panza avesse puntato gli occhi su Scully: nel 1989 aveva visitato il suo studio di New York, manifestando interesse per un quadro che poi sarebbe stato acquisito dalle Tate. Ma il prezzo dell’artista era già troppo alto rispetto alla filosofia oculata di acquisizioni sempre perseguita da Panza. L’abiura del minimalismo da parte di Scully inoltre non poteva certo trovare d’accordo il collezionista, che in quegli anni stava invece seguendo artisti che si muovevano con molto rigore su quella linea. “Backs and Fronts” è, al contrario, un’opera pervasa da un fremito, dove la pittura si allontana dalla rarefazione a volte vertiginosa del minimalismo e si orienta decisamente verso uno spazio “impuro” di indeterminatezza e di espressività. Mi viene anche da credere che Scully si sia ben reso conto come questa ospitalità tra gli spazi di Giuseppe Panza non sia stata una cosa scontata e “dovuta”. Così ha voluto realizzare e donare le 27 finestre di vetri colorati destinate alla serra della Villa: un tocco prezioso, che si deposita come una carezza sulle forme e sulle luci del giardino, ma anche un segno d’affetto e di gratitudine nei confronti del luogo e del collezionista che ne ha segnato la storia.
Tornando al polittico, c’è un altro elemento di novità che Scully qui introduce. È una componente che Scully stesso ha definito “associativa” («Le mie opere sono incredibilmente associative», ha spiegato). Anche in questo caso la distanza dalla concezione del quadro come “monolite” puro, propria del minimalismo, è evidente. Per l’artista ogni opera vive di relazioni; quindi diventa decisiva la decisione di comporle con più elementi che siano affiancati o giustapposti o che siano addirittura inglobati come accade nella serie “Passengers”, dove ogni tela ne ingloba un’altra, quasi fosse una finestra aperta all’interno del proprio tracciato architettonico. Ma in queste opere la sensazione è anche quella di una dinamica generativa, come se il quadro fosse un processo di fecondazione e dalla pittura si generasse altra pittura, senza problemi di coerenza né cromatica né di disegno.
La relazione a volte sviluppa anche drammaturgie coinvolgenti e potenti all’interno di uno stesso quadro, come accade in un’altra opera di grande peso e dimensioni presente in mostra. Si tratta di “Standing”, del 1986 (anche questa raramente prestata dall’artista e mai vista in Italia), realizzata come meditazione sulla morte del figlio Paul, vittima nel 1983, quando aveva solo 19 anni, di un incidente automobilistico. Il quadro è composto di tre “corpi” disposti orizzontalmente uno sopra l’altro, ciascuno con un diverso spessore di telaio. Quello con la cassa del telaio più profonda è posizionato in alto e quindi si sporge, quasi con un senso di incombenza. La sua superficie è dipinta di un nero rugoso e tragico, solcato per il lungo da una sottile linea di luce rossastra, come di un’alba affaticata che sorge dopo un cataclisma. Aveva sottolineato Scully che la sua pittura non parla della “chiarezza” ma semmai della “rivelazione”: è una chiave che aiuta a capire un’opera come questa e che spiega anche perché Scully negli ultimi anni abbia scelto di lavorare per edifici religiosi, com’è accaduto a Montserrat e nella cattedrale di Girona. Anche la Biennale da poco inaugurata lo vede presente con un progetto per la basilica palladiana di San Giorgio Maggiore: “Opulent Ascension” è una scultura che si alza in verticale a fasce colorate giustapposte, proprio sotto la cupola.
Nel 2009 l’artista ha avuto un altro figlio, Oisin, nato dalla relazione con Liliane Tomasko, con la quale si era sposato nel 2006. Anche in questo caso le vicende della vita fanno breccia nel percorso artistico, in modo del tutto sorprendente. La mostra di Villa Panza presenta infatti la serie inedita “Madonna”, datata 2019. Scully fa uno scarto inatteso in direzione della pittura figurativa. Si tratta di grandi quadri dipinti ad olio su alluminio, dove mamma e bambino giocano con sabbia e secchielli in riva al mare in un contesto di serenità quasi matissiana. Ma l’andamento delle campiture colorate e delle vaste linee curve che disegnano l’architettura delle tele riportano più ad un’idea archetipa che non semplicemente autobiografica. È l’archetipo generativo della madre e del figlio, che richiama le dinamiche fecondative proprie della pittura di Scully.
A questo proposito è significativa la selezione di fotografie presenti in mostra, che aggiungono un altro tassello importante per scavare nel percorso dell’artista. In particolare la serie di scatti in bianco e nero realizzate tra i resti straordinari delle architetture contadine dell’isola Aran riportano alle sue origini irlandesi (è nato a Dublino nel 1945, ma nel 1975 si è trasferito a New York). Non solo: Scully compone una serie di 24 immagini concentrando l’obiettivo sull’allineamento seriale e ordinato delle pietre. Sono geometrie che hanno una familiarità genetica con quelle dei suoi quadri. Più che dall’allineamento, la familiarità è però determinata da quella irregolarità dei bordi che è propria delle pietre come pure delle fasce colorate, elemento per eccellenza iconico della pittura di Scully. Sono proprio i bordi ad accendere la sua pittura, sottili frontiere vitali e inquiete, luoghi dell’attesa e della rivelazione, sismografi capaci di captare, come ha detto lui, «l’incertezza del cuore umano».