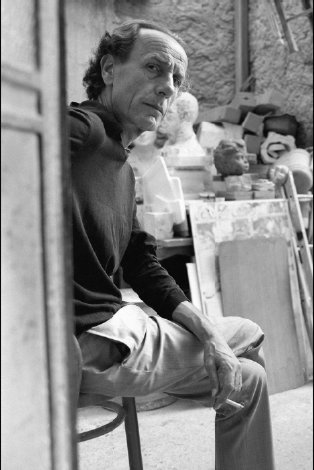La definitiva donazione ai musei di Brescia di questo capolavoro di Giacomo Ceruti (La filatrice), che faceva parte del ciclo di Padernello, mi ha smosso un pensiero che se ne stava sopito e non adeguatamente messo a fuoco. Che questa tela sia un capolavoro, ci sono pochi dubbi: un quadro che sprigiona una simpatia umana come pochi. Un quadro fatto di niente, com’è fatta di niente la vita della filatrice. Eppure che cuore, che densità affettiva, che positività calma e irriducibile, che senso sano della vita sprigiona questo Ceruti! Inutile “dirne” perché quest’immagine parla con una decisività e con una evidenza che non ha bisogno di nessun supporto interpretativo. Piuttosto la domanda da fare è questa: su che cosa poggia un capolavoro come questo? Che tipo di struttura intellettuale lo ha generato? Perché la spontaneità non basta a spiegare, non basta dire che Ceruti era un pittore di natura “buona”. Ecco perciò il concetto che volevo mettere a fuoco: questo quadro è generato dall’energia del bene. È una categoria a cui non si dà mai dignità culturale. Che si relega alla sfera dei comportamenti. Invece il bene è anche una categoria intellettuale, che quindi genera forme e immagini, che determina una coerente visione del mondo. Questo quadro di Ceruti è una quintessenza di questo senso del bene. Ma non è certo un quadro che si tira indietro, che accetta di farsi da parte nel segno di una docilità malintesa. Direi che la sua bellezza sta in una potenza mai prevaricante, eppure certamente in azione. Una potenza che ha nella travolgente persuasività la sua forza.
Il paragone immediato è a quel capolavoro assoluto che sono i Promessi sposi: li ho appena riletti e non ho finito di contare quante volte ritorna la parola “bene” tra quelle pagine. Ma vi dico che siamo vicini alle 500 occorrenze! Il bene come struttura del mondo, come motore della conoscenza, come energia generatrice dei rapporti che reggono la quotidianità. Forse sarebbe l’ora di sdoganarlo…