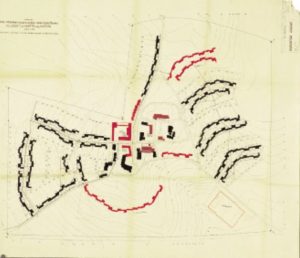A meno quattro giorni dalla chiusura, ho visto la mostra più desiderata dell’anno, “Bacon-Giacometti”, alla Beyeler di Basilea. Mostra oggettivamente eccezionale, per la grandezza dei protagonisti, per la qualità dei prestiti e dell’allestimento, per la semplicità del percorso, che non “scherma” con interpretazioni la sostanza così diretta, a volte persino così brutale, delle opere. È una di quelle mostre con le quali è inutile misurarsi e all’interno delle quali è inutile misurare grandezze.
Detto questo, ecco alcuni pensieri di dettaglio.
Tra tanta intensità e densità di capolavori, la leva “drammaturgica” della mostra è una foto. O meglio una serie di fotografie che hanno invece una loro meravigliosa casualità. Sono le uniche che testimonino un rapporto diretto tra Bacon e Giacometti, scattate da Graham Keen, mentre Giacometti stava ultimando l’allestimento della sua mostra alla Tate Gallery di Londra, il 13 luglio 1965. Keen era riuscito ad intrufolarsi, in quanto appassionato di Giacometti, grazie ad una raccomandazione della mamma della sua fidanzata, che era stata amante di Chagall ed era amica di Pierre Matisse, gallerista del grande artista svizzero. Insomma un intreccio di casualità. Keen ha fotografato da lontano per timidezza, in modo che Bacon e Giacometti non s’accorgessero della sua presenza. Che cosa si stavano dicendo? Non potremo mai saperlo, ma la magia di queste foto ci rende lecito immaginare un confronto su temi grandi, sul destino della pittura che non può essere diverso dal destino del mondo. Si colgono le vibrazioni di quelle concordanze profonde che sfuggono all’ufficialità della storia, ma che hanno più incidenza e decisività di tante concordanze dichiarate. C’è un che di epico, di unico in queste foto, scattate in extremis, perché di lì a pochi mesi Giacometti sarebbe morto. Ma sono foto che legano, che incatenano i due dentro una storia che oggi li vede stretti molto più di quanto non si possa riscontrare nelle biografie. È una sorta di folgorante amicizia postuma.
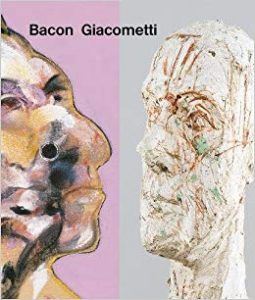
Più che un dialogo è un faccia a faccia, come sottolinea la copertina del catalogo. Giacometti e Bacon sono per loro natura dei “non dialoganti”. Solitari ad oltranza. Come ho cercato di scrivere su Il Sussidiario hanno una vocazione eremitica e i loro studi di dimensioni oltranzisticamente piccoli sono come le loro celle. La mostra funziona perfettamente laddove l’allestimento rispetta questa frontalità, quasi replicando il meccanismo di quella foto iniziale. È un guardarsi reciproco che non si banalizza mai in uno scambio. Sono due stiliti che se ne stanno “appollaiati” sulle loro colonne e non deflettono da questo loro radicale isolamento. Ma nello spazio quasi claustrofobico dei loro studi finiscono con il convergere tutte le grandi domande che trafiggono il mondo. Sono due solitudini che calamitano presenze ferite. Solitudini dense di altri corpi e di altri sguardi.

Li unisce anche un connotato sacrale, diverso ma molto esplicito. In Giacometti è la costruzione così rigorosamente frontale e quasi neobizantina delle immagini; è lo studio del piedistallo che rende le sue sculture così geneticamente simili agli antichi reliquiari; è quell’idea di “ostensione” che sottostà ad ogni suo lavoro, che sia dipinto o che sia scultura. In Bacon invece questi echi sacrali sono a volte negli stessi soggetti. Ma più intimamente li ritroviamo nella concezione del quadro come pala d’altare, quindi sempre verticale, con lo spazio che spesso si apre all’interno seguendo la curvatura di un’abside. E la pala tanta volte si trasforma addirittura in trittico, dove la dimensione religiosa si palesa come scandalo, come oltraggio. Al centro, nel posto che dovrebbe essere dell’altare, si compie sempre un qualcosa che è difficile non definire altro che un sacrificio… Se un appunto si può fare alla mostra di Basilea è forse questo: è mancato il coraggio di rendere esplicito questo tema del rapporto con l’immaginario del cattolicesimo (Bacon teneva nello studio il Crocefisso di Cimabue e mise del suo senza farlo sapere per il restauro di quello “ferito” dall’alluvione di Firenze: qui la stupenda storia).

C’è anche un aspetto che emerge nella mostra e che commuove. Ed è quel loro attaccamento, che non conosce di fatto eccezioni, alla figura umana. Sono due giganti che non si sottraggono mai a questo loro destino di testimoniare, rappresentandola, la condizione dell’uomo del loro tempo. In genere si legge questo come una dinamica ossessiva, centripeta, che quindi riguarda solo loro stessi e i loro tormenti. In realtà – e oggi lo si percepisce ancora meglio – sono come risucchiati da una necessità che li trapassa e travalica. Dire che la loro opera ci riguarda può sembrare una banalità. Dire che la loro opera è fatta per noi, nel senso sollecita un sentimento più intenso della vita, è un po’ meno una banalità. Che in Giacometti non ci sia narcisismo è palese: è uno che come le sue sculture, a furia di ridurle, vorrebbe sparire. In Bacon si può pensare che sia diverso, perché la sua pittura a volte tradisce un furioso compiacimento, nella teatralità della costruzione dei quadri, nell’uso così spinto dei colori. Ma a Bacon alla fine, questa impaginazione serve solo per permettere al quadro di precipitare in un punto che ne stabilisce la ragion d’essere. È quel punto vertiginoso in cui la pittura, anche materialmente, sembra obbedire ad una sorta di risucchio, come si esponesse sulla sponda del dramma e del mistero.

Ultima osservazione. Oggi nel vedere Bacon e Giacometti non intercettiamo “lo sporco” da cui si generavano le loro opere. Era una loro stessa strategia espositiva, in virtù della quale quando le opere uscivano dal supremo disordine dello studio, avevano bisogno di un qualcosa di esattamente contrario: la pulizia, l’ordine, la precisione delle cornici (Bacon, tutte dorate) o dei basamenti. Alla Beyeler il rito si rinnova, rispettando quella precisa volontà. Mi ricorda per analogia l’immagine del bambino lavato e reso lindo dopo la massacrante fatica del parto…
Sono illuminanti al proposito le parole di Francis Bacon nell’intervista a Michael Archimbaud: «La cornice è una cosa artificiale, e viene messa apposta per rafforzare l’aspetto artificiale della pittura. Più l’artificio delle tele che si realizzano è evidente, più vale questa consuetudine e più la tela ha possibilità di funzionare, di mostrare qualcosa. Può sembrare paradossale, ma in arte è un fatto indubitabile: si raggiunge uno scopo attraverso l’impiego massimo di artificio, e si riesce a creare qualcosa di autentico quanto più l’artifico è evidente».